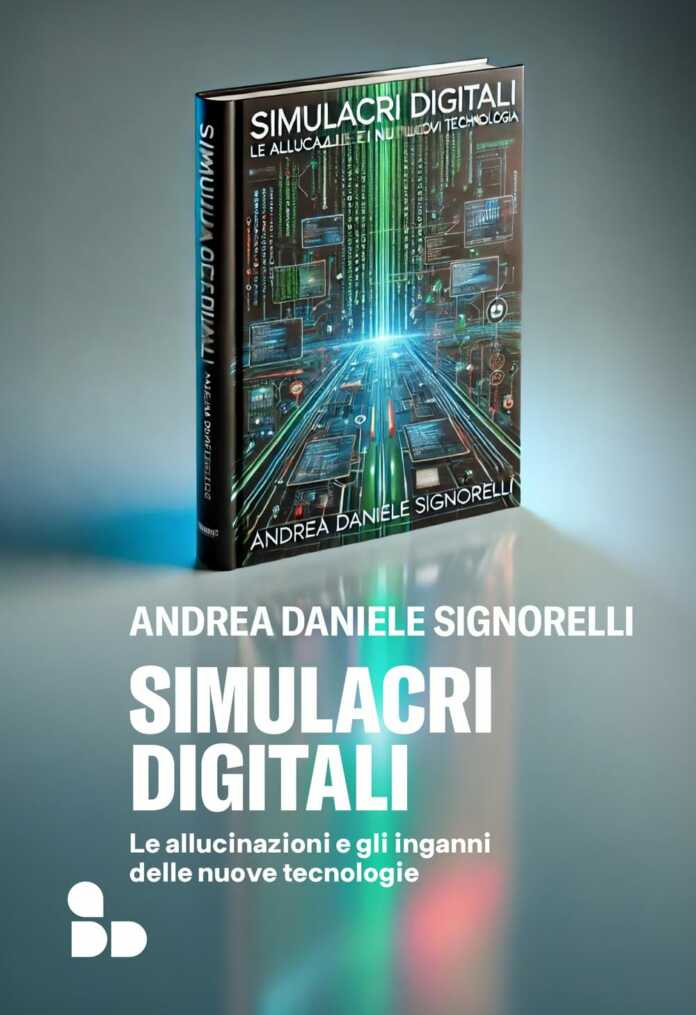Nel clima turbolento e cinico del Trump 2.0, Silicon Valley è diventata Big Tech. Gettata la maschera un po’ cascante del tecno-progressismo, Google e soci si sono calati l’elmetto, sempre più accomodanti con un comparto militare che ha trovato in un Peter Thiel il nuovo dominus della palude politica americana. Andrea Daniele Signorelli è un giornalista esperto che su testate come “Wired”, “il Tascabile” e “Domani” segue da vicino la scena dell’innovazione tecnologica e le cronache auto-incensanti della sua narrazione. Da questa fabula prende le mosse anche Simulacri digitali, che, per capirsi, non è l’ennesimo agile volumetto per chi vuole capire se le IA generative miglioreranno la sua esistenza o, al contrario, la condurranno verso una anticipata estinzione; va letto piuttosto come una riflessione allargata non solo alla tecnologia ma all’evoluzione del suo storytelling.
L’autore scomoda dalle prime pagine Jean Baudrillard e una delle sue più note concettualizzazioni, quella di “Simulacra” – evocata entusiasticamente benché approssimativamente anche dal classico cinematografico Matrix – domandandosi se ai giorni nostri il trionfo del capitalismo digitale l’abbia poi effettivamente realizzata. Se, in altre parole, la tecno – narrazione possa oggi non solo rappresentare, in modo più o meno interessato la propria offerta, modulando le nostre aspettative, ma anche generare ipso facto, dal nulla, la realtà stessa che volenti o nolenti siamo indotti a condividere. Cercandone una controprova, e limitandosi all’ultimo decennio, non sono certo mancati gli esempi di ciò che in un passato non troppo remoto veniva stigmatizzato come “vaporware”: annunci di prodotti rivoluzionari e di un futuro annunciato ma mai realmente pervenuto, con cui Silicon Valley ha superato alcuni suoi momenti di impasse, liberando la corsa degli investitori grazie a tecnoutopie miliardarie, rivelatesi nel tempo dei colossali fallimenti.
Tra queste un posto d’onore spetta alle auto autonome, annunciate a più riprese da colossi come Google e Tesla e sempre a un passo dalla consegna, ma anche il mitico Web3, la rete di contenuti e servizi totalmente decentrata e abilitata dalla blockchain che avrebbe dovuto restituire ai comuni mortali il controllo del Web (e dei propri dati personali), sottratto da tecno-oligarchi come Mark Zuckerberg. Proprio al padrone di Facebook risale anche il più incredibile azzardo di marketing del decennio, quello del cosiddetto “Metaverso”, un termine ombrello pescato dal museo cyberpunk che, mettendo disinvoltamente assieme giochi come Fortnite e altri shooter immersivi come Overwatch o Apex Legend con una nuova generazione di dispositivi come Oculus VR, ha ipotizzato che, grazie anche alla spinta claustrofobica dei lockdown, avremmo preferito partecipare a un meeting o fare la spesa in Realtà Virtuale anziché nel più familiare combo “online + offline”. Un flop annunciato in cui Signorelli ravvisa lucidamente anche un significativo distacco – e un madornale errore strategico di Facebook – dalla tendenza dominante che, sovrapponendo e ibridando sempre più strettamente l’esperienza digitale con la realtà fisica, si è affermata con successo negli ultimi tre decenni con la rete mobile, Google Map, gli smartphone, gli smartwatch: una linea evolutiva precisa, che nel prossimo futuro potrebbe, almeno in linea di principio, convergere invece con il trend – finora scarsamente gettonato – della Realtà Aumentata.
Un discorso a parte riguarda naturalmente l’intelligenza artificiale generativa e l’exploit dei modelli linguistici che utilizzano reti neurali avanzate, entrati nella nostra routine quotidiana attraverso piattaforme chatbot come Gemini o Chat GPT. Il saggio analizza in particolare come il desiderio inconscio di abitare in senso antropomorfo anche il rapporto strumentale con comuni oggetti quotidiani – la nostra auto, ecc. – nella vicenda pratica della cibernetica abbia portato il campione umano a instaurare relazioni di “intimità”, anche con generazioni di bot assai più primitive della attuale. Un impulso che sembra controbilanciare, per altri versi, la crescente robotizzazione delle posture umane e dei nostri gesti quotidiani nei contesti professionali e lavorativi del neocapitalismo.
Per Signorelli si rivelano narrazioni entrambe smaccatamente interessate sia lo stucchevole ottimismo alla Marc Andersen, associato all’avvento delle IA, sia, all’estremo opposto, il pessimismo apocalittico di un filosofo come Nick Bostrom che tende a dipingerlo, per contro, come una “minaccia esistenziale”, alla Skynet, per la nostra specie. Come dimostrerebbe la parabola dello stesso Elon Musk – passato in pochi anni dai sermoni sulle IA cattive al lancio di Grok, il chatbot sboccato e senza filtri di X – gli estremi del discorso tendono oggi a convergere nel concreto interesse di una superclasse privilegiata che, grazie a una concentrazione finanziaria senza precedenti, ammicca sempre più apertamente a un ideale di società tecno-feudale. Un ceto di intoccabili che dietro a una confusa escatologia, fluttuante tra la galassia transumanista e l’altruismo “Long Term”, si è autonominato a decidere cosa sarà dell’innovazione tecnologica anche per conto del futuro genere (post) umano.