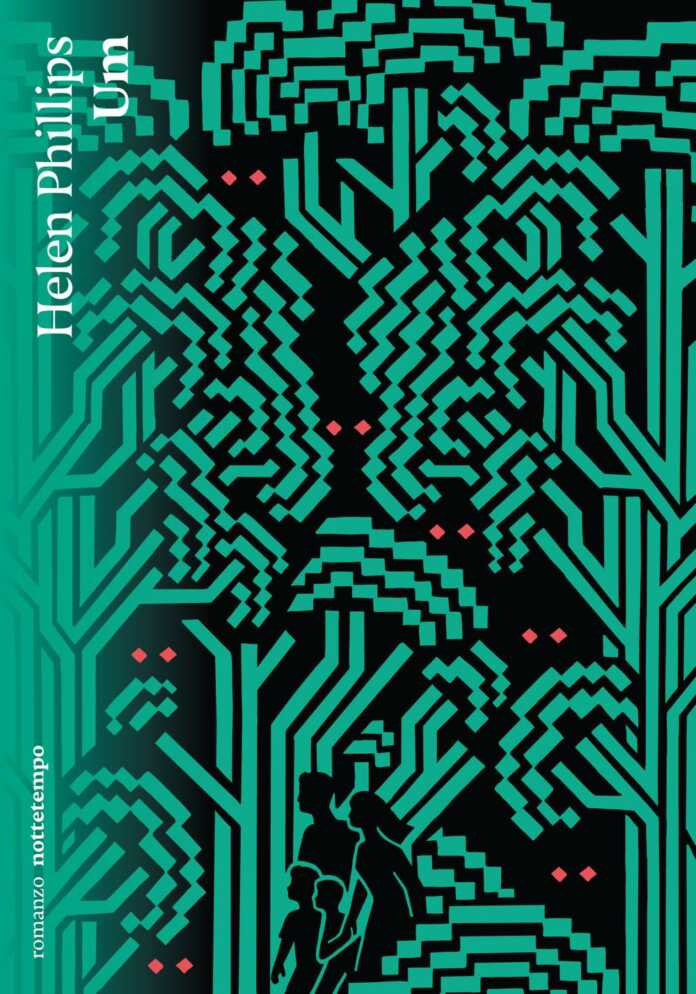La famiglia di May fa fatica ad arrivare a fine mese. Le spese sono tante, troppe per le scarse entrate precarie che lei e il marito Jem riescono a racimolare con quei pochi lavoretti saltuari che si procurano con piattaforme di gig economy. Per questo May fa un grosso sacrificio. Un sacrificio ben pagato ma folle. Sceglie infatti di sottoporsi a una procedura chirurgica che modificherà per sempre le fattezze del suo viso. La esegue uno Um, uno dei tanti androidi con una IA avanzata quanto intrisa di esigenze commerciali che permeano la società contemporanea. May si ritrova con un bel gruzzolo in mano e decide di godersela un po’, di regalare a Jem e ai loro figli, Sy e Lu, una vacanza di lusso in un giardino botanico. Unica regola: tutti i membri della famiglia dovranno separarsi dai loro devices e passare quei pochi giorni completamente disconnessi. La scelta è sofferta ma sembra portare i suoi frutti, fino a quando i bambini non si perdono e, per recuperarli, May si dovrà fare una scelta dalle conseguenze devastanti.
Già con il suo La bella burocrate, pubblicato quasi un decennio fa da Safarà Editore, Helen Phillips si è dimostrata un’autrice capace e con una poetica profondamente personale, in grado di mettere in campo una scrittura di genere solida con un taglio intimista che tuttavia non scade nella letteratura ombelicale schiacciata dall’ipertrofia dell’interiorità. Qui la riflessione filosofica sul futuro, per quanto prossimo e molto vicino alle dinamiche del presente, c’è e il peso enorme dell’approfondimento psicologico è un valore aggiunto che ancora i concetti nel reale. Già la scelta del nome Um, deliberatamente associato all’Om con tutto il suo portato metafisico, è una dichiarazione d’intenti forte e sintetica che, con poche frasi, esprime la pervasività della tecnologia molto più delle lunghe descrizioni scenografiche che caratterizzano tanta fantascienza con velleità sociali e tanto bisogno di farlo sapere al lettore nel modo più didascalico possibile.
In Um i riferimenti sono immediati e familiari, il domani è letteralmente domani e l’identificazione del lettore è istantanea, ci si orienta subito in un futuro che è riconoscibile ed è proprio questo a renderlo inquietante. May e la sua famiglia sono infatti consci, a un livello puramente logico, delle proprie dipendenze dall’iperconnessione costante di device che di fatto sono estensioni della nostra dimensione esistenziale ma, non di meno, non sono granché interessati a separarsene, tutt’altro, addirittura i suoi bambini si chiedono, quando la madre li separa dai loro dispositivi, perché lei abbia strappato loro i polsi. L’ambiente in cui prosperare, in senso evolutivo, è quello della rete e delle piattaforme, in contrasto netto e deliberato con una natura ormai ridotta ad ambientazione esotica per vacanze di lusso che chi è nato nell’epoca del lavoro precario non si può permettere salvo casi eccezionali come quello di May. Ed è proprio questa natura digitale a ricordare ai protagonisti la propria primaria importanza, il proprio status di ambiente in cui sopravvivere quando una shitstorm inaudita li colpisce in pieno devastando le loro vite social che sono più vere del vero.
I temi ci sono tutti nella scrittura di Phillips, ci sono le domande attuali e sono lì da vedere, mai negate ma nemmeno sbandierate. Basta leggere non troppo tra le righe, un po’ di attenzione è più che sufficiente per prendere in mano tutti i fili concettuali che tessono l’impianto del libro, ivi compreso il cambiamento climatico che qui non è urlato ma che, non di meno, fa parte di un mondo futuro presente descritto non da una prospettiva a volo d’uccello ma da una visione in soggettiva altrettanto efficace che si focalizza non sui massimi sistemi ma sui loro effetti sul quotidiano in un’accezione onesta di “il personale è politico”, vera nella misura in cui il primo è il prodotto del secondo che ci piaccia o meno.