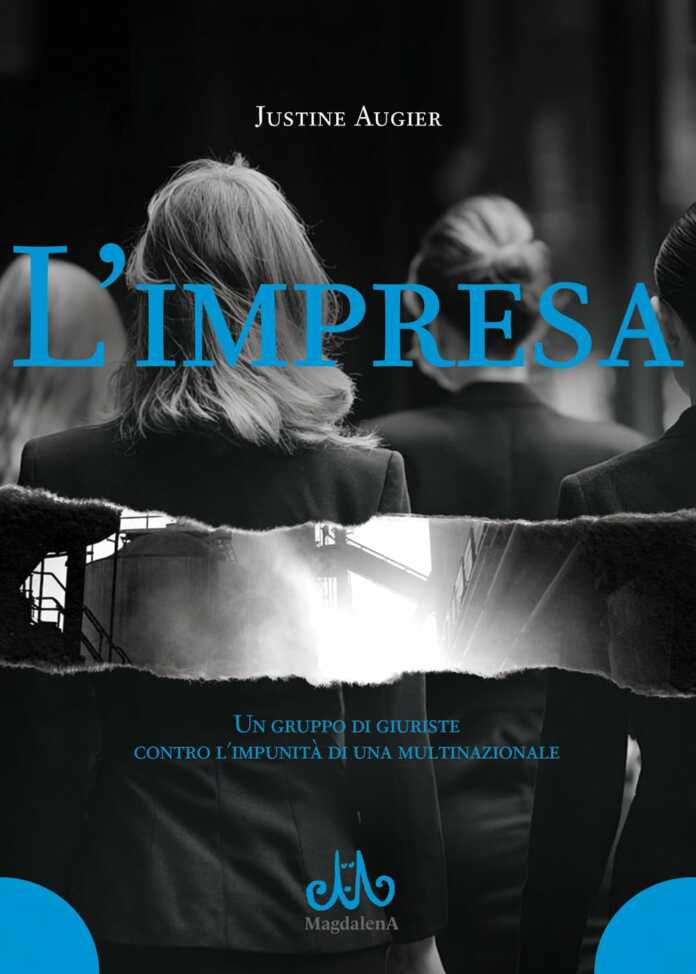Nel giugno 2016, in una Parigi segnata dalle grandi proteste contro la riforma del lavoro e dove i militari continuano a pattugliare le strade in seguito agli attentati terroristici al Bataclan, una stagista dell’associazione Sherpa – organizzazione che si occupa di combattere l’impunità legata alla globalizzazione degli scambi economici e finanziari e di difendere le vittime di crimini economici – legge un articolo che racconta come il cementificio francese Lafarge, il cui impianto si trova nel mezzo del deserto siriano, abbia finanziato l’ISIS perché non si rischiasse d’interrompere il funzionamento di questo suo stabilimento durante la guerra civile.
La storia narrata da Justine Augier è quella di un gruppo di donne, giuriste e avvocate, che decidono di intraprendere una battaglia legale senza precedenti, sfidando in tribunale una delle più grandi multinazionali francesi – la Lafarge, appunto – per aver finanziato gruppi jihādisti, distribuendo a bande armate ingenti somme di denaro affinché materiali, dipendenti e manovalanza potessero muoversi tranquillamente in un territorio dilaniato dalla guerra e da crimini per lungo tempo ignorati dal mondo.
«Non posso farci niente», dice l’autrice, «se questa storia conta solo donne e se queste donne si trovano ad affrontare persone che sono quasi tutti uomini, dal cementificio siriano di Jalabiya, alla sede di rue Belles-Feuilles nel sedicesimo arrondissement di Parigi, fino ai grandi studi legali coinvolti. Non posso fare a meno di notare l’aspetto caricaturale di questa storia, ma non posso fare a meno di pensare che non sia priva di significato».
È una storia di donne che, di fronte a fatti gravissimi, non si limitano a scandalizzarsi o a farsi schiacciare dal senso di impotenza che a volte porta a dimenticare le cose sgradite il più in fretta possibile. È la storia di chi guarda dritto negli occhi ciò che non sarebbe mai dovuto accadere e si confronta con un sistema che ha permesso a una grande impresa europea di trasferire denaro a un’organizzazione terroristica. È la storia di chi vuole rompere con l’accettazione silenziosa di un meccanismo di stampo capitalista che permette alle multinazionali di dettare le regole del gioco, di chi non teme di disturbare un sistema in cui talvolta anche chi lo ritiene ingiusto preferisce non cambiarlo perché conosciuto e, in qualche modo, ritenuto rassicurante. È la storia di chi conosce bene il diritto e che si rende conto che la denuncia contro il cementificio potrebbe anche andare oltre l’accusa di finanziamento al terrorismo, che si potrebbe configurare il concorso in un reato ancora più grave, quello di crimini contro l’umanità.
La lotta delle giovani donne si concentra sull’idea di chiamare la multinazionale a rispondere come persona giuridica per i crimini commessi all’estero, un concetto giuridico innovativo e di grande impatto simbolico, puntando il dito contro la questione cruciale dell’impunità delle grandi aziende, intravedendo la possibilità di ritenerle responsabili penalmente e diventando così, finalmente, giudicabili come qualunque altro soggetto. Spesso aziende come Lafarge architettano la loro impunità attraverso strutture societarie complesse, separandosi da quelle che sono le loro stesse catene di produzione, creando holding e filiali, ricorrendo a subappaltatori e tessendo un velo giuridico che rende facile nascondere le responsabilità. Con un coraggio che non ci si aspetterebbe da persone così giovani e con molto da perdere, le giuriste decidono di accettare questa sfida e per sostenere l’impianto accusatorio ascoltano i vertici della Lafarge e, soprattutto, i dipendenti siriani la cui vita è stata quotidianamente messa a rischio per gli spostamenti continui su un territorio pericolosissimo e sottoposti a condizioni di lavoro inumane.
In principio – benché gli operai lavorino dieci ore al giorno, escluse le lunghe ore di trasporto per arrivare dalle abitazioni al cementificio e viceversa – il salario è buono, decisamente migliore rispetto ad altre zone; non solo, firmare un contratto di lavoro con un gruppo internazionale impressiona molti di loro, anche per via del codice di condotta etica cui si ispira l’azienda: la fabbrica è così moderna e promettente che la Banca Europea per gli investimenti nel 2011 le conferisce il premio per il miglior progetto industriale dell’anno in Medio Oriente. Ma ben presto la situazione degenera. Mentre la situazione in Siria viene descritta dai vertici aziendali come “molto complicata e in via di evoluzione”, i racconti dei lavoratori del cementificio parlano di centinaia di migliaia di morti e dispersi, di torture, rivoluzionari massacrati, bombardamenti, città assediate, bambini che muoiono di fame, radicalizzazione dei gruppi di opposizione al regime, donne yazide ridotte in schiavitù e giornalisti decapitati.
Nonostante il sistema delle “donazioni” in denaro ai terroristi, non si contano le storie di camion bloccati sulle strade, dipendenti controllati con violenza nei numerosi checkpoint che costellano il territorio vicino all’impianto e che arrivano terrorizzati in fabbrica dove nessuno li ascolta e in cui devono adempiere alle mansioni cui sono stati assegnati senza sosta e senza sostegno alcuno. Così come non si contano gli impiegati attaccati e rapiti nel tragitto per arrivare al lavoro e che subiscono violenze di ogni tipo prima di venire liberati a seguito di un riscatto versato dall’azienda. Non è di certo una vita lavorativa compatibile con la dignità umana eppure, mentre alcuni dipendenti stranieri lasciano il sito produttivo, i dipendenti siriani sono abbandonati a loro stessi e devono lavorare più duramente di prima per compensare l’assenza di chi, vista la situazione, viene rimpatriato.
È vergognosa la distanza tra il linguaggio utilizzato dai dirigenti della Lafarge e il contesto di violenza in cui vivono i loro dipendenti: in tutti i verbali dei comitati di sicurezza del cementificio non appare mai la parola guerra – è un’idea folle quella che domina i dirigenti della filiale per cui non parlarne significa tenere lontano dal cementificio ciò che sta incendiando il paese. Altra follia linguistica della multinazionale è quella di usare termini come racket, obolo, decima o malversazione per indicare soldi versati a terroristi responsabili di crimini che hanno gravemente colpito anche la Francia, e non di parlare chiaramente di finanziamenti a Daesh, nonostante la cifra di denaro sborsata ai jihādisti ammonti a oltre dodici milioni di euro. È così, nulla smuove certi imprenditori: molti di loro, di fronte alle conseguenze nefaste delle loro operazioni, si sono trincerati dietro al fatto d’aver dato lavoro a migliaia di persone.
Per rispondere alla domanda se dare lavoro, così come la Lafarge ha fatto per migliaia di famiglie, giustifichi ogni tipo di abuso e la totale indifferenza verso la vita umana, Augier porta altre testimonianze. La multinazionale mineraria Vale costruì in Brasile una diga destinata a contenere acque inquinate, residui minerari e rifiuti ultra-tossici. La diga cedette e duecento settantadue persone morirono “travolte e schiacciate da una gigantesca colata di un colore rosa orribile e irreale”. Dalle indagini si venne a sapere che la Vale conosceva quanto sarebbe costato il crollo della diga in termini di risarcimenti, quanto sarebbe costata smantellarla e, preso atto della spesa più economica, fu presa la decisione di mantenerla in piedi. Non solo, quando dopo il disastro mancavano all’appello ancora tre corpi, alcuni dipendenti della ditta andarono dagli abitanti della zona le cui case erano minacciate da altre dighe minerarie, per distribuire loro chip GPS così da limitare i costi per la ricerca dei corpi la prossima volta che un fatto simile si fosse verificato.
La scrittrice ci ricorda che mentre centinaia di migliaia di bambini, donne e uomini venivano sistematicamente massacrati in Ruanda – nelle loro case, nei villaggi, nelle chiese o su colline che speravano potessero essere rifugi sicuri –, la banca francese BNP avrebbe autorizzato importanti trasferimenti di denaro, di fondi che provenivano dalla Banca del Ruanda ospitata proprio dalla BNP, destinato a un noto trafficante d’armi sudafricano. Tale transazione sarebbe avvenuta alla vigilia di una vendita che il trafficante concluse alle Seychelles con un colonnello dell’esercito ruandese. Altre banche avevano rifiutato l’autorizzazione a simili operazioni, ma la BNP le avrebbe approvate.
Come altro esempio della voracità del capitalismo, leggiamo che nel 2013 in Bangladesh, nella periferia di Dhaka, un edificio che ospitava diverse fabbriche tessili è improvvisamente crollato schiacciando e seppellendo più di millecento persone, sia i lavoratori sia i loro figli che li seguivano sul posto di lavoro in modo che i genitori non avessero impedimenti nel confezionare gli abiti commissionati da subappaltatori di grandi gruppi europei, i cui nomi sono stati trovati sulle etichette sparse tra le macerie, come Auchan, C&A e Camaïeu – marchi diventati improvvisamente macabri.
Questa sorta di romanzo-inchiesta che travalica i confini del semplice reportage, ci riconcilia almeno in parte anche con la giustizia. In un mondo in cui siamo abituati a leggi ad personam o a vedere sempre sul banco dei vincitori il più forte, Augier ci ricorda l’esistenza di un modo di sentir la legge che, quando ben conosciuta e correttamente applicata e interpretata, può sovvertire i rapporti di forza: «Tutte smettono di parlare quando iniziano a vedere arrivare gli avvocati della Lafarge in tribunale, con abiti ognuno dei quali deve valere più di un mese dei nostri stipendi. Per diversi minuti, escono uno dopo l’altro dalle loro berline con i vetri scuri e li abbiamo contati: erano diciannove, tutti uomini. Gli avvocati dell’azienda e i suoi dirigenti, avvocati dietro i quali decine di collaboratori e stagisti contribuiscono a ogni fase, producendo documenti, osservazioni, richieste di atti e ricorsi per nullità; forze considerevoli».
Con L’impresa, Augier – oltre a dirci che scrivere può essere un atto di resistenza, responsabilità civile – propone un testo particolare e stimolante, capace di far parlare i fatti, che si muove con naturalezza tra riflessione filosofica, analisi sociale e racconto dell’esperienza contemporanea del lavoro, muovendosi in un contesto storico segnato da crisi economiche, ridefinizioni del lavoro e interrogativi sul futuro.