In un’America distopica, il Maggiore governa il paese col pugno di ferro. Le squadre, il suo braccio armato, fanno sparire i dissidenti che osano esprimersi a voce troppo alta. La forma di intrattenimento più popolare negli Stati Uniti controllati dal Maggiore è una marcia che ogni anno vede cento ragazzi camminare dal confine con il Canada fino a dove i loro corpi riescono a portarli. Non sono previste pause di alcun tipo fino alla fine della competizione. Chi si ferma riceve un avvertimento. Chi scende sotto la velocità stabilita dal regolamento riceve un avvertimento. Chi commette un’infrazione riceve un avvertimento. Dopo il terzo avvertimento si viene fucilati sul posto dai soldati che seguono i marciatori a bordo dei mezzi corazzati. La partecipazione è facoltativa, il vincitore riceverà tutto quel che desidera per il resto della propria vita. Il premio alletta molti dei ragazzi che partecipano sperando di vincere in qualità di ultimo sopravvissuto. Altri partecipano per ragioni tutte loro. Ciò di cui nessuno si rende conto è della trappola spaventosa in cui si sta andando a cacciare con le proprie mani.
In un’altra America non meno distopica e governata da un regime altrettanto autoritario, Ben Richards è un disoccupato senza un soldo la cui moglie si prostituisce per guadagnare qualche soldo per tentare di curare la figlia malata. Per tentare di cambiare il destino della piccola, Ben si reca alla Federazione Giochi, un ente che produce competizioni trasmesse in TV in cui i poveri come lui partecipano a programmi in cui mettono a rischio la propria salute per soldi. Lui non punta ai giochi pericolosi ma fattibili come il Macinadollari. Lui punta alla gara più estrema, quella da cui nessuno finora è uscito vivo. L’uomo in fuga, una caccia all’uomo che frutta al fuggitivo un pozzo di soldi a patto di sopravvivere trenta giorni di fila braccato dall’America intera: dai poliziotti ai cittadini comuni, o peggio ancora dai Cacciatori, una squadra specializzata alla guida dello spietato Evan McCone. L’uomo in fuga non serve solo a intrattenere, aiuta il governo a liberarsi di potenziali sovversivi pericolosi. Ma Ben Richards, con il suo acume e con la sua rabbia dirompente, potrebbe dimostrarsi più pericoloso del previsto.
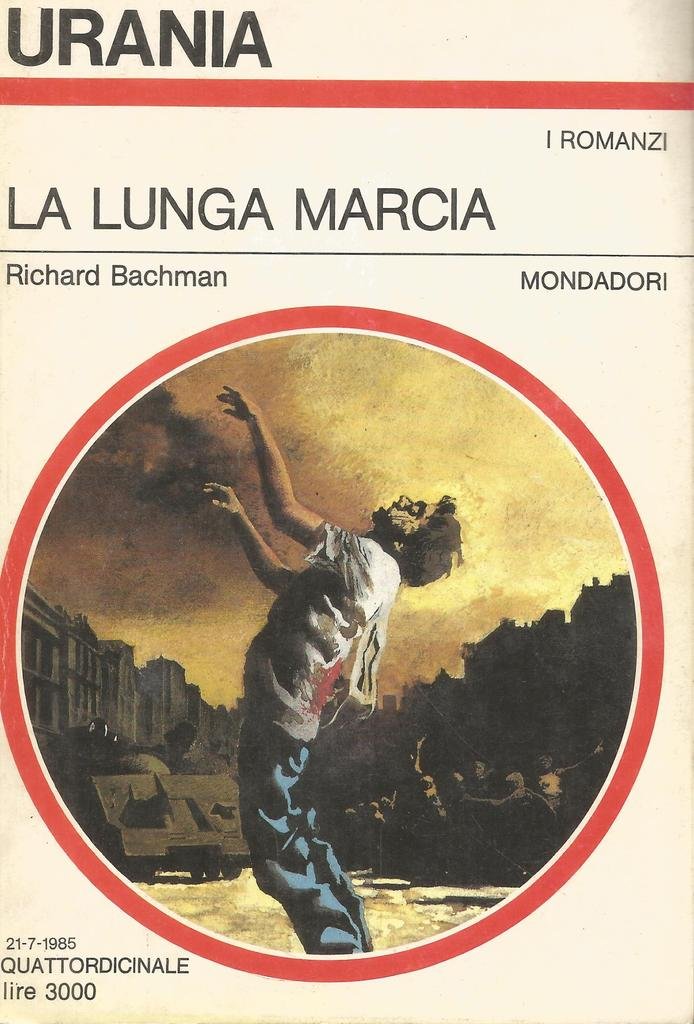
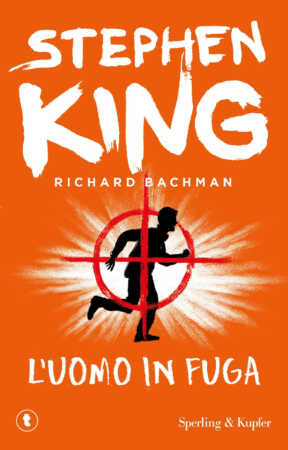
La lunga marcia, la prima opera scritta (anche se non la prima pubblicata) da Stephen King e L’uomo in fuga fanno parte dei Bachman Books, una serie di libri che il Re scrisse, insieme a Ossessione, Uscita per l’inferno e L’occhio del male, sotto lo pseudonimo di Richard Bachman un po’ per gioco e un po’ per sfida, in sintesi per rendersi conto di quanto il suo nome pesasse realmente nel determinare il successo dei suoi libri e quanto esso fosse dovuto alla loro qualità. Di tutta la sterminata produzione di King, i libri scritti come Bachman sono forse i più politici e fra di essi La lunga marcia e L’uomo in fuga si distinguono per una critica particolarmente dura, diretta e rabbiosa. Proprio in questi mesi è prevista l’uscita nelle sale cinematografiche di due pellicole tratte da queste due opere. Ora, il rapporto fra i libri di King e i loro adattamenti per il grande schermo è come minimo complicato, nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte a risultati mediocri a voler essere generosi, eccezion fatta per opere come Shining (1980) di Kubrick, e in tal senso sono ancora i due libri sopra citati a distinguersi. Se l’idea di portare nelle sale cinematografiche La lunga marcia ha infatti parecchi anni e altrettante false partenze sulle spalle, L’uomo in fuga ha generato un adattamento, conosciuto in Italia con il titolo L’implacabile (1987), su cui sarebbe forse meglio soprassedere, un film sci fi d’azione con Schwarzenegger che è pure divertente ma che con il libro di King non ha nulla a che vedere. Al di là del comprensibile hype da parte dei fan del re, fomentato almeno nel caso di La lunga marcia da un paio di trailer che promettono i fochi d’artificio, è interessante come proprio oggi questi due libri così attuali siano finalmente diventati due film e, soprattutto, è interessante capire cosa li rende così inquietantemente contemporanei.
Il primo aspetto difficile da non notare è che le due opere sono due modi completamente diversi di raccontare fondamentalmente la stessa storia. La narrazione è la medesima: in un’America controllata da un regime autoritario il protagonista sceglie liberamente di partecipare a un gioco che illude di poter cambiare la propria vita ma che, nella realtà dei fatti, è un tritacarne da cui non è possibile uscire vivi. Quindi, gli elementi fondamentali sono tre: il regime autoritario, il ruolo e le modalità dell’intrattenimento e la chiave di volta, la libera scelta.
Partiamo dall’ambientazione. A metterli insieme tutti e due, i world building dei due libri per quanto accennati ci restituiscono una fotografia sinistramente precisa del nostro presente, contando che sono stati pubblicati fra il 1979 e il 1982. Il regime autoritario del Maggiore, in La lunga marcia, è poco più che accennato ma le poche parole con cui è tratteggiato sono di una sintesi efficace che fornisce tutte le informazioni necessarie. C’è la figura carismatica, c’è la repressione del consenso strisciante ma presene, c’è un consenso generalizzato derivante dal culto della personalità. L’uomo in fuga racconta fa forbice fra le classi sociali, con le sue differenze sempre più chiare, accentuate e apertamente giustificate con una borghesia che non fa nemmeno finta di non disprezzarli, i poveri. L’ambientazione qui è più delineata, dickensiana ma in pieno bad trip di quelli pesanti con la gente comune che è tornata ad avere la sussistenza economica e la sopravvivenza tout court come problemi principali dagli esiti niente affatto garantiti.
Quanto all’intrattenimento, entrambi i libri raccontano di una nazione che segue assiduamente un gioco al massacro nel senso letterale, basato su una morte violenta in qualche modo catartica e attesa da un pubblico acclamante. Qui si vede la maggior complessità della struttura di L’uomo in fuga: il libro è dinamico, pieno di eventi e di rovesciamenti di fronte rapidi e improvvisi, giocato su una tensione costruita a strappi, a scatti di adrenalina che si alternano a seppur brevi momenti dove il protagonista riesce a riprendere fiato. Il parallelismo con i gladiatori è più scoperto, il ruolo dei media è più invadente e la sete di sangue della folla più urlata per quanto ci sia dello spazio per alleati che aiutano Ben Richards soprattutto come atto di resistenza dettata da un barlume di coscienza di classe, non a caso il consiglio che riceve da uno degli antagonisti è: stai con la tua gente. La lunga marcia, nella sua costruzione maggiormente lineare, costruisce la narrazione su una trappola che all’inizio del romanzo si chiude sui protagonisti e non li lascia più uscire, un meccanismo di tortura lento e inarrestabile da cui le vie d’uscita semplicemente non esistono. Si può solo camminare e morire, anzi, camminare e poi morire. Il ruolo dei media è meno invadente perché il Maggiore è un dittatore vecchio stampo, di quelli che ancora andavano di moda all’epoca per esempio in Sud America, con il loro amore per le piazze e per le parate. Il pubblico qui non guarda il gioco davanti alla TV (anzi, alla tri-vu) come ne L’uomo in fuga, qui le famiglie si sistemano a bordo strada cercando un punto di osservazione ottimale. In entrambi i casi, l’intrattenimento basato sulla sofferenza fisica e sulla morte svolge la fondamentale funzione di collante della società, uno sfogo per persone a cui è stata portata via la possibilità di una vita dignitosa.
L’ultimo, drammatico elemento che rende La lunga marcia e L’uomo in fuga è la scelta, o l’illusione della stessa. Nessuno costringe i partecipanti ai giochi a iscriversi. Lo decidono loro, di loro spontanea volontà. O almeno credono. Certo, l’atto di espressione del consenso è deliberato, non estorto, ma nel migliore dei casi sono guidati da una pulsione di morte indotta dal mondo in cui vivono, quando non è direttamente il bisogno a guidare la loro mano alla compilazione dei documenti necessari. Se le motivazioni di Ben Richards sono chiare, ha bisogno dei soldi per le cure di sua figlia, Ray Garraty non lo sa nemmeno perché si è iscritto alla marcia, forse c’è un motivo correlato al fatto che Squadre hanno portato via suo padre, col vizio del bere e di parlare di politica, lasciandolo solo con una madre traumatizzata e spaventata dalla propria ombra. Altri marciatori lo fanno per quella microscopica possibilità di garantire un futuro alle loro famiglie, altri sono semplicemente consapevoli di star compiendo un suicidio. Tutti, in questi due romanzi, scelgono di giocare una partita le cui possibilità di vittoria sono assurdamente basse, ma sono accecati dal premio, dall’incapacità di capire le implicazioni del loro gesto o da una voglia di morire che sa di resa allo stato delle cose. Una scelta libera sul piano formale, un po’ meno nella sostanza.
Voler indicare col ditino i parallelismi con l’epoca in cui viviamo sarebbe didascalico, gli elementi sono lì da vedere, l’ironia amara che sta dietro al tempismo che vede La lunga marcia e L’uomo in fuga de film proprio adesso è che forse non esiste un momento storico che queste due opere sono più adatte a rappresentare.



