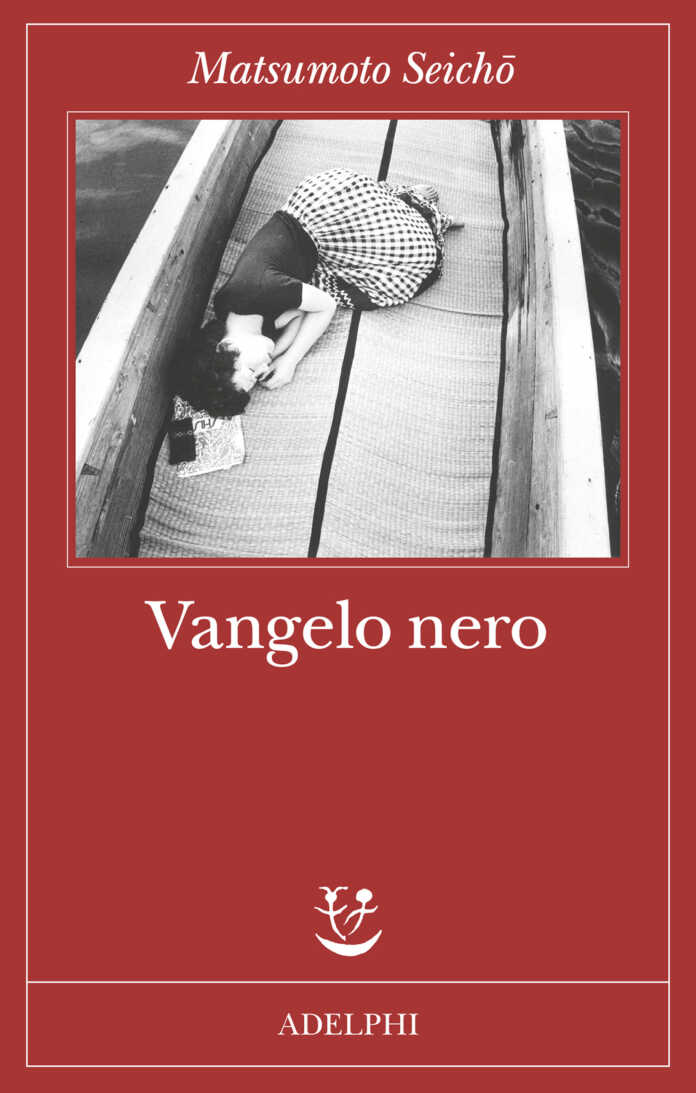Vangelo nero di Matsumoto Seichō nasce da un fatto di cronaca reale e lo trasforma in indagine sul funzionamento concreto del potere. Nel marzo del 1959 una giovane hostess giapponese viene trovata morta sulle rive di un fiume a Tokyo. Il principale sospettato è un sacerdote cattolico europeo legato a una missione straniera, che tuttavia non verrà mai arrestato né formalmente incriminato. Da questo dato noto e incompiuto Seichō costruisce un romanzo che rinuncia alla suspense per interrogare ciò che accade quando la verità è accessibile ma non praticabile.
La struttura è quella del howcatchem: il colpevole emerge presto, ma il centro del racconto è lo scarto tra accertamento dei fatti e la loro traduzione in responsabilità. Le indagini della polizia, affiancate dal lavoro ostinato di alcuni giornalisti, ricostruiscono una rete di complicità che coinvolge la Chiesa cattolica in Giappone, traffici illegali, pressioni diplomatiche e interessi politici di alto livello. Nulla, sul piano investigativo, impedirebbe di procedere. Eppure l’inchiesta si arresta. A bloccarla non è l’assenza di prove, ma una decisione politica. I livelli più alti dell’amministrazione e della polizia comprendono perfettamente le implicazioni del caso e scelgono di non arrivare fino in fondo, accettando l’idea che esistano interessi superiori rispetto all’accertamento della verità. Vangelo nero mostra con chiarezza come l’insabbiamento non sia una deviazione, ma una scelta consapevole, condivisa e giustificata. In questo passaggio compare una delle frasi più rivelatrici del romanzo, attribuita a un alto funzionario e fatta circolare come argomento ragionevole: «In fondo, è stata uccisa solo una donna». Non è una battuta cinica, ma una formula amministrativa che ridefinisce le priorità. La morte viene valutata, pesata, e giudicata insufficiente a giustificare un conflitto diplomatico o un danno d’immagine internazionale. L’omicidio non viene negato: viene reso irrilevante.
Ciò che colpisce maggiormente è che questa gerarchia delle vite non venga soltanto accettata dallo Stato e dai vertici della polizia, ma apertamente condivisa dalla Chiesa stessa. Nei colloqui riservati tra i rappresentanti dell’ordine religioso e i notabili giapponesi, l’omicidio non è mai il vero problema. La posta in gioco è la sopravvivenza dell’apparato missionario: l’arresto di un sacerdote straniero equivarrebbe alla delegittimazione dell’opera di evangelizzazione in Giappone. In questa prospettiva, la morte di una donna diventa un danno collaterale accettabile e persino necessario. Questo meccanismo si chiarisce ulteriormente alla luce del razzismo strutturale che attraversa l’istituzione religiosa nel romanzo. Seichō lo esplicita senza attenuazioni: «Sebbene molti di loro vivessero in Giappone ormai da lungo tempo per diffondere il Vangelo, non rispettavano minimamente la popolazione locale. Pensavano che i giapponesi fossero un popolo inferiore, come inferiore era la loro statura.» In questo sguardo, la missione evangelica assume i tratti di un’impresa civilizzatrice rivolta a un popolo ritenuto minore, e il disprezzo razziale diventa il presupposto silenzioso della violenza.
A questa gerarchia razziale si sovrappone una gerarchia sessuale altrettanto netta. Nel romanzo le donne giapponesi non sono soggetti, ma presenze funzionali: corpi disponibili, accessori dell’esperienza maschile e religiosa. I sacerdoti, pur vincolati formalmente al voto di castità, agiscono in zona di sostanziale impunità, in cui il desiderio non comporta responsabilità e il corpo femminile locale appare privo di tutela. La relazione con la vittima non è mai pensata come rapporto tra pari, ma come uso temporaneo e revocabile. In questo senso la sessualizzazione precede il sacrificio: se una donna è già ridotta a oggetto, la sua scomparsa può essere assorbita senza scandalo. Genere e razza agiscono così insieme. La vittima è una donna giovane, non sposata, priva di potere simbolico, ma soprattutto è una donna giapponese, collocata nel punto più basso di una gerarchia che intreccia dominio coloniale e autorità religiosa. La frase “solo una donna” non appare più come una caduta individuale di cinismo, ma come conseguenza logica di una scala di valori già interiorizzata.
La professione della vittima, hostess internazionale, accentua questa vulnerabilità. Figura mobile, esposta, desiderabile, attraversa confini senza controllarne alcuno. Proprio per questo la sua morte può essere assorbita dal sistema. Dire che è stata uccisa “solo una donna” significa affermare che quel corpo non possiede un valore politico sufficiente a giustificare uno scandalo. In questo senso Vangelo nero, per il lettore italiano, dialoga profondamente con Leonardo Sciascia. Come in Sciascia, la verità non è oscura né indecifrabile: è ricostruibile, spesso già evidente. Ciò che manca è la volontà di usarla. La giustizia si arresta davanti a una soglia che non può essere superata senza incrinare equilibri più vasti.
Scritto e pubblicato a puntate nel 1959, a ridosso di fatti ancora irrisolti, Vangelo nero appartiene a una fase decisiva del lavoro di Matsumoto Seichō, quando il romanzo smette di funzionare come dispositivo d’intrattenimento e viene deliberatamente impiegato come strumento di intervento sul presente, capace di incidere sul dibattito pubblico e di metterne in crisi le versioni ufficiali. È soprattutto nella sua prima parte un romanzo di notevole nitidezza, sostenuto da un ritmo preciso e da una chiarezza espositiva che rendono la lettura fluida e piacevole, nonostante la densità dei temi affrontati. Proprio questa trasparenza rende più netto l’esito finale: quando la verità, così chiaramente ricostruita, viene accantonata, risulta evidente che ciò che è in gioco non è l’enigma di un delitto, ma il prezzo umano necessario a mantenere intatto un ordine politico e simbolico.