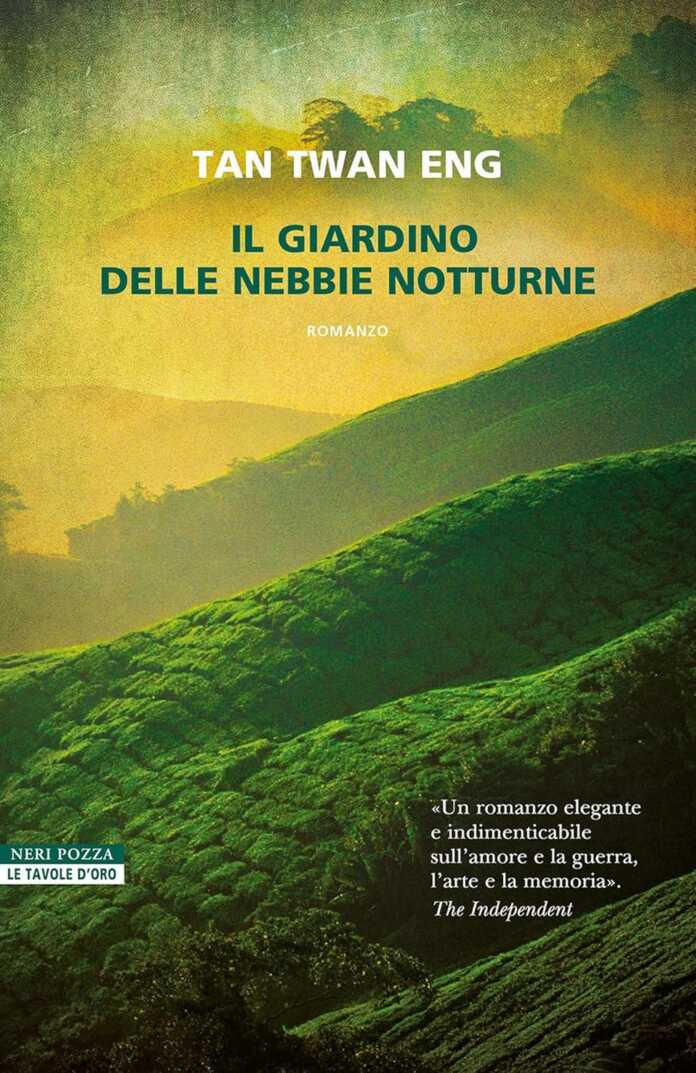Leggere la letteratura straniera è un modo appassionante e tutto sommato facile per imparare qualcosa sul mondo lontano da noi. Anche per renderci conto di quanto siamo centrati sul piccolo universo a cui apparteniamo, e quante cose non solo non conosciamo, ma non immaginiamo neppure. Il giardino delle nebbie notturne è un romanzo ambientato in Malesia. Quanti di noi la saprebbero collocare geograficamente, diciamo in cinque minuti? Senza Google Maps penso non molti. Io faccio eccezione solo perché di recente ho letto un altro libro ambientato nello stesso Paese.
Teoh Yun Ling è una donna cinese nata e cresciuta in Malesia, di famiglia colta e benestante. Durante la Seconda guerra mondiale, quando il suo paese è invaso dal Giappone, viene internata insieme alla sorella in un campo di concentramento giapponese. Dove le regole sono le stesse di qualsiasi campo: violenza, sopraffazione, fame, nello sforzo di togliere ogni dignità ai prigionieri. Il destino della sorella è quello di tutte le donne giovani e belle, diventare oggetto di trastullo per i militari e il personale del campo; così aiuta Teoh a fuggire. Di lei non si saprà più nulla, così come del campo di prigionia, scomparso come se non fosse mai esistito.
Finita la guerra, Teoh diventa un giudice ed è conosciuta e riconosciuta per la sua probità e dirittura morale. Coltiva però dentro di sé un bisogno di vendetta e rivalsa che riesce a malapena a contenere. Non può perdonare ai giapponesi il trattamento subito e soprattutto la morte della sorella. Nei cui confronti prova un senso di colpa insuperabile. Quando la incontriamo nel romanzo, Teoh ha molti anni, si è ritirata dal lavoro, ha una malattia degenerativa che le toglierà presto o tardi ogni capacità di ragionare. Decide quindi di ritornare a Yugiri, sugli altipiani di Cameron, dove nel 1951 aveva cominciato a costruire un giardino giapponese in memoria della sorella. Si era rivolta a Aritomo, il più bravo giardiniere giapponese, il giardiniere dell’imperatore, e si era trasferita a Yugiri anche per evitare che il desiderio di vendetta le impedisse di fare il suo lavoro di giudice con equità. Strana scelta, quella di un giardiniere giapponese per un giardino dedicata alla sorella uccisa in un campo di concentramento giapponese. Ma scopriremo tutto nel corso del romanzo.
Nello sforzo di fissare i ricordi sulla carta per conservarli anche quando il suo cervello non sarà più in grado di funzionare, Teoh ci porta indietro nel tempo, alla guerra e ai tumultuosi anni successivi. Anni che, in Giappone e in Malesia, come in tutto il mondo, avrebbero dovuto essere usati per delineare le responsabilità e le complicità dei massacri e delle torture inflitte ai prigionieri e ai civili; per rimettere le cose nel giusto ordine; per punire i colpevoli, risarcire le vittime, rappacificare gli stati e ricreare le condizioni per la convivenza (quanto suonano attuali queste parole, è terribile). Impossibile è però il compito di ristabilire la verità, di dare corso alla giustizia, di equilibrare punizioni e perdono. Dopo alcuni processi esemplari, anche il governo malese si era arreso a una sorta di amnistia generalizzata.
Teoh Yun Ling non riusciva ad accettare questo stato di cose. Per questo era partita per Yugiri. Dove la scelta di progettare un giardino giapponese sotto la guida di un giardiniere giapponese la costringe a fare i conti: con il passato suo e con quello di Aritomo; della Malesia e del Giappone. Perché alla fine, quando c’è di mezzo una guerra, nessuno può passare indenne. Se le vittime sono tutti quelli che sono morti, che non hanno più voce, che al massimo possono avere un momento di commemorazione o un giardino in loro nome, e se i colpevoli sono mostri che nascondono un lato buono, o semplicemente uomini e donne come noi, tutti gli altri, tutti i sopravvissuti, sono un misto di atti di coraggio e di viltà, di momenti eroici e momenti di terrore, di azioni mancate, di rimpianti, vergogne e sollievi. Gli armadi sono pieni di scheletri, e a un certo punto bisogna aprirli.
In mezzo a tutto questa complessità, avvolta spesso nella nebbia, c’è la natura. Una natura potente oltre che bellissima. Montagne e giungla, piogge e nebbie, sentieri introvabili e caverne. Una natura quasi indomabile. Rispettata per forza, per necessità. Sia Teoh Yun Ling sia Aritomo, come giardinieri in erba o esperti, hanno con questa natura un rapporto ambivalente e complesso. Se il giardino infatti è per forza una costruzione dell’uomo, quasi l’antitesi della natura, il modo in cui il giardiniere imperiale Aritomo si pone di fronte alla natura è però rispettoso e intimorito. Il giardino non è un luogo in cui ammirare la natura. È un luogo in cui meditare e riflettere, in cui pensare aiutandosi con geometrie, specchi e riflessi che vengono dalla natura, che richiamano il paesaggio circostante ma ne sono sempre ben distinti e ben separati. Una concezione della vita e di ciò che ci circonda molto diversa dalla nostra, e anche per questo fonte di meraviglia.
È un romanzo un po’ sconcertante, Il giardino delle nebbie notturne, suggestivo come il suo titolo, visionario. Che apre tante finestre sulla grandezza e sulla miseria del mondo, e sulle nostre possibilità di conoscenza. E che resta nel nostro immaginario come un piccolo mistero. Tan Twan Eng su Pulp Magazine.