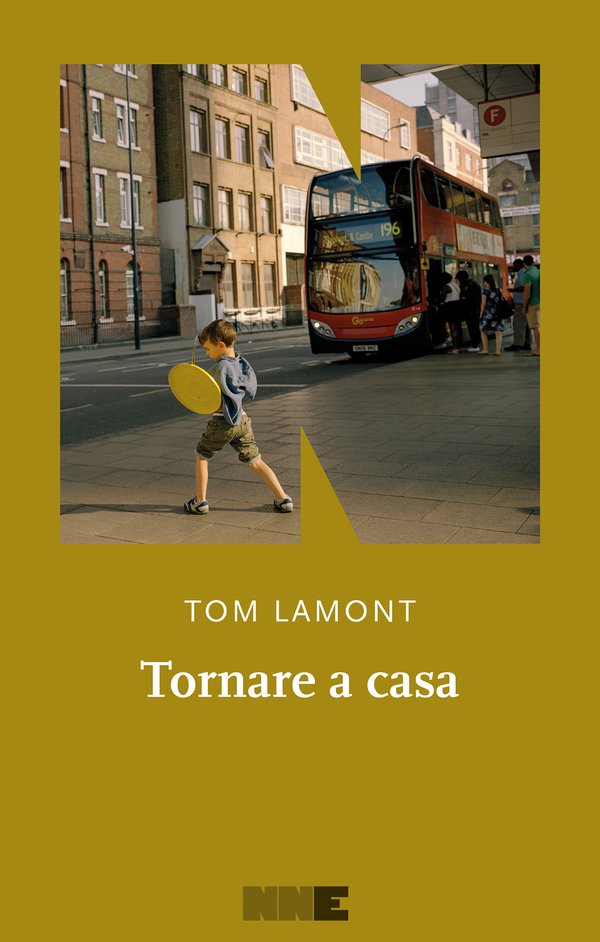Niente cambia il corso di un’esistenza quanto l’arrivo di un bambino – soprattutto quando accade per caso e non per scelta, soprattutto quando non è tuo. I protagonisti di Tom Lamont, giornalista freelance e collaboratore di “Guardian”, “Observer” e “GQ America”, scoprono (o riscoprono) le gioie e i dolori della genitorialità nel suo esordio Tornare a casa, pubblicato da NNE nella traduzione di Antonio Matera. Un racconto corale sulle vite di quattro adulti sconvolte dal piccolo Joel, finito in affidamento a Téo Erskine, un amico di giovinezza di sua madre Lia, dopo il suicidio di lei. Siamo nel sobborgo di Enfield, Inghilterra, una zona periferica che si fa vero e proprio villaggio, dove ogni abitante si conosce e si formano comitive di ragazze e ragazzi cresciuti insieme, compagni di sempre, traditi dal tempo nel suo incedere impietoso. Lo stesso luogo da cui Téo Erskine ha avuto bisogno di allontanarsi per ricominciare daccapo.
Da un lato ci sono gli adulti, nelle differenti declinazioni della loro solitudine e del loro senso di abbandono, nelle diverse sfumature delle loro paure. Téo, ormai trentenne trasferitosi a Londra, torna a casa per occuparsi del padre e ancora una volta è costretto a esplorare i suoi sentimenti per Lia, le aspettative disattese di un amore non corrisposto. Con Joel si lancia in un’atipica paternità, fatta di frustrazioni, dubbi e un coinvolgimento nuovo, attraverso cui rileggere anche il rapporto con Lia. «Per Téo era come se nella sua mente fosse stato demolito un edificio, come se un albero avesse perso tutte le foglie: lui la vedeva con maggiore chiarezza e si chiedeva perché non fosse stato altrettanto curioso in passato. Libero dall’ossessione per via del tempo e degli eventi». Accanto a lui il padre Vic, ormai anziano e malato, vede in Joel una nuova occasione di vita e riscatto, il migliore amico Ben, abituato agli agi della ricchezza, amato ma incapace di assumersi veri impegni, e la rabbina Sybil, simbolo di cambiamento nella comunità ebraica, in preda a uno smarrimento della fede.
Dall’altra parte, Joel. Lamont lo introduce nel prologo, a sancire il suo ruolo di primo piano nell’intreccio. Da bambino tra i tanti – colleziona oggetti, conosce solo una normalità condivisa con la madre – a ragazzino all’improvviso a contatto con morte e perdita, obbligato a condividere tempo e spazi con degli sconosciuti. Come un uragano spazza via ogni impasse nelle vite degli adulti, paralizzate nella resa, funge da collante. Li costringe a fare i conti con le proprie famiglie, in una qualche forma lontane: Vic vive da spatriato in una terra considerata a fatica casa; Téo non lo ha perdonato per non essere stato all’altezza delle sue aspettative di figlio; Ben è stato trascurato da genitori troppo distratti; Sybil forse non si è mai sentita fino in fondo di appartenere.
Occuparsi di Joel, tra le sfide del quotidiano e fratture ancora aperte, significa affrontare di petto la sofferenza per Lia, la fragilità di fronte al dolore. Significa prendersi la responsabilità di diventare adulti e abbracciare le persone care quando commettono errori, quando si smarriscono nei loro terrori. «E se invece la perdita della fede che aveva avvertito dopo la morte di Lia non fosse stata solo il cedimento di qualcosa, ma piuttosto un deliberato riassestamento, un piccolo intervento di Dio stesso?» si domanda Sybil. «Essere senza fede non voleva dire essere senza meta. Durante il suo lavoro aveva imparato così tante cose che potevano essere utili a qualcuno. Joel era quel qualcuno».
Lamont scrive un romanzo intimo e coinvolgente sullo splendore e sulla miseria della condizione umana, su quegli affetti destinati a durare e sulla nostra capacità inesauribile di occuparci l’uno dell’altro.