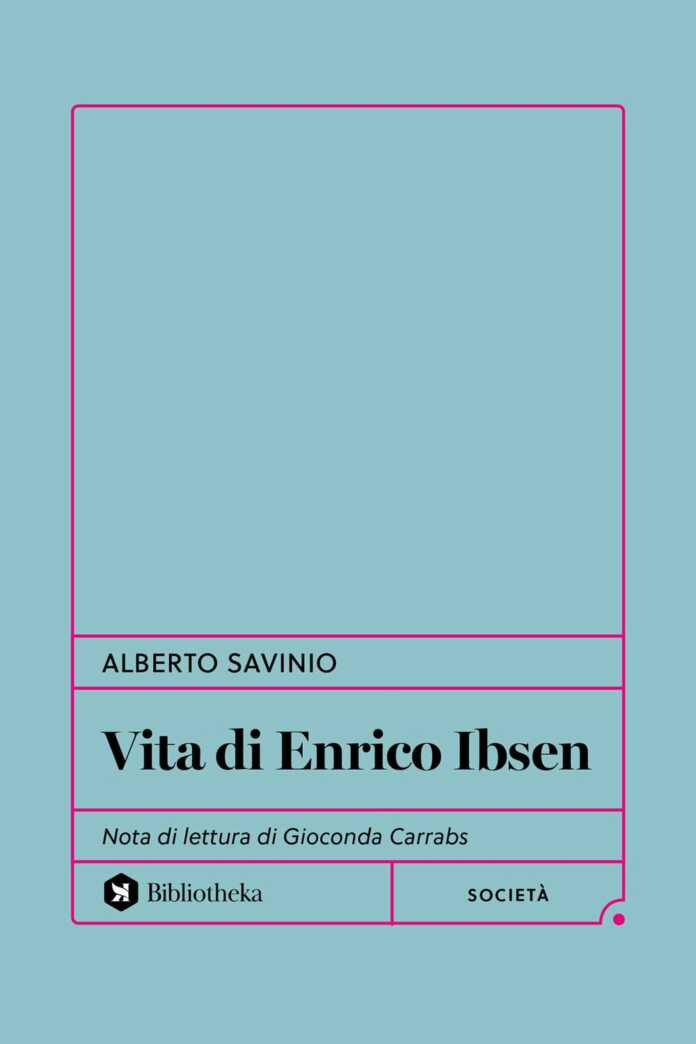Come spesso accade con i titoli di Bibliotheka, anche Vita di Enrico Ibsen di Alberto Savinio è un repêchage d’alto livello di un volume pubblicato per la prima volta da Adelphi nel 1979, corredato in questa nuova edizione da sei preziose tavole dell’autore e una puntuale e ricca introduzione di Gioconda Carrabs.
Il testo di Savinio risale al 1943, quando venne pubblicato a puntate sul periodico “Film”, e di questo tipo di pubblicazione, più che del contesto bellico, risente senza dubbio la struttura, vagamente rapsodica, del testo; d’altra parte, Savinio non è impegnato nella costruzione di una biografia in senso stretto, quando nell’indagine su una di quelle “affinità elettive” – l’espressione, ripresa da Carrabs, è di Alessandro Tinterri – che possono comporre l’albero genealogico e, allo stesso tempo, nutrire gli affetti e le passioni che attraversano la sua stessa scrittura. Interrogare la lettura di Ibsen, in altre parole, permette a Savinio di interrogare anche la propria opera, fino a ritrovare non una consonanza di temi o di stile, bensì la convinzione – da prendere con grande precauzione, a ottant’anni di distanza – di essere «femministi entrambi».
A Savinio, dunque, interessa «la parte ultima e più alta dell’opera di Ibsen», quella che per Otto Weininger e altri critici successivi, è «la parte “borghese”, minore, di rinuncia, in confronto alla plasticità orgogliosa e “voluminosa” del Peer Gynt e delle liriche»: Spettri, Casa di bambola, Hedda Gabler e L’anitra selvatica, soprattutto. In queste opere, Ibsen scandaglia la «profondità della superficie», paradosso enunciato da Savinio in questo testo e che si attaglia a tanta altra grande letteratura, incline al gioco delle parti tra orizzontalità e verticalità, in luogo di un’esibizione, sempre assai retorica, di quest’ultima.
L’acutezza di questa riflessione, come di tante altre che costellano il testo di Savinio, fa da contraltare a un “femminismo” più volte esplicitamente sbandierato e che di fatto – con un’evidenza a tratti disarmante, oggi – non sembra essere tale. Come può immaginare chiunque abbia frequentato l’opera di Savinio, infatti, prevale il riferimento classicamente saviniano al topos dell’ermafroditismo come possibile orizzonte culturale e anche politico, perché procedendo dall’idea di una simbiosi “uomo-donna” – come si legge nella Nuova Enciclopedia (1977) di Savinio – si arriva a quella “individuo-stato”.
Per Savinio, dunque, Ibsen indica la strada maestra: lo fa con un certo paternalismo – come sembra di poter leggere, tra le righe, nella stessa analisi di Savinio di Casa di bambola – e insieme con un chiarissimo piglio tragico. Quest’ultimo aspetto si deve al fatto che la salvazione progettata da Ibsen si rivela progressivamente senza limiti: «Altre “salvazioni” rimangono da compiere e la missione di Ibsen veramente non ha fine. Se riprendiamo “lo sguardo” al punto in cui Ibsen lo lasciò, e serriamo maggiormente le palpebre intorno le pupille, e ammicchiamo più stretto, e spingiamo più avanti la scoperta del “sempre più grande nel sempre più piccolo”, di là dalla donna arriviamo al bambino…». Inclinazione che, in questo modo, manifesta il proprio paternalismo e allo stesso tempo si consegna alla tragedia: «Idea della salvazione: idea tipicamente riformista che l’europeo settentrionale ha preso dall’orientale, in quel connubio di oriente con occidente che ha composto la cosiddetta civiltà arabogotica e che in poesia ha dato Parsifal, ha dato Brand, ha dato Zaratustra». Una teorizzazione storico-culturale affascinante, fornita anche qui per intuizione, o comunque per un improvviso slancio dell’immaginazione critica, ma che senza dubbio denota una classica impostazione primonovecentesca, con tutti i suoi limiti metodologici: allo stesso modo, infatti, Savinio apre il testo descrivendo la Norvegia di Ibsen come “l’ultima Grecia dell’Europa” – descrizione che, appunto, aderisce al tragico ibseniano e a poco altro, avvitandosi infine su sé stessa.
Infine, il “femminismo” di Ibsen e Savinio si condensa ancora in un’altra immagine, tra le molte che si lasceranno alla scoperta di chi vorrà leggere: «Un abisso separa la donna dall’uomo, ma anche gli abissi si colmano e a colmare questo abisso provvede il femminismo. Per avere una immagine precisa di come avviene questa operazione di riempitura, basta ripensare al traforo del Sempione iniziato nel 1898 e portato a termine nel 1905, e celebrato nel suo felice compimento dalla Esposizione Universale di Milano del 1906. Due squadre di perforatori iniziarono i lavori, una a Domodossola l’altra a Briga, e perforando la roccia ciascuna dalla sua parte, un giorno s’incontrarono nel mezzo della montagna. Nell’attuazione del femminismo non le sole femministe operano, cioè a dire le donne cui muove l’idea della evoluzione della donna, ma operano da parte loro anche i femministi, ossia gli uomini cui essi pure muove l’idea della evoluzione della donna, e in testa ai quali è giusto porre Enrico Ibsen».
Metafora della penetrazione come di una comunicazione sotterranea, genitale, che oggi non può non apparire datata, se non anche grottesca, in rapporto alla storia successiva del femminismo, dei femminismi, ma che rende bene lo spirito dell’epoca, incarnato da una critica letteraria esercitata anche come posizionamento culturale e politico. Ed è quest’ultima che merita di essere riattraversata ancora oggi, sia per il valore intrinseco del testo di Savinio, sia per ricostruire le genealogie dei limiti e delle potenzialità del “femminismo” quando è stato agito da altri orientamenti di genere, e a maggior ragione nel caso di intellettuali uomini etero-cis detentori di un grandissimo capitale simbolico.