Aria di bicentenario tra i vampirologi, visto che ricordiamo quest’anno l’arrivo del primo vampiro maschio in prosa, Il vampiro di John William Polidori, 1819, derivato in qualche modo – un frammento di Byron – della famosa scommessa letteraria di Villa Diodati, 1816. Ma sarebbe un grave torto dimenticare l’altra metà dell’ombra, visto che nello stesso 1819 John Keats scrive il poema Lamia [Scotti], pubblicato l’anno successivo.
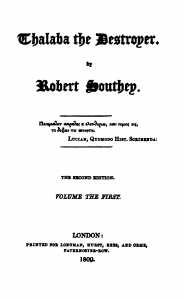 Certo, in senso proprio Lamia non può vantare primati di apparizione letteraria. A precederla nella letteratura romantica sono già apparse varie figure vampiresche femminili, dalla non-morta della ballata goethiana “La sposa di Corinto” (1797), che rilegge in chiave gotica l’antica e ben più delicata storia di una revenant greca, Filinnio, narrata sotto l’imperatore Adriano dal collezionista di mirabilia Flegonte di Tralle), alla seduttrice vampiroide Geraldine dell’incompiuto Christabel di Samuel Taylor Coleridge (in due parti, 1797 e 1801), alla vampira orientale di Thalaba the Destroyer di Robert Southey (1801). E poi, a rigore, Lamia non è una vampira, almeno nel senso tecnico di non-morta umana – il che però apre a un paio di interessanti considerazioni.
Certo, in senso proprio Lamia non può vantare primati di apparizione letteraria. A precederla nella letteratura romantica sono già apparse varie figure vampiresche femminili, dalla non-morta della ballata goethiana “La sposa di Corinto” (1797), che rilegge in chiave gotica l’antica e ben più delicata storia di una revenant greca, Filinnio, narrata sotto l’imperatore Adriano dal collezionista di mirabilia Flegonte di Tralle), alla seduttrice vampiroide Geraldine dell’incompiuto Christabel di Samuel Taylor Coleridge (in due parti, 1797 e 1801), alla vampira orientale di Thalaba the Destroyer di Robert Southey (1801). E poi, a rigore, Lamia non è una vampira, almeno nel senso tecnico di non-morta umana – il che però apre a un paio di interessanti considerazioni.
Anzitutto la vampira, a differenza del suo omologo maschio, manterrà uno statuto assai più libero quanto a forme e manifestazioni, non a caso Lamia proviene in via diretta da quell’arcaicissima e variegata koiné degli incubi che vedeva demoni femmina di origine neolitica con tratti protovampirici (empuse, lamie, mormolici e altri) infestare le mitologie dei popoli più diversi dal Medio Oriente ai paesi baschi e in realtà molto oltre. Il suo modello originale è l’empusa di Corinto da cui, secondo Filostrato, il filosofo-mago Apollonio di Tiana, avrebbe salvato un discepolo e, attraverso una serie di trasformazioni, l’episodio arriverà a Keats, che presenterà Lamia come un’equivoca mutaforma dai caratteri serpentini. Ma anche in seguito, e assai più dei maschi della specie, nelle loro epifanie le vampire sfuggiranno ai tentativi di richiuderle in rigidi e determinati canoni sovrannaturalistici.
Però, soprattutto, ed è questo il punto che merita attenzione, la creatura di Keats ha spaccato in due filoni l’orizzonte degli interpreti: divisi tra chi, memore della pericolosità delle lamie del mito mediterraneo, assume una posizione colpevolista (Lamia mira al giovane Licio per poi divorarlo, e per quanto Apollonio appaia qui odioso il suo intervento sarebbe motivato), e chi invece, considerando come Lamia sembri solo innamorata, la vede vittima del pregiudizio patriarcale. Ma attenzione, Keats non offre indizi univoci, consegnando cioè l’intera vicenda all’ottica di una radicale, provocatoria ambiguità.
Se il vampiro, creatura-ossimoro a cavallo tra istanze diverse (vita/morte, umano/ferino, corporeo/fantasmatico…) si guadagna successo nel mondo moderno anche proprio in quanto icona di un’ambiguità che riconosciamo nostra, nelle vampire troveremo enfatizzata questa duplicità radicale e sfuggente per il nesso con le mitologie patriarcali sulla donna. Ciò che in Lamia trova la più eclatante e provocatoria manifestazione: qualcosa che inficia di un dubbio fondamentale da un lato ogni caccia al vampiro e dall’altra qualunque romanticheria sui Dracula in Love. A suggerire che la realtà è sempre più complessa delle scorciatoie con cui pretendiamo di riassumerla.
Il modello Lamia avrà un enorme impatto, e una sua elegante trascrizione in prosa in senso vampiresco è il racconto “La morta innamorata” di Théophile Gautier (1836) [Scotti], dove, conformemente allo spirito anche di altre visitatrici dei testi dell’autore, la fascinosa cortigiana Clarimonde che traghetta il prete Romuald nei sogni di una Venezia incantata è una figura benevola, pronta a sottrargli solo qualche goccia di sangue; mentre il terribile padre Sérapion, tra furia senile e acquasanta, è il corrispettivo cattolico di Apollonio. Resta il fatto che la vita schizofrenica in cui Romuald viene coinvolto dall’amante sovrannaturale non si esaurisce in un peana alla fantasia, ma mantiene pericolosamente l’ambiguità dell’alienazione.
 Dove però il lascito spicca in modo più emblematico è in un’altra opera-cardine, Carmilla di Joseph Sheridan Le Fanu. Talmente ambigua – potremmo dire – da restare al confine tra forme narrative diverse, il romanzo (è divisa in capitoli) e il racconto; e anzi, dopo la prima apparizione a puntate sulla rivista The Dark Blue (1871-72), il testo appare incernierato nella raccolta In a Glass Darkly (1872), presentata unitariamente con tanto di cornice quale florilegio di casi repertoriati dal proto-detective dell’occulto Martin Hesselius, altro epigono di Apollonio. Già così sfuggente nella forma, Carmilla lo diventa ancor più nel contenuto, come una ghost story “di confine”: una novità forte, a tener d’occhio la progenie del vampiro polidoriano, e più in generale la narrativa anglosassone, che tende a dividere in due filoni le storie di fantasmi e quelle di vampiri.
Dove però il lascito spicca in modo più emblematico è in un’altra opera-cardine, Carmilla di Joseph Sheridan Le Fanu. Talmente ambigua – potremmo dire – da restare al confine tra forme narrative diverse, il romanzo (è divisa in capitoli) e il racconto; e anzi, dopo la prima apparizione a puntate sulla rivista The Dark Blue (1871-72), il testo appare incernierato nella raccolta In a Glass Darkly (1872), presentata unitariamente con tanto di cornice quale florilegio di casi repertoriati dal proto-detective dell’occulto Martin Hesselius, altro epigono di Apollonio. Già così sfuggente nella forma, Carmilla lo diventa ancor più nel contenuto, come una ghost story “di confine”: una novità forte, a tener d’occhio la progenie del vampiro polidoriano, e più in generale la narrativa anglosassone, che tende a dividere in due filoni le storie di fantasmi e quelle di vampiri.
Ma è tra le pieghe della vicenda che l’ambiguità trionfa. L’incantevole vampira adolescente Carmilla emerge come doppio della narratrice Laura, prigioniera in un mondo di vecchi, e lì deprivata di speranze vive e di passioni, di autonomia e identità sessuale; emerge evocata dalla solitudine di lei e da un irriconosciuto, divorante desiderio – un volto oscuro, sovversivo e irresistibilmente seduttivo che il romanzo circonfonde di pericolosa minaccia sessuale. Dove persino la sintesi tante volte spesa – “storia di una vampira omosessuale” – e in sé corretta ma limitante, mostra tutta l’ambiguità di una lettura vittoriana dell’omosessualità femminile, negata e confusa in una sorta di rifrazione narcisistica: come nel quadro Il bacio di Philip Burne-Jones (1887) in cui l’immagine apparente di un bacio tra due donne si svela, attraverso il bozzetto preparatorio, segnata dal contorno circolare di uno specchio. Evidentemente, la giovane sta baciando il proprio riflesso.
Non è strano che proprio il Mondo Vecchio da cui Laura aveva cercato scampo tramite Carmilla reagisca a stroncare quella ribellione, distruggendo brutalmente la giovane predatrice: una situazione che la pur lucida Laura, non-morta alla vita, non riesce tuttavia a elaborare e la condanna alla deriva schizofrenica del rimpianto. La suggestione con cui chiude il romanzo, quella sensazione di udire ancora il passo leggero di Carmilla oltre la porta del salotto, è intrisa di inquietudine e di malinconia, di un sapore di inaccettato, represso e irrisolto.
Il risultato è una storia senza “buoni”. Anche se l’autore solidarizza coi patriarchi in scena, c’è molto di vampiresco in quel confinare i propri figli in un mondo chiuso, e nella stessa feroce esecuzione finale gestita dai vecchi su Carmilla riversa. Che però a sua volta non è un’eroina libertaria, perché si porta dietro le crudeltà arcaiche di un mondo di Contesse Sanguinarie, e persino nelle dichiarazioni appassionate a Laura tradisce un divorante egoismo sadiano. La cifra è insomma quell’ambiguità che connota il fantastico nella sua accezione laica e moderna.
 Il gruppo descritto da Le Fanu di tre vampire – Carmilla, la madre e una sorta di spiacevole nutrice – più un cavaliere nero trova però completa ridefinizione in un altro gruppo di tre vampire più un Conte nero, cioè nel Dracula di Bram Stoker (1897) [Gallo]. Due sono brune e assomigliano al Conte, la terza è bionda, ad abbinare idealmente le due classiche declinazioni fenomeniche del vampirismo, quello folklorico che si consuma tra parenti (magari con un quid di incestuoso) e quello romantico che vede il ritornante quale maschera di demon lover – con l’ovvia avvertenza a non cadere nella citata banalizzazione interpretativa del Dracula in love. Al di là di una bella tomba per la bride favorita e del ricordo di un qualche “amore” archiviato nel passato, il senescente predatore imperialista descritto da Stoker ha il cervello occupato da ben altri pensieri; e tanto meno, con buona pace di Coppola & Co., può sdilinquirsi per Lucy o per Mina (anche perché nel romanzo l’idea della reincarnazione proprio non c’è). Questa dunque una prima, radicale connotazione di ambiguità. A cui se ne può far seguire una seconda: nonostante l’episodio delle tre vampire figuri fin dai primissimi appunti di Stoker, negli elenchi di personaggi da lui stilati in bozza secondo l’uso teatrale le vampire mancano: a negar loro persino l’identità sfuggente concessa alle tre Strane Sorelle del Macbeth, cui rinviava una frase poi stralciata del dattiloscritto originale. E richiamarle piuttosto all’umbratile fungibilità delle “donne perdute” portatrici d’infezioni o delle più esotiche ma altrettanto sfuggenti donne degli harem del non-morto (al tempo) impero ottomano.
Il gruppo descritto da Le Fanu di tre vampire – Carmilla, la madre e una sorta di spiacevole nutrice – più un cavaliere nero trova però completa ridefinizione in un altro gruppo di tre vampire più un Conte nero, cioè nel Dracula di Bram Stoker (1897) [Gallo]. Due sono brune e assomigliano al Conte, la terza è bionda, ad abbinare idealmente le due classiche declinazioni fenomeniche del vampirismo, quello folklorico che si consuma tra parenti (magari con un quid di incestuoso) e quello romantico che vede il ritornante quale maschera di demon lover – con l’ovvia avvertenza a non cadere nella citata banalizzazione interpretativa del Dracula in love. Al di là di una bella tomba per la bride favorita e del ricordo di un qualche “amore” archiviato nel passato, il senescente predatore imperialista descritto da Stoker ha il cervello occupato da ben altri pensieri; e tanto meno, con buona pace di Coppola & Co., può sdilinquirsi per Lucy o per Mina (anche perché nel romanzo l’idea della reincarnazione proprio non c’è). Questa dunque una prima, radicale connotazione di ambiguità. A cui se ne può far seguire una seconda: nonostante l’episodio delle tre vampire figuri fin dai primissimi appunti di Stoker, negli elenchi di personaggi da lui stilati in bozza secondo l’uso teatrale le vampire mancano: a negar loro persino l’identità sfuggente concessa alle tre Strane Sorelle del Macbeth, cui rinviava una frase poi stralciata del dattiloscritto originale. E richiamarle piuttosto all’umbratile fungibilità delle “donne perdute” portatrici d’infezioni o delle più esotiche ma altrettanto sfuggenti donne degli harem del non-morto (al tempo) impero ottomano.
Quale “amore” e quale identità. Ma nelle spose del Castello c’è almeno una terza e più generale dimensione di ambiguità. Come evocate inizialmente da Harker, le tre dame emergono quali chiare proiezioni di un immaginario preraffaellita, salvo virare in creature d’incubo. È interessante ricordare che Dracula appare in libreria nel maggio 1897, e soltanto un mese prima si è avuta la scandalosa presentazione alla New Gallery di Londra del quadro The Vampire di Philip Burne-Jones, figlio del più celebre preraffaellita Edward e amico di Stoker, palesemente ispirato a The Nightmare di Johann Heinrich Füssli. Si tratterebbe di una denuncia della femminilità predatrice, sulla scia delle ultime “rivelazioni” scientifiche (gli Charcot, Lombroso, Nordau citati anche in Dracula); e poco importa qui che il dipinto adombri la relazione dell’autore con l’attrice Beatrice Stella Tanner, alias Mrs. Patrick Campbell, diva al teatro Lyceum di cui Stoker è impresario. Nel quadro vediamo un giovane dall’aria un tantino bohémien privo di sensi e di energie su un letto, con una macchia scura a segnargli il costato, a riportare ai drenaggi pettorali (e non dal collo) associati nel folklore e in classici pre-stokeriani come Carmilla all’azione del vampiro; e a incombere sul giovane è una seducente, assetata femme fatale. Ora, è credibile che i due amici si influenzino reciprocamente con anticipazioni delle relative opere. Ma ciò che colpisce, e che in fondo trova conferma proprio nello sviluppo dell’immaginario narrativo sulle vampire, è che i figli della generazione preraffaellita come appunto Philip, ma a suo modo lo stesso Bram, sembrino guardare con estremo sospetto le dee evocate dai padri: pensiamo solo a cos’avessero rappresentato per le fantasie di un intero mondo vittoriano le dame di Edward Burne-Jones o, persino più paradigmaticamente, quelle di Dante Gabriel Rossetti. Che ora passano da creature numinose cui votare devote contemplazioni a vere e proprie succhiasangue, capaci di pericolose eversioni all’ordine patriarcale (magari chiedendo pure di votare): e il simbolismo prima, e un certo pulp poi ci sguazzeranno.
Le Salomè del primo Novecento – ben più di quella di Wilde – e tutte le altre vamp traghettate al cinema vedono così un irrigidirsi del modello di dissanguatrice. Dark lady e femme fatale conoscono anzi la consacrazione ad autentiche maschere di minaccia per la virilità e per la famiglia, tra fiumi di psicologismi d’accatto, invece d’essere riconosciute per quel che sono, archetipi o più spesso stereotipi. Dove il gioco su una figura mitica finisce col riflettere pesi molto concreti di dialettica tra i sessi, e all’emergere dal tessuto sociale di nuove istanze di libertà vede contrapporsi tentativi rinnovati di controllo a partire dall’immaginario. Per arrivare molto oltre, complici diversi fattori di crisi: e fino magari ad abominevoli, recenti disegni di legge.





