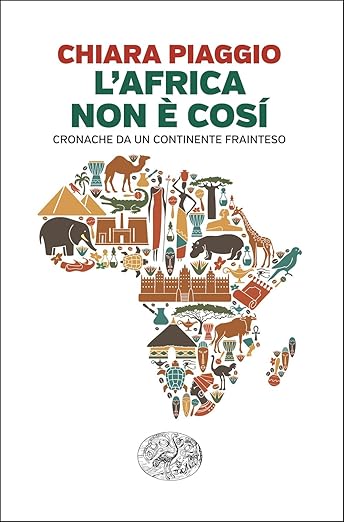Nel suo saggio Chiara Piaggio mette in discussione i cliché che ancora incorniciano il continente africano: la povertà come destino, la violenza come natura, la resilienza e l’autenticità come unico racconto possibile. Fin dall’episodio d’apertura — la bara ghanese a forma di pesce, oggetto rituale che diventa arte contemporanea — l’autrice ci invita a cambiare prospettiva, a spostare lo sguardo dall’alto all’interno e a scoprire un’Africa viva, molteplice, spesso sorprendentemente normale.
Non c’è in queste pagine nessuna fascinazione esotica né residuo missionario. Piaggio, forte della sua lunga esperienza di cooperazione e di ricerca culturale nel continente, scrive da un’angolatura consapevole e disincantata: conosce le contraddizioni dei progetti di aiuto, le distorsioni della filantropia, ma anche la vitalità sociale, artistica e politica di un’Africa che non attende più di essere interpretata. La scrittura piena di dettagli visivi è nutrita di incontri reali — da Abidjan a Cotonou, da Accra a Nairobi — che diventano piccoli studi di caso. Ne risulta un’Africa urbana, giovane, connessa, tecnologica; un continente che non si riconosce più nei codici dell’arretratezza e che, tuttavia, continua a fare i conti con le diseguaglianze e con i lasciti del colonialismo.
Pur senza porsi sul piano accademico, L’Africa non è così condivide alcune intuizioni con autori come Jean-Loup Amselle e Achille Mbembe: l’idea di un’Africa plurale, ibrida, attraversata da scambi e contaminazioni; il rifiuto dell’essenzialismo culturale; la critica delle categorie rigide con cui l’Europa ha tentato di definire “l’altro”. A differenza della saggistica postcoloniale militante, Piaggio mantiene però un tono narrativo e pragmatico: non teorizza la decolonizzazione, la osserva nei gesti quotidiani, nei mercati, nei linguaggi, nelle contraddizioni dei giovani. La sua è una scrittura che nasce dall’esperienza — quella di chi ha vissuto e lavorato a lungo in Africa — e da lì costruisce un pensiero critico, più empirico che ideologico.
Nel volume l’autrice affronta anche il tema decisivo della giovinezza africana, “l’anomalia statistica di un continente”. Piaggio scrive infatti che “ad avere meno di trentacinque anni è il 75% cento della popolazione, dispersa su cinquantaquattro Paesi. Il 60% è così giovane da essere nato dopo l’attentato alle Torri Gemelle”. In questa rappresentazione ambivalente, il continente appare ora come una minaccia, ora come una promessa, raramente come una realtà da conoscere per se stessa. Dietro le astrazioni statistiche, Piaggio mostra una realtà concreta, fatta di creatività, innovazione e adattamento. Il caso del Kenya è emblematico: nel 2007, quando solo il 19% della popolazione possedeva un conto in banca ma oltre la metà aveva un telefono cellulare, nacque M-Pesa, il sistema di pagamento elettronico via SMS partendo dall’uso spontaneo del credito telefonico come moneta di scambio, M-Pesa trasformò la SIM in un portafoglio digitale accessibile anche senza internet né smartphone. Nel giro di pochi anni, oltre il 40% del PIL del Kenya transitava su quella piattaforma, che divenne un modello di inclusione finanziaria per tutto il continente.
Le sue pagine dedicate alle città — Accra, Lagos, Abidjan — proseguono su questa linea concreta: restituiscono l’energia delle metropoli in espansione, la creatività dell’economia informale e le reti di solidarietà che suppliscono all’assenza di politiche pubbliche. Ma non eludono precarietà e diseguaglianze: mostrano come crescita e esclusione convivano, e come la vitalità sociale sia inseparabile dalla fatica della sopravvivenza quotidiana. Quando descrive la normalità di una città africana come la capitale del Ghana, Accra, Piaggio osserva che non è una città “bella” nel senso estetico europeo — mancano piazze e viali, non c’è monumentalità — ma è funzionale, coerente con una logica pratica più che decorativa. La sua struttura urbana risponde ai bisogni concreti della vita quotidiana, e in questa efficienza priva di ornamenti Piaggio riconosce un’altra idea di modernità: un’estetica dell’uso, non della rappresentazione.
Da questo sguardo concreto nasce una delle osservazioni più forti del libro: la normalità del Ghana come ragione della sua invisibilità. Piaggio scrive che, a differenza di altri Paesi africani segnati da guerre o crisi umanitarie, il Ghana non fa notizia: non interessa ai media, né ai politici, né — e qui l’autrice è tagliente — ai solidali europei. È un Paese che, dal 1957, quando per primo in Africa ottenne l’indipendenza dal Regno Unito, non ha conosciuto guerre civili né conflitti etnici di vasta scala, e che ha saputo mantenere una forma di democrazia abbastanza stabile e una reputazione di affidabilità nella regione. Mi viene in mente che, forse, proprio questa stabilità — più sociale che economica — ha reso i lavoratori ghanesi riconosciuti e ricercati in Europa. In Friuli Venezia Giulia, Confindustria ha promosso negli ultimi anni programmi di formazione e reclutamento che coinvolgono giovani del Ghana, presentati come esperienze di cooperazione ma di fatto rispondenti al fabbisogno di manodopera delle imprese locali. Non è un fenomeno nuovo: già dai primi anni Novanta molti ghanesi lavoravano all’Electrolux, costruendo una presenza discreta ma solida, basata su competenza, affidabilità e capacità di adattamento. A fronte di queste qualità — e della volontà di costruirsi un futuro in contesti difficili — il racconto pubblico continua però a ignorarli, come se la loro normalità non fosse degna di attenzione. Piaggio non affronta direttamente questi casi, ma la sua riflessione li lascia intravedere in filigrana: ciò che è stabile, ciò che funziona, non genera empatia né riflessione. L’immagine del Ghana come Paese “che non ha bisogno di essere salvato” diventa allora un controcampo potente: mostra come la cooperazione, economica o umanitaria, spesso presentata come gesto di solidarietà, nasconda rapporti di forza e disuguaglianze persistenti. In questa distanza — tra la retorica della cooperazione e la realtà materiale del lavoro — si gioca il vero nodo politico delle relazioni tra Africa ed Europa.
Nelle parti, dedicate alla politica e ai nuovi equilibri geopolitici, la riflessione si fa più problematica. Piaggio osserva e descrive la presenza crescente della Cina in Africa, sottolineando come la retorica della “cooperazione Sud-Sud” e della “non interferenza” possa apparire, agli occhi di molti africani, una forma di rispetto più concreta di quella offerta dall’Occidente. “La Cina — scrive — non impartisce lezioni di democrazia, non pretende riforme, propone scambi.” Il suo sguardo, qui, non è ingenuamente entusiasta, ma resta indulgente verso la pragmaticità cinese, letta come alternativa alla moralità coloniale europea. È un punto di vista che rischia di sottovalutare gli effetti strutturali di una nuova dipendenza economica e simbolica: l’Africa come mercato, come serbatoio di risorse, come tappa della Belt and Road.
Similmente, la figura del giovane presidente burkinabé Ibrahim Traoré, che si dichiara “erede” di Thomas Sankara, viene evocata come sintomo di una domanda di riscatto e di orgoglio nazionale. Piaggio osserva che per molti giovani “la democrazia è diventata un concetto vuoto, imposto dall’alto”, e riconosce in Traoré la capacità di parlare a quella disillusione. È una posizione comprensiva più che schierata, ma lascia aperto un interrogativo: quanto può la rivolta contro l’’ipocrisia’ occidentale trasformarsi in una nuova forma di autoritarismo? Qui l’autrice sfiora un terreno scivoloso, dove la sua empatia rischia di indebolire l’analisi. Sono proprio queste zone più ambigue — il giudizio sospeso sulla Cina, la benevolenza verso i leader carismatici anti-occidentali — a rendere L’Africa non è così un libro vivo, non pacificato. Non si tratta di un pamphlet politico, né di un diario di viaggio, ma di un esercizio di sguardo: un tentativo di vedere il continente da vicino, “senza illusioni ma con curiosità”.
Piaggio non chiede di scegliere tra progresso e tradizione, tra Occidente e Africa: chiede di comprendere come le immagini si costruiscono, chi le produce, e come possono essere ribaltate. E in questo gesto di decentramento — critico, talvolta spigoloso — sta il valore del suo lavoro. L’Africa non è così non è un libro da leggere per sapere “com’è l’Africa”, ma per capire quanto ancora sia necessario guardare meglio.