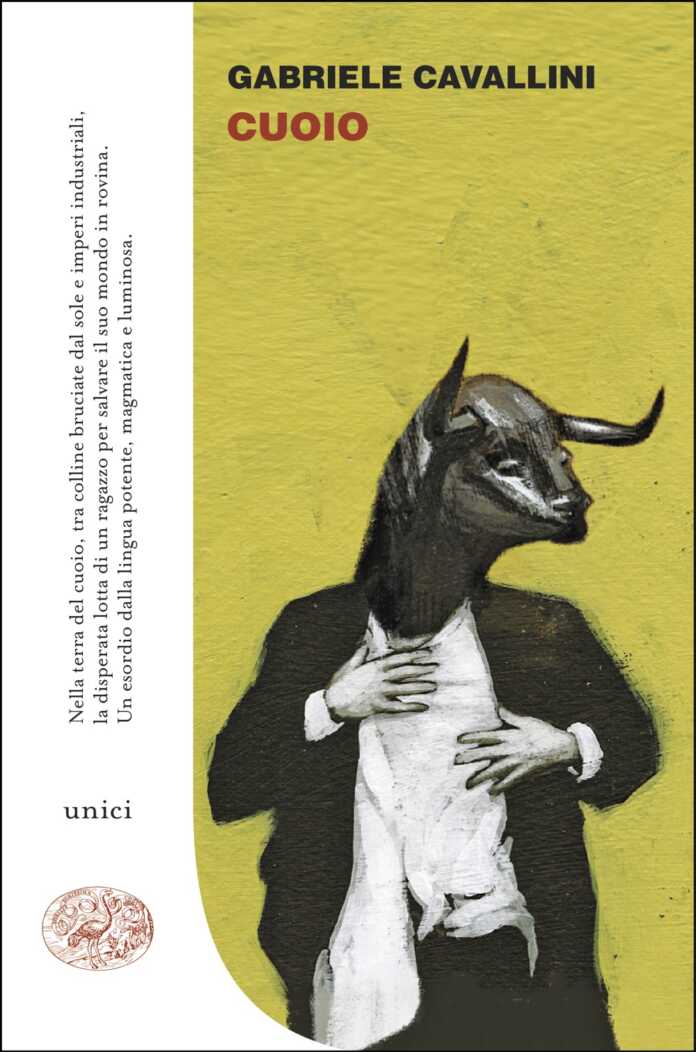Gabriele Cavallini – classe 1995, nato a San Miniato in provincia di Pisa – ha lavorato nel comparto conciario prima di dedicarsi alla scrittura e ambienta il suo primo romanzo in Toscana, dove esiste un vero e proprio “Comprensorio del cuoio”. L’area è così chiamata per l’altissima concentrazione di aziende conciarie che ne caratterizzano il tessuto economico; la quasi totalità della produzione italiana di cuoio da suola proviene da questa zona. È proprio qui che vivono e lavorano i protagonisti di questa storia che ruota attorno all’io narrante Michelangelo Cavalcanti; l’uomo è un tecnico della Conceria Fucci Vanni dopo che la blasonata impresa di famiglia, la “Cavalcanti & Figli” fondata dal nonno paterno, è miseramente fallita cambiando la vita di tutti: il padre di Michelangelo ha lasciato il mondo del lavoro e, smarritosi in varie fantasticherie, si interessa solo di botanica; il fratello minore Emanuele si è chiuso in un ostinato mutismo ed esce a malapena dalla sua stanza trascorrendo la giornata con in mano il cellulare; la madre è scomparsa da un giorno all’altro e non si sa dove sia e mai nessuno, per un lungo periodo, ha pensato di cercarla.
È un libro spietato questo di Cavallini e molto attuale dal momento che “Il Sole 24 ore” ha di recente presentato una collana “I grandi romanzi dell’industria italiana” con cui si vuole raccontare e recuperare un pezzo della nostra storia e della nostra identità e lo stesso intento mi pare potersi ravvisare in Cuoio. L’autore, infatti, riserva grande spazio alla rappresentazione del sistema industriale conciario italiano e al mondo del lavoro in generale con le sue caratteristiche e, in particolare, con le sue violenze. Tanti gli argomenti trattati, ma il cuore del romanzo si potrebbe ravvisare in una parabola discendente del rapporto tra le tre generazioni dei Cavalcanti e la ditta di famiglia. In chi ha fondato la conceria, traspare una sorta di ammirazione e rispetto per la pelle e per la conciatura quale atto fondamentale di sopravvivenza, uno fra i primi compiuto dall’uomo per proteggersi dal freddo e dalla pioggia. Conciare è considerato un modo per valicare il confine stabilito fra la vita e la morte, è una forma di conservazione della specie e il lavoro, anche se duro, nobilita ancora la vita dell’uomo e dà soddisfazione: salvare ogni pelle dalla naturale decomposizione è come giocare a fare Dio poiché la concia, in qualche modo, ferma il tempo, lo scorrere degli anni e rende persistente ed eterno qualcosa che per sua natura non lo è. «Una leggenda del Comprensorio racconta che alla scomparsa di una famiglia conciaiola si dissolvano le loro pelli. Perché per renderle immortali il vero conciaiolo lascia un minuscolo frammento di anima in ogni pelle. Fin quando l’anima non comincia a diventare instabile. Fin quando l’anima accartocciata del conciaiolo non si disgrega. Solo allora è possibile vederli, quei minuscoli frammenti chiusi nel cuore delle pelli, che fuggono e levitano con i resti dell’anima del conciaiolo. Per l ‘amore di precipitare insieme giù all’inferno».
È la seconda generazione, quella del padre di Michelangelo, che non ride mai, a subire negativamente il lavoro: un’attività che lo costringe a tornare a casa tardi la sera senza avere la forza e la voglia di rivolgere la parola a nessuno, a fare telefonate nel cuore della notte a clienti lontani, senza neanche pensare di premurarsi di far piano, dimostrando così un totale disinteresse per la famiglia. In particolare, il trascurare la moglie porterà la donna a scaricare la sua insoddisfazione sui figli, i quali cresceranno in un ambiente anaffettivo e convinti che l’unica cosa giusta da fare nella vita per diventare migliori sia seguire il mestiere di famiglia. L’ultima generazione, quella di Michelangelo, invece, si trova a convivere con il declino di quello che sembrava un impero solidissimo. Ci si muove tra fabbricati che si assottigliano per numero e grandezza, e con l’intonaco sbriciolato che mostra lo scheletro nudo, i ferri arrugginiti del cemento armato e i tetti rotti e forati come se Dio in persona dovesse guardarci dentro. Alcune costruzioni, tra cui la gloriosa conceria dei Cavalcanti, sono messe così male che basterebbe un temporale a buttarle giù, ma è proprio lì, dove non entra più nessuno, che vivono gli scarnatori e i pressatori, manovalanza impegnata tutto il giorno in fabbrica tra il grasso, il cromo, la melma del fango tossico ma che, nonostante questo, non guadagna abbastanza da potersi permettere un tetto sopra la testa e vive accampata dentro gli stabilimenti ormai in rovina. Oltre alle parti che descrivono anche da un punto di vista materiale, il lavoro, la produzione e il funzionamento concreto di una conceria, largo spazio viene dato al racconto dei rapporti familiari.
Siamo di fronte a una famiglia in crisi, segnata irreparabilmente dall’incapacità di comunicare e risolvere i conflitti, dall’assenza totale di empatia, dove nessuno pare essere in grado di condividere apertamente pensieri e sentimenti e dove solo il rifugiarsi nei pochi episodi felici dell’infanzia allontana il protagonista da un senso costante di malinconia e nostalgia per una tenerezza raramente conosciuta, ma di cui sente comunque la mancanza; a volte, Michelangelo si sente talmente solo d’aver paura di sparire e con suo fratello – inesorabilmente risucchiato dalla violenza più estrema del deep web – fatica a mantenere un rapporto che si esaurisce nell’accompagnarlo ai settimanali incontri con la psicologa.
Tutto il romanzo è permeato da un senso di sconfitta del protagonista principale non solo per non aver più la ditta di famiglia che dava lustro e onore al cognome Cavalcanti, ma perché è un soggetto che vive nell’immobilismo, incapace di ricomporre i frammenti di una famiglia e di una stantia vita sentimentale che cerca goffamente di recuperare. È un interessante d’esordio questo di Cavallini che ha avuto la buona intuizione di esplorare il mondo del lavoro in un ambiente poco noto come quello della lavorazione della pelle e anche il coraggio di affrontare il tema dell’identità personale e della difficoltà di gestire i rapporti con gli altri e le emozioni in genere. Non solo, anche l’accenno al deep web è un tema drammaticamente attuale e un argomento che, probabilmente, andrebbe più diffusamente trattato e non solo dal giovane esordiente toscano.