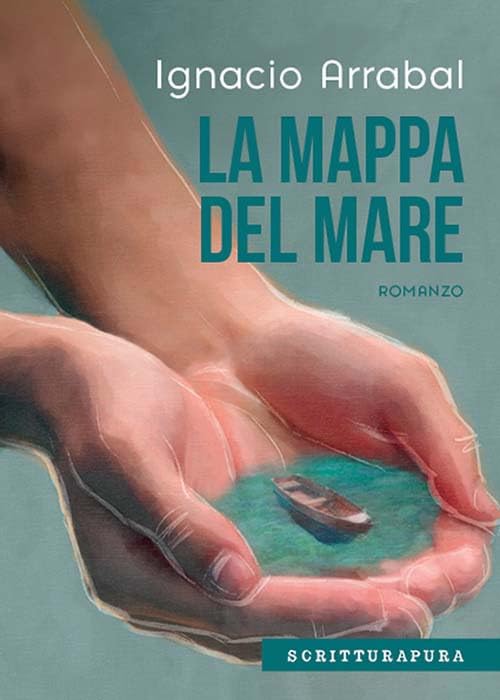Ipotesi: c’è una dimensione dell’immaginario spagnolo peninsulare, spesso frequentata, che ha a che fare con un pueblo – nel senso di “villaggio” o “paese”, prima che di “popolo” – apparentemente fuori dal tempo e dalle relazioni culturali, sociali e politiche con la propria contemporaneità. Darne prova non è facile e richiede maggiore spazio che non quello di una semplice recensione. Mi è capitato, ad esempio, di ritrovarne esempi in un libro letto già in bozze quasi quindici anni fa, come Belfondo dell’autrice catalana Jenn Díaz, pubblicato dalla casa editrice bolognese La Linea nel 2011, e poi di ritrovarne motivazioni antropologiche e culturali profonde in un bel saggio intitolato La Spagna vuota (Sellerio, 2019) di Sergio Del Molino. Potrebbero essere molti altri ancora i titoli, ma di sicuro La mappa del mare dell’autore andaluso Ignacio Arrabal – nipote del forse più noto drammaturgo Fernando Arrabal – ne è un nuovo esempio, e la casa editrice Scritturapura, sempre alla caccia di piccoli gioielli della letteratura internazionale, ha fatto bene a darne traduzione italiana per la mano sempre sicura di Alessandro Gianetti.
“La mappa del mare” è, in effetti, oggetto della ricerca di un narratore presumibilmente molto giovane che, insieme all’amico Agustín, si muove nelle ristrettezze geografiche, ma anche economiche e culturali, di «un luogo carbonizzato dal presente, dove tutti cercano segni e presagi in una natura impaziente, rovistando tra le parole, cercando di svelare nella luce, negl’incantesimi dei sogni o nell’oscurità del destino, l’indecifrabile senso della vita». Se già in questi pochi cenni si può intravedere la propensione lirica della scrittura di Arrabal – occasionalmente appesantita da alcune scelte lievemente barocche nell’aggettivazione («virulenta tranquillità», «foglie rognose», «cervicale e imprevedibile paura»), scelte che la sempre puntuale traduzione di Gianetti provvede comunque ad amalgamare – vi si scorge nettamente anche la qualità metafisica della narrazione di un pueblo triste, solitario y final (per rubare una citazione a Osvaldo Soriano, e collocarla momentaneamente fuori luogo) o, per meglio dire, di un “paese terminale”. Morte e disgregazione sociale sono, in effetti, due protagonisti disincarnati sin dalle prime pagine, da quando uno straniero arriva nel villaggio, diffondendo il terrore «come un’epidemia».
Lo straniero si chiama Lerma, come un piccolo borgo di duemilacinquecento anime nel cuore della Castiglia, emblema della “Spagna vuota” di Del Molino: si può tuttavia dubitare che l’allegorismo di Arrabal arrivi a tanto, preferendo invece ipotizzare che si tratti di una coincidenza; il suo personaggio, d’altra parte, interroga da subito l’identità degli abitanti del paese in funzione della propria alterità, ad esempio con il suo primo e unico gesto pubblico, ossia con l’installazione di una porta a specchio in casa sua.
Ciò che Lerma porta con sé è una storia di violenza, trauma e dolore («La prima parola che ricordo di aver sentito è stata disgrazia», racconta a un certo punto) che indirizza la narrazione verso gli esiti tragici finali; allo stesso tempo, in quanto straniero, è anche un personaggio catalizzatore di pulsioni represse e fantasie di vario tipo. La stessa “mappa del mare” ricercata dal narratore e da Agustín rientra in questo ambito, delineandosi via via come un sogno di difficile realizzazione.
In effetti, serpeggia nella narrazione un senso trasversale di impotenza, che è in primo luogo impotenza verso il proprio contesto sociale: se ne ritrova traccia anche nel titolo originale del testo, Los ofendidos, che rimanda a un’offesa della vita che, infine, non può essere sanata (e che forse rinvia a una tradizione cultura peninsulare parallela a quella sinora descritta, ossia la linea di narrazione-inchiesta presso le classi sociale subalterne emblematicamente rappresentata dal documentario Las hurdes di Luis Buñuel, del 1932, girato in Extremadura). L’impotenza, come manifestazione di una vulnerabilità che non riesce e forse non può fare i conti con sé stessa, tocca infine tutti i personaggi, anche il «mitologico» Lerma, coinvolgendo anche chi legga questo romanzo breve e dalle tinte ancestrali in un’indagine, che non può essere elusa, sulla propria e attualissima vulnerabilità.