Cartografare le trame culturali complesse tra Europa e Asia attraverso la poesia e il lavoro spesso impossibile della traduzione emerge come uno dei tratti più interessanti dell’Antologia di poesia cinese contemporanea, in uscita in questi giorni per i tipi di Delufa Press (pp. 386, euro 19,00 stampa) con la traduzione e la cura di Francesco De Luca, esperto di lingua cinese e di Cina. Traduttore e casa editrice che hanno recentemente realizzato il progetto editoriale I tre dell’università di Pechino. Poesie scelte 1981-2022 che raccoglieva versi scelti di Hai Zi, Luo Yihe e Xi Chuan, tutti presenti anche in questo volume.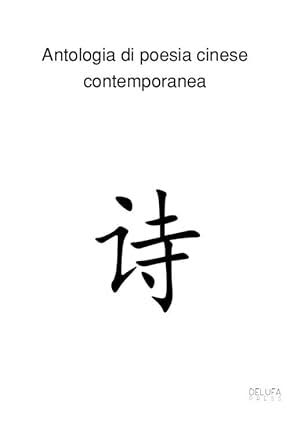
Questa antologia include una vasta campionatura di poesie di trentotto poeti e poete cinesi, nati e nate tra il 1928 e il 1988 che ci restituiscono una panoramica decisamente articolata del fare poesia in Cina tra gli anni Quaranta del XX secolo e gli anni Venti del XXI: una ampiezza che include una grande varietà di stili, registri, linguaggi, temi, geografie e storie di un vero Paese-continente, con una stratificazione letteraria difficile da comprendere fino in fondo alle nostre latitudini – come si intuisce dalla ricca introduzione del poeta, anch’egli qui antologizzato, di Shu Cai (1965) – senza poter attingere a più testimonianze, visioni e mondi intricati creati e ricreati da questi autori e autrici attraverso il tempo e lo spazio.
Alcune delle linee tematiche prevalenti possono essere individuate lungo il segmento interrotto tra infanzia e natura (onnipresente) oppure da un certo disagio della modernità dinanzi a un tempo perduto e rimpianto. Molti versi sono attraversati da riferimenti più o meno espliciti alla cultura europea ma certamente risemantizzati e trasfigurati in contesti e sensi nuovi.
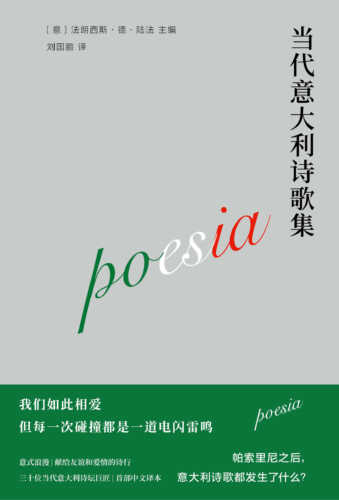 È importante sottolineare che l’Antologia fa parte di un dittico: contemporaneamente, infatti, esce in Cina, sempre per la cura di De Luca e con una prefazione di Renzo Paris, una Antologia di poesia italiana contemporanea per la casa editrice Jiangsu Phoenix Literature and Art Publishing di Nanchino. Uno stare poeticamente tra lingue e tradizioni culturali che preludono a contaminazioni e transculturazioni. Martedì 2 settembre, presso la Libreria di Palazzo Esposizioni in Via Milano 15 a Roma, ci sarà la presentazione delle due antologie in occasione del Festival di poesia italo-cinese.
È importante sottolineare che l’Antologia fa parte di un dittico: contemporaneamente, infatti, esce in Cina, sempre per la cura di De Luca e con una prefazione di Renzo Paris, una Antologia di poesia italiana contemporanea per la casa editrice Jiangsu Phoenix Literature and Art Publishing di Nanchino. Uno stare poeticamente tra lingue e tradizioni culturali che preludono a contaminazioni e transculturazioni. Martedì 2 settembre, presso la Libreria di Palazzo Esposizioni in Via Milano 15 a Roma, ci sarà la presentazione delle due antologie in occasione del Festival di poesia italo-cinese.
Di questo e di molto altro abbiamo parlato con Francesco De Luca.
PULP Nell’incipit della tua introduzione all’antologia scrivi: “Tutta la mia storia con la Cina è una storia d’amore e di poesia”. Allora vorrei cominciare col chiederti perché proprio la poesia? E perché la poesia per creare ponti tra Italia e Cina?
Francesco De Luca Per me la poesia è lo strumento principe per arrivare al cuore delle persone. È l’unico modo per superare resistenze, diffidenze e incomprensioni che spesso impediscono a due popoli gloriosi come i nostri di conoscersi e abbracciarsi. Due culture millenarie non possono che incontrarsi nel tempio della parola: la poesia.
Oggi l’Occidente si è perso, lo dico da quando sono partito e lo ripeto da quando sono tornato, ormai dieci anni fa. Lo specchio di cui abbiamo bisogno è l’Oriente: guardarci nella sua anima per ritrovare equilibrio ed essenza. La poesia, in questo, ha un potere raro: sa mettere a nudo il cuore dei popoli, mostrarci per come siamo, anche nei momenti di fragilità con noi stessi e con la società.
PULP Cosa significa oggi portare in Occidente, in Europa, pezzi di scrittura letteraria dalla Cina, un Paese dal quale si fa gran fatica a recepire umori e amori culturali – con rare eccezioni e penso qui a Add editore che si occupa anche di sottoculture cinesi, oltre ovviamente, a Delufa Press – e del quale ancora quasi esclusivamente come un incombente gigante economico e politico e come luogo di asfissiante controllo totalitario e mancanza di diritti umani elementari?
FDL Portare la letteratura cinese in Occidente significa aprirsi alle possibilità dell’essere. Smetterla di pensare di sapere già tutto, smettere di ritenersi superiori e iniziare un dialogo sincero. La Cina ha subito per secoli l’avidità dell’Occidente, la storia lo insegna. Eppure anche la nostra storia europea non è priva di errori, interessi, militarismi, violenze. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Nessuno lo è. Per questo credo che l’unica via d’uscita dalla confusione contemporanea, con i suoi conflitti e la sua disinformazione a fibra ottica, sia il dialogo.
E il dialogo passa dalla lingua, dallo studio, dalla conoscenza reciproca libera da preconcetti. Bisogna andare alle fonti, non fermarsi alle versioni tramandate: la storia quasi sempre è stata scritta da uomini. Io in Cina ci sono andato di persona e ci sono rimasto quasi dieci anni. La lezione che ho imparato è semplice: smettiamo di giudicare senza elementi sufficienti e impariamo a studiare sul campo, non solo sui libri.
PULP Quali sono stati i criteri che ti hanno guidato nella scelta dei poeti antologizzati?
FDL I poeti inseriti nella presente antologia sono tutti attivi in un periodo che copre circa gli ultimi 40 anni, ognuno con le proprie caratteristiche peculiari che li accomunano perché sono tutti rivolti verso uno stesso sole: la poesia.
Ho rinunciato subito all’idea che un’antologia del genere potesse essere giusta o completa. È impossibile. Così ho vagato nel panorama poetico cinese come vagavo fisicamente nel Paese: ogni volta che incontravo un poeta che mi colpiva lo appuntavo, sognando un giorno di riunirli in un libro.
Ci sono voluti anni. Ho raccolto nomi, ho parlato con letterati, critici e poeti in diverse città, finché bussando alle porte della Phoenix di Nanchino si sono aperte nuove possibilità. Ho potuto incontrare grandi poeti, dialogare con loro di persona o online. Da lì il lavoro è stato tutto in discesa, merito anche della loro disponibilità.
Questa antologia, lo dico chiaramente, non esaurisce il panorama poetico cinese. È solo un’istantanea rubata dalla serratura di una porta di servizio.
PULP In contemporanea a questa antologia hai curato un’Antologia di poesia contemporanea italiana con un importante editore cinese. Cosa ti ha spinto all’idea di una doppia traduzione di poesia dal cinese all’italiano e viceversa? Quali sono stati i criteri di inclusione di poeti e poete italiane?
FDL Alla base c’è l’amore per l’Italia. Tornato a Roma, ho cominciato a tradurre poesia cinese, a insegnare lingua, a restituire almeno in parte ciò che avevo imparato in quegli anni in Cina. Poi mi sono chiesto: perché non portare anche un po’ d’Italia in Cina? Me lo chiedevano loro stessi: “Ma dopo Pasolini, cosa è successo alla vostra poesia? Facci leggere qualcosa!”. Così è nato il progetto.
I criteri di scelta? Il pragmatismo. Ho pensato all’antologia italiana come a quella cinese: istantanee, non un canone definitivo. Non volevo eleggere “i migliori”, ma portare voci vive. Certo, i poeti selezionati hanno tutti un riconoscimento nel panorama italiano, e chi conosce le difficoltà di attirare attenzione oggi capirà che già questo è molto.
Un altro criterio è l’arco temporale di riferimento. I poeti presenti nell’antologia sono tutti poeti che idealmente hanno operato dalla morte di Beppe Salvia a quella di Gabriele Galloni.
Quindi come per la selezione dei poeti cinesi, circa gli ultimi 40 anni. Troviamo poeti completamente diversi tra loro e l’idea è proprio questa. Accumunarli nella diversità. Far vedere che in un determinato periodo storico c’erano poeti che poetavano in modi anche estremamente diversi, pensa a Elio Pecora, Daniele Mattei e Guido Catalano, per esempio. Sono molto diversi tra loro e tutti a loro modo rappresentativi di ciò che “c’è”.
Molti nomi sono noti, altri un po’ meno: ho avuto l’onore di accompagnarli tutti in questo viaggio verso la Cina. Ma non sarei riuscito a raggiungerne tanti senza l’aiuto di Renzo Paris, poeta, traduttore e amico.
PULP L’Antologia di poesia cinese include trentotto poeti, di cui sette sono poete. Esiste una questione di genere nella poesia in Cina, cioè in termini di tematiche e linguaggi ma anche di accesso all’espressione letteraria? E ha influenzato il tuo lavoro di ricerca, selezione e traduzione?
FDL La questione di genere non mi ha mai convinto. Trovo assurdo distinguere uomini e donne in qualsiasi contesto, e anche solo parlarne mi lascia diviso tra un sorriso e un brivido. Nell’antologia ci sono poeti e poete, alcuni grandi, altri meno noti, scelti per la loro voce e non per il loro sesso.
La mia selezione è stata intuitiva: ho ascoltato il loro sentire poetico, traducendolo secondo le mie capacità. Non smetterò di tradurre poesia cinese: questa raccolta è solo un passo ulteriore in un lavoro che vuole mettere insieme i poeti, spesso troppo in competizione, al di là di sesso e capacità.
PULP I due volumi saranno presentati in occasione del primo Festival di poesia italo-cinese. Come è nata questa idea di un festival tra le due lingue, letterature ed esperienze poetiche? E ci sono già nuovi progetti in cantiere sull’asse letterario Italia-Cina?

FDL L’idea del festival è nata a Nanchino, durante una visita alla sede della Phoenix. Mi ha colpito la loro disponibilità al dialogo e la naturalezza con cui ci intendevamo. Ho proposto di organizzare una festa della poesia, un’occasione per abbracciarci e colmare almeno in parte le distanze. Hanno accolto subito la proposta con entusiasmo, e da lì è nato tutto.
Il progetto prevede che il festival continui con cadenze che non anticipo ancora, ma con un’idea chiara: farlo viaggiare tra Italia e Cina, portando la poesia in giro come una festa della bellezza che supera ogni differenza. Sarà emozionante accompagnare i poeti italiani in Cina, viaggiare insieme come si faceva un tempo e come, a mio avviso, dovremmo tornare a fare con maggiore spinta. Nel frattempo, sto concludendo la traduzione di un libro di Zhou Yaping, poeta e regista già presente in questa antologia. Se tutto va bene lo porteremo in libreria a novembre. Poi ci saranno sicuramente altri libri, ma per quelli bisognerà attendere la fine del 2026, inizio 2027. Avremo modo di riparlarne. Tutto, naturalmente, grazie a Delufa Press.
PULP Oggi, secondo te, quali sentieri possono essere aperti da questo lavoro di doppia traduzione poetica tra i due Italia e Cina, che sono già così connessi in una rete globale di migrazioni e mobilità economiche? Potrebbe avere anche un impatto sulla folta comunità cinese in Italia, nella quale fra l’altro sono emerse anche le voci letterarie di autori e autrici sino-italiane?
FDL Potrebbe, sì. Ma molto dipenderà dall’eco che si riuscirà a creare, dai dibattiti e dagli incontri che seguiranno. Arrivare a questo risultato non è stato semplice: nessuna casa editrice di prestigio ha risposto ai miei tentativi di pubblicazione. Per questo, con Emilio Pappagallo di Radio Rock e Valentina Chiarelli, abbiamo deciso di fondare la nostra casa editrice, con uno spirito quasi ferlinghettiano.
Ora molto dipende da noi, dalla nostra capacità di aprirci a nuove opportunità di dialogo. Un libro da solo non copre le distanze: ha bisogno di tempo. E quanto tempo servirà non possiamo saperlo.
PULP Quando si fanno operazioni culturali e di traduzione come la tua, che mette in connessione realtà linguistiche così diverse e lontane nello spazio, esiste ancora il rischio di mettere in atto ciò che Edward W. Said chiamava “orientalismo”, ovvero un rapporto di fascinazione esotica con lo scopo finale di rappresentare un altro da sé deformato e, sostanzialmente, inferiore?
FDL Che bella domanda, Roberto! Il primo altro da me per me stesso sono io stesso. E non lo dico per rispondere in maniera radical chic. Sono radical, ma non chic. Mi sono espanso. Ho vagato oltre i confini della mia limitata percezione e sono tornato con una visione pur sempre limitata ma accresciuta. Sono quasi morto, più volte, ho sfidato i tifoni e le tempeste. Non c’è altro da sé se non i nostri limiti che ci impongono una visione di noi stessi. Ho risposto alla tua domanda?
PULP Un’ultima curiosità: perché la gran parte di questi scrittori e scrittrici scrive sotto pseudonimo?
FDL In Cina lo pseudonimo è una tendenza storica e culturale, ma in passato ha avuto anche una funzione pratica: proteggere dalla censura. E la censura non riguarda solo la Cina. Anche noi ci illudiamo di poter dire e pubblicare tutto, ma chi lavora davvero in editoria o giornalismo sa bene che non è così. Io stesso ne sono stato toccato, e lo stesso mio padre, con i suoi libri su mafia e antimafia. Quando gli argomenti si fanno scomodi per qualcuno una censura di sorta arriva sempre.
Torna sempre lo stesso punto: smettiamola di ritenerci superiori. Avviamo invece un dialogo sincero, accorato, verso una società migliore. Anche — e forse soprattutto — attraverso e grazie alla poesia.



