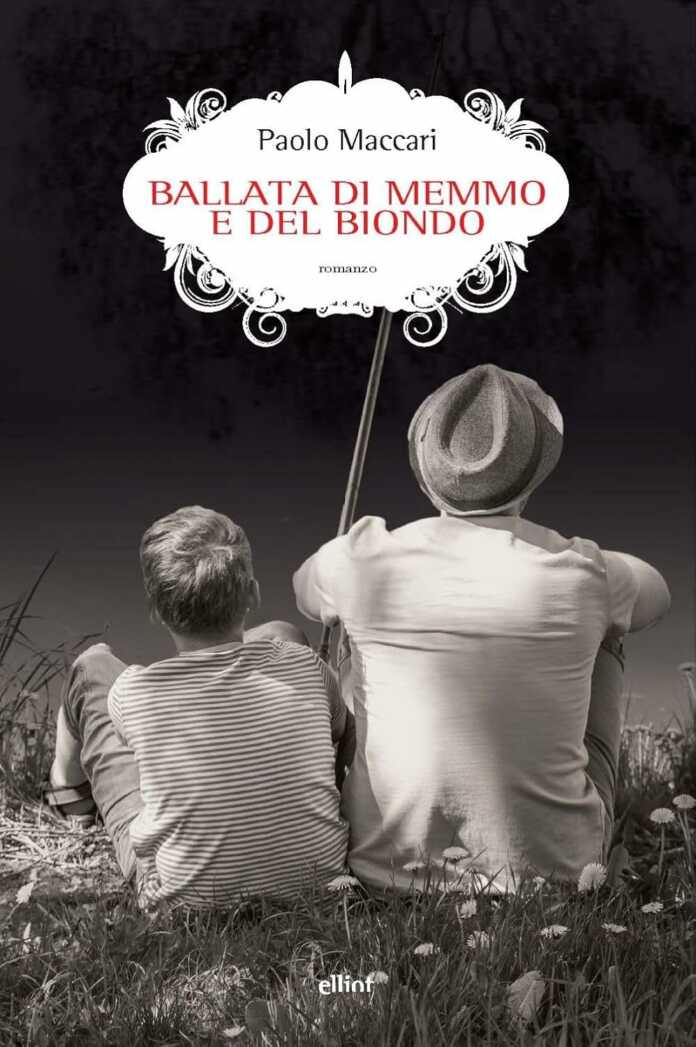Misurandosi per la prima volta con la forma del romanzo allo scoccare dei cinquant’anni, il poeta e critico Paolo Maccari (tra i suoi ultimi titoli di poesia, Fermate, sempre per Elliot, 2017), I ferri corti, Lietocolle 2019 e Quaderno delle presenze (Le Lettere, 2022) sceglie, nel titolo e in alcuni elementi del testo, di mantenere un riferimento alle forme della poesia e di raccontare, quindi, la storia di Memmo e del Biondo con il titolo di ballata. La tipica struttura responsoriale della forma poetica citata è, in realtà, dilatata lungo tutto il libro, conferendo un’apparente preminenza al personaggio di Memmo rispetto al Biondo: se il primo si racconta per tre quarti del testo, del secondo si chiarisce l’identità solo in coda al libro, con una mossa, tuttavia, che chiarisce ulteriormente la struttura della narrazione e ne amplifica la portata, come un’eco, anche dopo la conclusione del romanzo.
Chi conosce sin dall’inizio l’identità del Biondo, invece, è senza dubbio il narratore, che troviamo impegnato, nelle prime pagine, in una lenta risalita della strada detta Costa in direzione di Colle Alta, o del Borgo, ovvero la parte più elevata di Colle Val d’Elsa, dove abita Memmo. È un cammino lento, intervallato da momenti pensosi e sigarette, con un vago sentore sveviano che talora si stempera nel compiacimento. Anche la lingua, peraltro tersa e godibile in tutto il romanzo, si mostra a tratti ciondolante – nel tentativo, forse, di corrispondere all’incedere, altrettanto faticoso, del pensiero – e, soprattutto, fin da subito oscillante tra un registro formale e, anzi, “notarile” (questa è la professione del narratore) e guizzi che, invece, sfiorano i territori della misantropia e del cinismo, ma senza mai accomodarvisi.
Non è affatto una posa, in una narrazione che si riconosce gradualmente, fino alla chiara esplicitazione finale, come dispositivo teatralizzato: pur non volendo ad ogni costo rintracciare la lingua del poeta in quella del narratore, è pur vero che alcuni elementi tra quelli citati – insieme a una fascinazione, naturalmente non epigonica, per il crepuscolarismo, che si risolve forse nella tematizzazione più chiara e banale: la narrazione occupa tutta una giornata, interrompendosi quando il narratore è sulla via del ritorno, appunto al crepuscolo – e una circostanza aneddotica (anche Paolo Maccari è nato a Colle Val d’Elsa, nel 1975) potrebbero indurre a ipotizzare non tanto e non solo una narrazione autobiografica, quanto una composita unità d’intenti nella sua opera in versi e in prosa.
In fondo, per un Maccari saggista che si è soffermato in primo luogo sull’opera di Bartolo Cattafi e anche di Dino Campana, il punto di riferimento principale può essere colto nella narrativa di un altro senese del primo Novecento, Federigo Tozzi, capace di narrare una crisi sociale e culturale profonda attraverso ambientazioni provinciali simili a quella adottata anche da Maccari. Se in Tozzi si trattava del conflitto tra gli antichi valori contadini e quelli di una piccola borghesia cittadina gretta e ipocrita, per Maccari il conflitto è invece interno alla borghesia di provincia del secondo Novecento, e ripercorre l’apogeo e il declino della piccola e media impresa.
Si tratta di una crisi strutturale che riverbera ancora nel presente – la Ballata è ambientata nei primi anni del ventunesimo secolo – ma per Maccari sembra richiedere innanzitutto riferimenti letterari del primo Novecento (segnati, beninteso, dalla carica dirompente, per alcuni versi ancora efficace, del modernismo) per tentare un’interpretazione che, tuttavia, si rivela a più riprese sfuggente se non anche traditrice. Ed è con la potenza, anche formale, di questa inattualità che questa Ballata di Memmo e del Biondo, che è in fondo la riproposizione di una ballata di padri e figli – figure simboliche che attraversano la società, e dunque anche il piccolo mondo letterario, specie poetico –, si propone oggi come gioiello narrativo: fuori dai canoni correnti, eppure tutto dentro al canone.