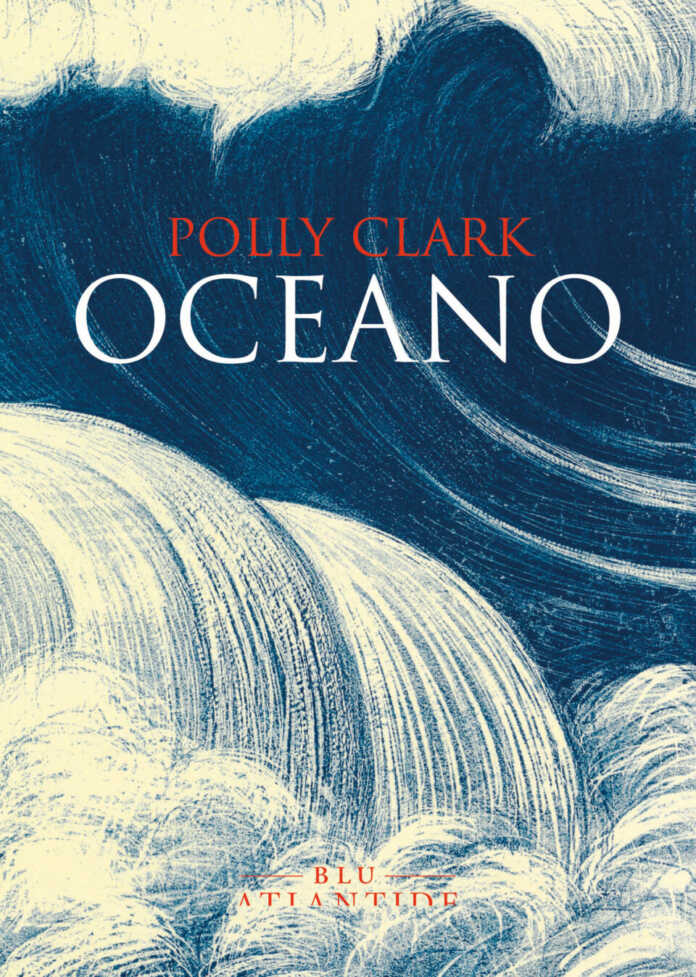Il trauma ci getta in un mare in tempesta da cui possiamo salvarci solo se rinunciamo a chi siamo stati per abbracciare chi siamo nel presente. Lo sa bene Polly Clark, canadese ormai trapiantata a Londra, che abita in una barca sul Tamigi, già autrice di successo con raccolte di poesie e opere di narrativa; ce lo ricorda attraverso la voce di Helen in Oceano, il suo nuovo romanzo pubblicato da Edizioni di Atlantide nella traduzione di Federica Bigotti.
Helen percorre gli spazi affollati, umani, della capitale inglese in una vita in apparenza perfetta: ha un marito dalla bellezza carismatica e un figlio, aspetta un altro bambino e insegna in una scuola popolata da ragazze e ragazzi da ambienti difficili, di cui si occupa con eccessivo fare materno e creatività. Fin dalle prime pagine, però, Helen confessa l’inquietudine di perdere l’amore di Frank, la sua certezza, e si definisce in primis come trofeo del suo sposo. Un malessere difficilmente confessato a sé stessa e al mondo, almeno finché l’esistenza della protagonista non viene sconvolta da un attentato nella metro londinese, il trauma che spezza il suo tempo in un prima e in un dopo.
Nel tempo del dopo, Helen mal si adatta ai panni di moglie di un uomo perfetto, di madre di un bambino sempre più risucchiato dal mondo digitale, di insegnante in mezzo alla solitudine di tanti adolescenti. C’è solo spazio per l’ossessione nei confronti di James, il suo salvatore: lui che ha rischiato di morire per proteggerla, ha saputo accogliere la sua paura e farla sentire comunque al sicuro. Pensare a James, scrivergli lettere mai spedite, cercarlo – sembra l’inizio di una storia d’amore, invece è la rinascita della fame di libertà, e soprattutto di una struggente nostalgia della giovinezza passata con Frank sulla barca Innisfree, in un mare aperto e senza confini.
Clark avrebbe potuto adagiarsi sul registro della malinconia, sceglie invece una direzione vertiginosa, un ritmo di continui colpi di scena, restituendo le diverse modalità di reazione ai traumi senza trascurare mai una vena surreale e ironica. Prigioniera restia a trovare un modo definitivo per liberarsi, Helen accetta la proposta di Frank di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare daccapo sulla Innisfree assieme al figlio Nicholas e a Sindi, un’ex-allieva della sua scuola che hanno preso in affidamento, il simbolo più viscerale di quel futuro scivolato via.
Nella quotidianità condivisa tra pericoli e ambienti ristretti emerge con potenza l’impossibilità di tornare indietro: Helen non è più la ragazza spensierata che imparò con Frank ad andare in barca né la donna capace di adeguarsi alle necessità della loro relazione adulta. Helen e Frank si sono amati, la loro coppia funziona ancora negli squarci di passato riportati a galla dalla Innisfree, eppure la frattura si allarga, tra gli scheletri dei silenzi e delle omissioni che hanno accumulato in anni e anni di matrimonio. E allora rimangono rabbia, recriminazioni, promesse infrante, perché “non c’è luogo più urgente, più denso di vita, dello spazio in cui l’amore si arrende”.
Clark lascia la sua protagonista gradualmente – e brutalmente – da sola, la mette di continuo alla prova per costringerla a salvarsi dalla tempesta, in senso metaforico e fisico, e abbandonare la dimensione allucinatoria in cui si è rinchiusa. Questo significa affrontare la spietatezza della natura, congedarsi dall’illusione di tanti ritorni desiderati e maturare la consapevolezza che “ci sono più vite dentro una stessa vita”. Vite vissute, autentiche, ma non fatte per durare in eterno, per esistere in un’unica realtà.