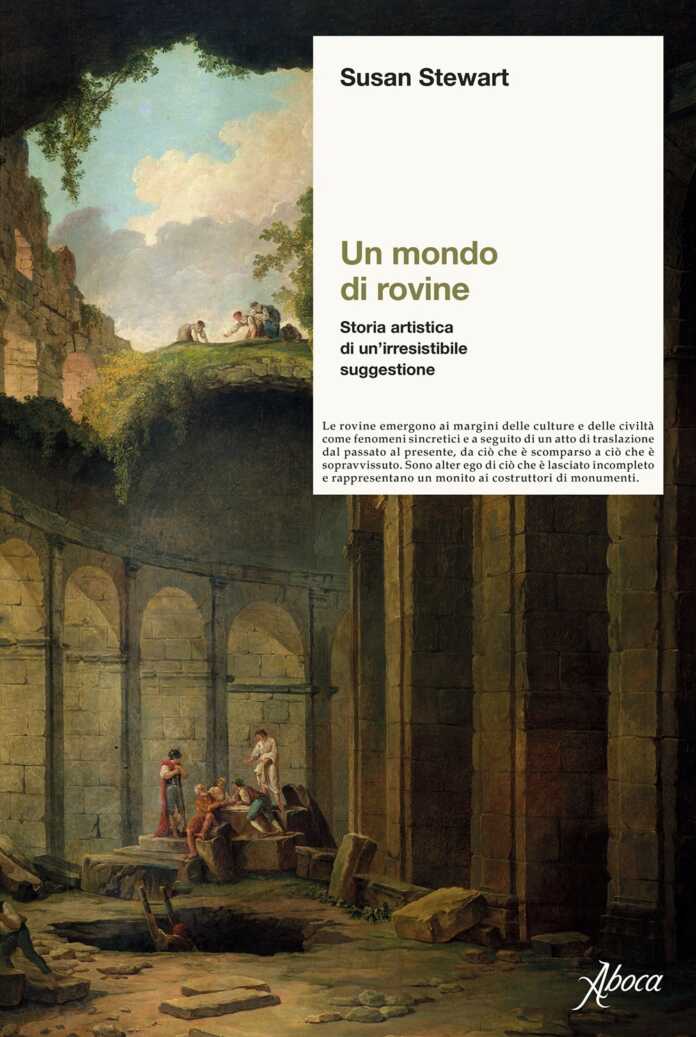Fate questa prova. Cercare “Consonno” su Instagram: sarete immediatamente sommersi di reel con decine di migliaia di like, che vi inviteranno ad esplorare i ruderi della “Las Vegas lombarda” costruita negli anni ’60 alle porte di Milano e ormai abbandonata da decenni. Nel corso del tempo, la natura e un’armata di street artist l’hanno completamente trasformata, affermandola come una meta obbligata del turismo Urbex (urban exploration) nel Nord Italia. Se ancora avanzate dei dubbi sul fascino postmodern delle vestigia, fate un salto sul canale youtube @UrbexSquad dell’infaticabile team che da anni si introduce all’interno di ville abbandonate e fabbricati fatiscenti, e abbandonarvi al piacere che la pornografia delle rovine assicura a milioni di appassionati. Un piacere che, come già confessava Henry James, “potrebbe denunciare la premessa di una certa dose di perversione”.
Troviamo questa citazione all’interno di Un mondo di rovine, il poderoso volume illustrato che Susan Stewart, critica letteraria e docente dell’Università di Princeton, volge a indagare il significato delle rovine in oltre duemila anni di arte e cultura occidentale. Quanto alle citazioni, va detto che il libro ce ne riserva un vero florilegio, anche grazie alla passione dell’autrice per le ampie ed erudite digressioni che la portano, ad esempio, a dedicare un intero capitolo alle ninfe sessualmente inquiete che, in concorrenza con la verginità mariana, si ritrovano in tanti paesaggi con rovine. Qui ne scegliamo tre, le prime due di un filosofo e di uno dei massimi storici dell’arte che, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, si sono occupati delle rovine dal punto di vista della modernità, che si affermava allora, per la prima volta, anche nel dibattito sulla conservazione dei monumenti e sul loro valore storico patrimoniale. Eccole.
“La natura ha fatto dell’opera d’arte il materiale della sua creazione, proprio come in precedenza d’arte si è servita della natura come materia prima” (Georg Simmel).
“Nelle opere umane recenti i segni del fluire del tempo (decadenza prematura) disturbano, nello stesso modo in cui nelle opere antiche (restauri appariscenti) ci irritano i segni di un nuovo divenire” (Alois Riegl).
Definitivo, resta invece il giudizio lapidario di Diderot: “Affinché un palazzo sia un oggetto di interesse, lo si deve distruggere”.
Il punto di vista di Stewart riguardo alle rovine è decisamente meno cinico. Quando ci confrontiamo con esse, osserva, “incontriamo la presenza in cammino verso l’assenza”. Una storia forse destinata a ripetersi all’infinito perché “È come se ogni generazione disimparasse nuovamente la lezione dell’inevitabile connessione tra l’esistenza dei monumenti e la rovina”.
Una delle cose che ho imparato leggendo questo libro è che l’affermazione della cristianità porta inizialmente a percepire come “rovine” anche le montagne, avvertite come irsute imperfezioni nella liscia compiutezza di un Creato altrimenti armonioso. Un’imperfezione in ultima analisi associata alla Caduta e alla cacciata dal giardino dell’Eden. Se ci avete mai fatto caso, nel racconto biblico le montagne sono spesso presentate come luoghi tragicamente trasformativi e location di drammatici sacrifici. L’Umanesimo attenua il pregiudizio riguardo alle rovine che, sopraffatte dalla forza della natura e del decreto umano, si prestano ora a un viaggio nel tempo e nello spazio. Tra le rovine, vengono meno anche i confini tra interno ed esterno di un palazzo, la cui struttura invisibile, impiegata da un costruttore geniale, si rivela ora finalmente dietro al disfacimento dei marmi e della facciata. D’altro canto, con la diffusione della stampa, l’illustrazione del ’500 presenta un’inedita ricchezza di dettagli architettonici e annotazioni, declinando anche le rovine del passato al tempo presente, con l’inserimento nello staffage di figure della contemporaneità. Nella pittura i ruderi fanno da sfondo anche alle scene della Natività di Cristo, che secondo una leggenda sarebbe stata simultanea al crollo del Tempio di Gerusalemme. Ma è a partire dall’Illuminismo, che si consolida nelle tendenze dell’arte anche il valore estetico delle rovine.
E parlare di rovine significa parlare di Roma. Come osserva l’autrice “La pratica del Grand Tour nel XVIII secolo (..) e la centralità di Roma nel discorso sulle rovine si deve forse anche al fatto che Roma fu distrutta numerose volte-da terremoti inondazioni incendi oltre che dalla violenza e dall’incuria umana-e ristrutturata altrettante volte”. Con Piranesi (1720-78), a cui Stewart dedica un intero capitolo, le rovine diventano il terreno di una riproduzione prolifica, rivolte alla spazialità dell’artificio almeno quanto alla scoperta di un passato riaffiorante. Immaginazione e misura, archeologia e futuro concorrono alla visione che l’architetto e incisore veneziano infonde ai mondi tridimensionali delle Carceri e dei Grotteschi. Con Piranesi e Rolli l’Accademia dell’Arcadia esercita un’influenza che determinerà la ricezione del paesaggio italiano di Goethe e di una generazione di architetti-viaggiatori come Robert Adam e Charles-Louis Clérisseau.
Non molto diversamente, in fondo, 2000 anni prima di loro i giovani dell’élite romana che si recavano ad Atene e a Rodi, fantasticando della cultura greca, si confrontarono a loro volta con le rovine di un’altra classicità. Alla fine, i romani, che si ritenevano particolarmente degni di essere ricordati, svilupparono soprattutto il monumento come veicolo della fama e come media lapidario rivolto ai posteri, e una scrittura monumentale (scriptura monumentalis) opponibile alla damnatio memoriae e alla opinabile abitudine di decapitare le statue dei nemici. Le spoglie dei monumenti saranno infatti, a loro volta, riassemblate dal vincitore di turno, con un effetto di sincretismo architettonico, come nel caso di San Giovanni in Laterano, la prima basilica, o dell’arco di Costantino creato dai cristiani utilizzando i resti del foro di Traiano.
Su tutto campeggia l’immagine della Torre di Babele che nell’immaginario del Vecchio Testamento proietta un’insolita forma di punizione allorquando l’ira di Dio non si manifesta per una volta attraverso l’apocalisse del fuoco o dell’acqua ma la confusione delle menti e dei linguaggi. La metafora della torre, assimilata alle sembianze architettoniche del Colosseo, assume successivamente un carattere morale e allegorico, in particolare del ’500 nordico e cosmopolita (con Bruegel e altri) all’indomani della Sacco di Roma del 1527 Perché sempre a Roma si torna, dopotutto.
William Blake e William Wordsworth, compongono con Piranesi la Sacra Trinità delle Rovine che Stewart pone ai vertici di un’indagine affascinante e poderosa che resta, ben inteso, un’indagine sull’umanità attraverso le pietre che si è lasciata alle spalle. Compresa quella parte dell’umanità che sono le persone propriamente “rovinate”, cioè, costrette dall’indigenza e dalla povertà materiale, molto spesso a vivere negli anfratti delle rovine vere e proprie. Figurando a loro volta, ai margini delle stampe, come parte della loro stessa rappresentazione.