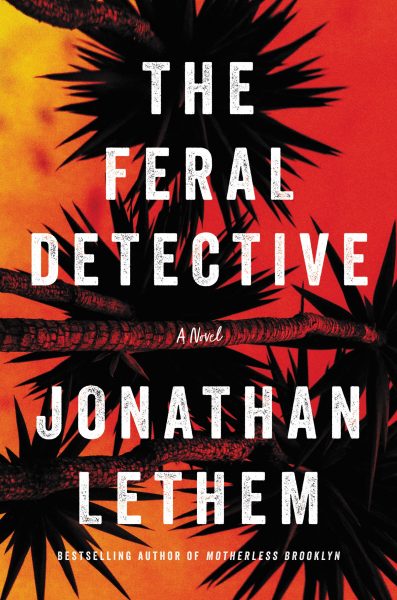 Sinceramente, non so se il titolo dell’ultimo romanzo di Jonathan Lethem, The Feral Detective (Harper Collins, 2018), verrà veramente reso così quando verrà tradotto (spero presto). Del resto feral vuole anche dire brutale, feroce, selvaggio. E tutti i significati dell’aggettivo s’adattano al personaggio di Charles Heist, che giustifica il titolo del romanzo, nonostante non si possa dire che ne sia veramente il protagonista. Io narrante della vicenda è invece una donna, Phoebe Siegler, che a tutti gli effetti potrebbe essere l’antitesi di Charles. Lui è laconico se non taciturno; lei è logorroica al limite dell’isteria. Lui californiano, lei newyorkese. Lui vive nell’Inland Empire, una zona semiselvaggia nell’entroterra; lei è il classico animale metropolitano, al punto che le montagne della California e il cielo non schermato dai grattacieli la mettono a disagio. Lui è un uomo d’azione, un investigatore privato specializzato nel recuperare ragazzi e ragazze scappati di casa e magari finiti dentro sette e culti dei quali lo stato sul Pacifico non è mai a corto; lei una giornalista del New York Times stravolta per la vittoria elettorale di Trump. Lui un tipo selvatico e schivo; lei un’intellettuale sofisticata e loquace. Lui è uscito da un film dei fratelli Coen; lei da una pellicola di Woody Allen.
Sinceramente, non so se il titolo dell’ultimo romanzo di Jonathan Lethem, The Feral Detective (Harper Collins, 2018), verrà veramente reso così quando verrà tradotto (spero presto). Del resto feral vuole anche dire brutale, feroce, selvaggio. E tutti i significati dell’aggettivo s’adattano al personaggio di Charles Heist, che giustifica il titolo del romanzo, nonostante non si possa dire che ne sia veramente il protagonista. Io narrante della vicenda è invece una donna, Phoebe Siegler, che a tutti gli effetti potrebbe essere l’antitesi di Charles. Lui è laconico se non taciturno; lei è logorroica al limite dell’isteria. Lui californiano, lei newyorkese. Lui vive nell’Inland Empire, una zona semiselvaggia nell’entroterra; lei è il classico animale metropolitano, al punto che le montagne della California e il cielo non schermato dai grattacieli la mettono a disagio. Lui è un uomo d’azione, un investigatore privato specializzato nel recuperare ragazzi e ragazze scappati di casa e magari finiti dentro sette e culti dei quali lo stato sul Pacifico non è mai a corto; lei una giornalista del New York Times stravolta per la vittoria elettorale di Trump. Lui un tipo selvatico e schivo; lei un’intellettuale sofisticata e loquace. Lui è uscito da un film dei fratelli Coen; lei da una pellicola di Woody Allen.
Eppure questi due personaggi agli antipodi del paesaggio geografico e umano degli Stati Uniti s’incontrano e finiscono col cooperare, non senza fraintendimenti e sospetti, perché Phoebe è venuta in California, in un ambiente per lei del tutto alieno e vagamente minaccioso, nel tentativo di recuperare Arabella, la figlia della sua migliore amica, recatasi sulla west coast per motivi di studio ma poi sparita dal suo alloggio nel college. Un’assistente sociale consiglia a Phoebe di rivolgersi a Heist per rintracciare la ragazza; ed è così che questa improbabile coppia si trova impegolata in un’indagine che li porterà prima sulle montagne della California poi nel deserto del Mojave, nel bel mezzo di comunità primitiviste uscite dalla civiltà (o quasi); un’indagine che, nella migliore tradizione dell’hard-boiled, incappa ben presto in qualche cadavere, e metterà a rischio la vita dei due protagonisti. E come nei migliori hard-boiled, è la voce narrante del protagonista con la sua ironia e il suo uso barocco dell’inglese d’America a caratterizzare il testo – però, data la laconicità del vero detective, tocca a Phoebe, con la sua voce da intellettuale newyorkese, di raccontare la storia e fare battute: come se nel Grande sonno la voce fuori campo fosse quella di Lauren Bacall (o meglio di Diane Keaton) e non quella di Humphrey Bogart. Ribaltamento mica da poco.
 Insomma, Jonathan Lethem ha scritto un altro giallo. L’aveva già fatto anni fa, precisamente nel 1999, quando pubblicò Brooklyn senza madre (Bompiani, 2014), tradotto già l’anno dopo da Tropea con l’orripilante titolo Testadipazzo; quel giallo metropolitano e stralunato, incentrato sul detective dilettante Lionel Essrog, appassionato di Prince e affetto dalla sindrome di Tourette, segnava una svolta importante nella carriera letteraria di Lethem. Fino ad allora, infatti, lo scrittore newyorkese emigrato a Berkeley per motivi di studio aveva pubblicato una serie di sorprendenti romanzi di fantascienza, surreali e ironici, animati da una vena visionaria e da una prosa originale e barocca: Concerto per archi e canguro (Bompiani, 2013), Amnesia moon (minimum fax, 2003), Ragazza con paesaggio (Tropea, 2006), più una serie di racconti e un campus novel che faceva un po’ troppo il verso a Don DeLillo, Oggetto amoroso non identificato (Tropea, 1999). (Ci terrei a far notare che il primo a essere pubblicato fu proprio il romanzo più debole di questa prima fase della produzione di Lethem, nonostante nel 1999 questi quattro romanzi fossero già usciti tutti in America). Brooklyn senza madre segnava una sorta di cesura, l’abbandono della fantascienza, il ritorno a New York, città di nascita di Lethem. Back to the roots, si potrebbe dire.
Insomma, Jonathan Lethem ha scritto un altro giallo. L’aveva già fatto anni fa, precisamente nel 1999, quando pubblicò Brooklyn senza madre (Bompiani, 2014), tradotto già l’anno dopo da Tropea con l’orripilante titolo Testadipazzo; quel giallo metropolitano e stralunato, incentrato sul detective dilettante Lionel Essrog, appassionato di Prince e affetto dalla sindrome di Tourette, segnava una svolta importante nella carriera letteraria di Lethem. Fino ad allora, infatti, lo scrittore newyorkese emigrato a Berkeley per motivi di studio aveva pubblicato una serie di sorprendenti romanzi di fantascienza, surreali e ironici, animati da una vena visionaria e da una prosa originale e barocca: Concerto per archi e canguro (Bompiani, 2013), Amnesia moon (minimum fax, 2003), Ragazza con paesaggio (Tropea, 2006), più una serie di racconti e un campus novel che faceva un po’ troppo il verso a Don DeLillo, Oggetto amoroso non identificato (Tropea, 1999). (Ci terrei a far notare che il primo a essere pubblicato fu proprio il romanzo più debole di questa prima fase della produzione di Lethem, nonostante nel 1999 questi quattro romanzi fossero già usciti tutti in America). Brooklyn senza madre segnava una sorta di cesura, l’abbandono della fantascienza, il ritorno a New York, città di nascita di Lethem. Back to the roots, si potrebbe dire.
 Non a caso la successiva opera dello scrittore di Gowanus (il quartiere di Brooklyn dove è nato) sarebbe stata ben più voluminosa delle precedenti e dalla marcata vena autobiografica, La fortezza della solitudine (ora Bompiani, 2016, ma transitato per Tropea e Il Saggiatore): è difficile non vedere nel protagonista della storia, Dylan Ebdus, un alter ego di Lethem; come lui ha un padre artista d’avanguardia e una madre attivista politica, come lui cresce in un quartiere prevalentemente afroamericano dove i bianchi sono la minoranza (che è evidentemente Gowanus); come lui perde la madre presto (nel romanzo perché lascia la famiglia, nella vita reale perché Judith Frank Lethem morì di tumore quando il figlio aveva tredici anni); come lui inizia gli studi in un college di lusso nel New England, ma lo abbandona per andarsene a Berkeley, in California (che lo scrittore raggiunse con l’autostop). E come Lethem, Dylan è appassionato di musica, talché il romanzo è una cavalcata nei suoni degli anni Settanta: dal soul e funky, alla rivoluzione punk, alla new wave (Talking Heads e CBGB in testa), alle origini del rap (tra i cui pionieri c’è proprio il fratello di Lethem, Blake, allora noto come Lord Hopscotch): la traversata di un decennio epico della musica bianca e nera, col rap a segnare il momento in cui le due tradizioni confluiscono.
Non a caso la successiva opera dello scrittore di Gowanus (il quartiere di Brooklyn dove è nato) sarebbe stata ben più voluminosa delle precedenti e dalla marcata vena autobiografica, La fortezza della solitudine (ora Bompiani, 2016, ma transitato per Tropea e Il Saggiatore): è difficile non vedere nel protagonista della storia, Dylan Ebdus, un alter ego di Lethem; come lui ha un padre artista d’avanguardia e una madre attivista politica, come lui cresce in un quartiere prevalentemente afroamericano dove i bianchi sono la minoranza (che è evidentemente Gowanus); come lui perde la madre presto (nel romanzo perché lascia la famiglia, nella vita reale perché Judith Frank Lethem morì di tumore quando il figlio aveva tredici anni); come lui inizia gli studi in un college di lusso nel New England, ma lo abbandona per andarsene a Berkeley, in California (che lo scrittore raggiunse con l’autostop). E come Lethem, Dylan è appassionato di musica, talché il romanzo è una cavalcata nei suoni degli anni Settanta: dal soul e funky, alla rivoluzione punk, alla new wave (Talking Heads e CBGB in testa), alle origini del rap (tra i cui pionieri c’è proprio il fratello di Lethem, Blake, allora noto come Lord Hopscotch): la traversata di un decennio epico della musica bianca e nera, col rap a segnare il momento in cui le due tradizioni confluiscono.
Comunque, non è a New York che Lethem diventa scrittore, ma sull’altra costa degli Stati Uniti; in California. Fino a poco prima della sua emigrazione verso ovest aveva avuto l’ambizione di diventare un pittore, come il padre; ma proprio a Berkeley il giovane Jonathan scopre che gli interessano più le parole, e soprattutto s’imbatte in una sorta di spirito guida assolutamente californiano, lo scrittore che l’avrebbe più influenzato agli inizi della sua carriera: Philip Kindred Dick.
Di Dick si può dire tranquillamente che non è semplicemente uno scrittore californiano; è un uomo che ha scritto la California, come è riuscito solo forse a Raymond Chandler, a Nathanael West, a James Ellroy, a Steven Erickson. Berkeley è dove Dick cominciò gli studi universitari, senza mai completarli, e dove lavorò come commesso in un negozio di dischi e radio – commesso come Lethem, che però si guadagnava da vivere (lui lettore compulsivo) in negozi di libri usati, sempre nella stessa cittadina. E a Berkeley il newyorkese emigrato entra in contatto con la Philip Kindred Dick Society, l’associazione dei primi cultori dell’autore di Ubik e di 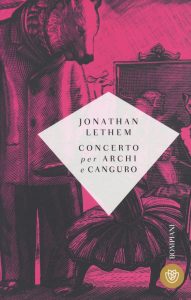 VALIS, allora capitanata da Paul Williams, che stava facendo stampare tutti i manoscritti inediti trovati tra le carte di Dick. Era l’epoca eroica della riscoperta di uno scrittore morto nel 1982, poco prima che Blade Runner lo facesse conoscere anche al di fuori del ghetto fantascientista. Lethem visse quell’epoca pionieristica, e Dick gli entrò nella pagina in modo clamoroso, basti leggere Concerto per archi e canguro, Amnesia Moon e Ragazza con paesaggio per convincersi. Il primo vede animali parlanti convivere con gli umani e suscita echi di Ma gli androidi sognano pecore elettriche? anche per il mix di giallo e fantascienza, in un futuro non tanto remoto dove ricordare diventa un reato; nel secondo romanzo l’omaggio al Gran Californiano è dichiarato e palese, con una sinossi di Cronache del dopobomba sfacciatamente innestata nella trama; e Ragazza con paesaggio prende dalle Tre stimmate di Palmer Eldritch, riproponendo una terra surriscaldata che sta diventando inabitabile, e da Noi marziani nella parte ambientata sul pianeta degli Archbuilders, immagine anamorfica del wild west, dove i rapporti tra uomini e alieni echeggiano quelli tra americani bianchi e nativi. C’è anche, a leggere tra le righe, John Wayne.
VALIS, allora capitanata da Paul Williams, che stava facendo stampare tutti i manoscritti inediti trovati tra le carte di Dick. Era l’epoca eroica della riscoperta di uno scrittore morto nel 1982, poco prima che Blade Runner lo facesse conoscere anche al di fuori del ghetto fantascientista. Lethem visse quell’epoca pionieristica, e Dick gli entrò nella pagina in modo clamoroso, basti leggere Concerto per archi e canguro, Amnesia Moon e Ragazza con paesaggio per convincersi. Il primo vede animali parlanti convivere con gli umani e suscita echi di Ma gli androidi sognano pecore elettriche? anche per il mix di giallo e fantascienza, in un futuro non tanto remoto dove ricordare diventa un reato; nel secondo romanzo l’omaggio al Gran Californiano è dichiarato e palese, con una sinossi di Cronache del dopobomba sfacciatamente innestata nella trama; e Ragazza con paesaggio prende dalle Tre stimmate di Palmer Eldritch, riproponendo una terra surriscaldata che sta diventando inabitabile, e da Noi marziani nella parte ambientata sul pianeta degli Archbuilders, immagine anamorfica del wild west, dove i rapporti tra uomini e alieni echeggiano quelli tra americani bianchi e nativi. C’è anche, a leggere tra le righe, John Wayne.
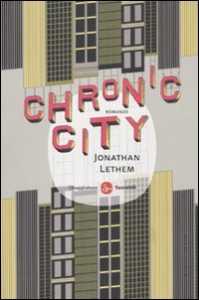 Se Lethem nasce come scrittore professionista in California, allora Brooklyn senza madre va letto come il momento in cui decide di chiudere il suo apprendistato e distaccarsi in qualche modo da quello che fino ad allora è stato il suo spirito guida, uscendo dalla fantascienza e tentando il giallo (che però già era presente, come s’è detto, in Concerto per archi e canguro…), lasciando la costa occidentale e tornando nel suo borough natale, Brooklyn, orgogliosamente sbandierato già nel titolo. Da allora in poi Lethem sembra volersi accreditare come romanziere residente della Grande mela. Dopo La fortezza della solitudine è la volta di Chronic City (Il Saggiatore, 2010), che segue una strampalata coppia di personaggi, l’artista da strada Perkus Tooth e l’attore in declino Chase Insteadman, in una New York post-11 settembre, col primo a bombardare il secondo con le sue eccentriche teorie sulla cultura e l’identità americana, l’arte, la musica, il cinema e tutto il resto dell’universo – soprattutto l’idea ossessiva che per capire gli Stati Uniti bisogna capire veramente Marlon Brando. Sono un po’ Vladimiro ed Estragone, questi due, o la versione postmodernista del dottor Johnson e del suo biografo Boswell; sembrano quasi una coppia di comici, e – a ben guardare – ricordano un po’ anche Phil Dick e Horselover Fat, i due personaggi complementari e speculari del dickiano VALIS. Insomma, dimenticare la California e il suo più originale cantore non è poi così facile; neanche a Manhattan.
Se Lethem nasce come scrittore professionista in California, allora Brooklyn senza madre va letto come il momento in cui decide di chiudere il suo apprendistato e distaccarsi in qualche modo da quello che fino ad allora è stato il suo spirito guida, uscendo dalla fantascienza e tentando il giallo (che però già era presente, come s’è detto, in Concerto per archi e canguro…), lasciando la costa occidentale e tornando nel suo borough natale, Brooklyn, orgogliosamente sbandierato già nel titolo. Da allora in poi Lethem sembra volersi accreditare come romanziere residente della Grande mela. Dopo La fortezza della solitudine è la volta di Chronic City (Il Saggiatore, 2010), che segue una strampalata coppia di personaggi, l’artista da strada Perkus Tooth e l’attore in declino Chase Insteadman, in una New York post-11 settembre, col primo a bombardare il secondo con le sue eccentriche teorie sulla cultura e l’identità americana, l’arte, la musica, il cinema e tutto il resto dell’universo – soprattutto l’idea ossessiva che per capire gli Stati Uniti bisogna capire veramente Marlon Brando. Sono un po’ Vladimiro ed Estragone, questi due, o la versione postmodernista del dottor Johnson e del suo biografo Boswell; sembrano quasi una coppia di comici, e – a ben guardare – ricordano un po’ anche Phil Dick e Horselover Fat, i due personaggi complementari e speculari del dickiano VALIS. Insomma, dimenticare la California e il suo più originale cantore non è poi così facile; neanche a Manhattan.
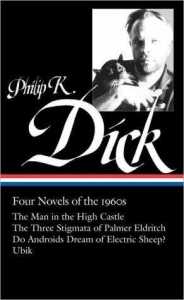 Del resto proprio in quel periodo Lethem pagava il suo debito con zio Phil, convincendo la prestigiosa Library of America a pubblicare un volume contenente quattro romanzi di Dick – perché, e diciamocelo, Lethem è uno che nel mondo dell’editoria si sa muovere molto bene, vedi anche la sua instancabile attività di saggista letterario, di curatore di antologie, di prefatore. Il nostro Jonathan è un autentico grafomane, e se si mettono insieme le sue raccolte di racconti, i saggi e i vari scritti occasionali ne viene fuori una massa di materiale decisamente sorprendente per uno scrittore che ha compiuto da non molto cinquant’anni. E ha anche la mano felice, per così dire: il primo volume della Library of America dedicato a Dick (che in origine avrebbe dovuto essere l’unico), contenente L’uomo nell’alto castello, Ubik, Le tre stimmate di Palmer Eldritch e Ma gli androidi sognano pecore elettriche? non vende, stravende, più dei Grandi Classici della Letteratura Americana. Per cui a questa prima raccolta nel seguono altre due, anche queste con buon successo commerciale, incoraggiando così Lethem a sponsorizzare la pubblicazione di parte dell’Esegesi dickiana, curata da Pamela Jackson, uscita da noi per i tipi di Fanucci e accuratamente tradotta da Maurizio Nati. Un’impresa non da poco, tenendo conto che il volume consiste in una selezione di appunti, annotazioni, brevi scritti e altri materiali che Dick aveva buttato giù freneticamente dal 1974 (anno delle ormai celebri visioni di febbraio-marzo) fino al giorno della sua morte; uno zibaldone eterogeneo che non era assolutamente stato concepito per la pubblicazione. Eppure Lethem riesce a farlo uscire in una splendida edizione rilegata. Il ragazzo, bisogna ammetterlo, ci sa fare.
Del resto proprio in quel periodo Lethem pagava il suo debito con zio Phil, convincendo la prestigiosa Library of America a pubblicare un volume contenente quattro romanzi di Dick – perché, e diciamocelo, Lethem è uno che nel mondo dell’editoria si sa muovere molto bene, vedi anche la sua instancabile attività di saggista letterario, di curatore di antologie, di prefatore. Il nostro Jonathan è un autentico grafomane, e se si mettono insieme le sue raccolte di racconti, i saggi e i vari scritti occasionali ne viene fuori una massa di materiale decisamente sorprendente per uno scrittore che ha compiuto da non molto cinquant’anni. E ha anche la mano felice, per così dire: il primo volume della Library of America dedicato a Dick (che in origine avrebbe dovuto essere l’unico), contenente L’uomo nell’alto castello, Ubik, Le tre stimmate di Palmer Eldritch e Ma gli androidi sognano pecore elettriche? non vende, stravende, più dei Grandi Classici della Letteratura Americana. Per cui a questa prima raccolta nel seguono altre due, anche queste con buon successo commerciale, incoraggiando così Lethem a sponsorizzare la pubblicazione di parte dell’Esegesi dickiana, curata da Pamela Jackson, uscita da noi per i tipi di Fanucci e accuratamente tradotta da Maurizio Nati. Un’impresa non da poco, tenendo conto che il volume consiste in una selezione di appunti, annotazioni, brevi scritti e altri materiali che Dick aveva buttato giù freneticamente dal 1974 (anno delle ormai celebri visioni di febbraio-marzo) fino al giorno della sua morte; uno zibaldone eterogeneo che non era assolutamente stato concepito per la pubblicazione. Eppure Lethem riesce a farlo uscire in una splendida edizione rilegata. Il ragazzo, bisogna ammetterlo, ci sa fare.
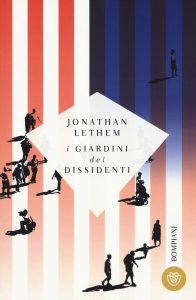 A questo punto esce il quarto romanzo newyorkese del nostro, I giardini dei dissidenti (Bompiani, 2015), e qualcosa decisamente s’inceppa. Le opinioni su quest’opera imponente, che racconta la storia di tre generazioni di attivisti politici a partire dalla comunista Rose Zimmer, sono divergenti; personalmente, dopo il primo capitolo, scritto magistralmente, nel quale si racconta il processo interno cui viene sottoposta Rose dai suoi compagni di partito per aver stretto una relazione adulterina con un tenente di polizia di colore, la storia alterna momenti affascinanti a pagine in cui il virtuosismo verbale va a detrimento della narrazione. Mi è sembrato che il romanzo soffra dello stesso difetto di Oggetto amoroso non identificato, solo che qui non abbiamo Lethem che fa il verso a DeLillo, ma Lethem che pare imitare Lethem. Potenzialmente, questa storia dei dissidenti americani dagli anni Quaranta a Occupy Wall Street avrebbe potuto essere qualcosa di straordinario; ma la ciambella mi sembra riuscita senza il proverbiale buco. Rose, che avrebbe dovuto essere il personaggio chiave del romanzo, resta una figura vaga: si continua a parlare della sua attività politica a Sunnyside Gardens, ma non la vediamo mai veramente in azione. Il suo amante Douglas Lookins rimane anche lui una figura solamente abbozzata, cosa irritante per il lettore che vorrebbe saperne di più, capire come ha vissuto la sua relazione con un’attivista politica bianca e per di più ebrea. In certi momenti Lethem sembra affrettarsi da una scena all’altra, come se non sapesse bene come riempire lo spazio, come collegare la successione degli eventi. E forse il mondo del marxismo americano (ma non solo) gli resta tutto sommato insufficientemente familiare; è faticosa anche la sua resa della Germania Est (nella quale se n’è andato il marito di Rose, Albert, e dove si reca loro figlia Miriam per cercare disperatamente di riallacciare un rapporto col padre).
A questo punto esce il quarto romanzo newyorkese del nostro, I giardini dei dissidenti (Bompiani, 2015), e qualcosa decisamente s’inceppa. Le opinioni su quest’opera imponente, che racconta la storia di tre generazioni di attivisti politici a partire dalla comunista Rose Zimmer, sono divergenti; personalmente, dopo il primo capitolo, scritto magistralmente, nel quale si racconta il processo interno cui viene sottoposta Rose dai suoi compagni di partito per aver stretto una relazione adulterina con un tenente di polizia di colore, la storia alterna momenti affascinanti a pagine in cui il virtuosismo verbale va a detrimento della narrazione. Mi è sembrato che il romanzo soffra dello stesso difetto di Oggetto amoroso non identificato, solo che qui non abbiamo Lethem che fa il verso a DeLillo, ma Lethem che pare imitare Lethem. Potenzialmente, questa storia dei dissidenti americani dagli anni Quaranta a Occupy Wall Street avrebbe potuto essere qualcosa di straordinario; ma la ciambella mi sembra riuscita senza il proverbiale buco. Rose, che avrebbe dovuto essere il personaggio chiave del romanzo, resta una figura vaga: si continua a parlare della sua attività politica a Sunnyside Gardens, ma non la vediamo mai veramente in azione. Il suo amante Douglas Lookins rimane anche lui una figura solamente abbozzata, cosa irritante per il lettore che vorrebbe saperne di più, capire come ha vissuto la sua relazione con un’attivista politica bianca e per di più ebrea. In certi momenti Lethem sembra affrettarsi da una scena all’altra, come se non sapesse bene come riempire lo spazio, come collegare la successione degli eventi. E forse il mondo del marxismo americano (ma non solo) gli resta tutto sommato insufficientemente familiare; è faticosa anche la sua resa della Germania Est (nella quale se n’è andato il marito di Rose, Albert, e dove si reca loro figlia Miriam per cercare disperatamente di riallacciare un rapporto col padre).
Che I giardini dei dissidenti segni un’impasse di Lethem ce lo dicono soprattutto i due romanzi successivi, ma soprattutto un dato biografico: lo scrittore torna in California, dove risiede attualmente, tenendo corsi di scrittura creativa al Pomona College. Se a spingerlo a tornare a ovest sia stata semplicemente un’opportunità lavorativa, oppure se il richiamo  del west abbia colpito ancora, non sta a noi dirlo. Di fatto il romanzo che segue I giardini dei dissidenti, e cioè Anatomia di un giocatore d’azzardo (La nave di Teseo, 2017) da un lato segna un ritorno in California, dall’altro, nella prima parte, ci mostra un personaggio di Lethem che esce dal perimetro degli Stati Uniti: infatti il protagonista, Alexander Bruno, è un giocatore professionista di backgammon, che campa sbaragliando a colpi di dadi ricchi appassionati di questo gioco, spostandosi continuamente da un hotel a cinque stelle all’altro nelle varie capitali del pianeta, inclusa Singapore. Per uno scrittore americanocentrico come Lethem è un cambiamento a dir poco epocale.
del west abbia colpito ancora, non sta a noi dirlo. Di fatto il romanzo che segue I giardini dei dissidenti, e cioè Anatomia di un giocatore d’azzardo (La nave di Teseo, 2017) da un lato segna un ritorno in California, dall’altro, nella prima parte, ci mostra un personaggio di Lethem che esce dal perimetro degli Stati Uniti: infatti il protagonista, Alexander Bruno, è un giocatore professionista di backgammon, che campa sbaragliando a colpi di dadi ricchi appassionati di questo gioco, spostandosi continuamente da un hotel a cinque stelle all’altro nelle varie capitali del pianeta, inclusa Singapore. Per uno scrittore americanocentrico come Lethem è un cambiamento a dir poco epocale.
Non riesco a non vedere in Alexander, che a un certo punto perde disastrosamente una partita cruciale di backgammon e una spropositata somma di danaro, ed entra in una crisi nera, aggravata dai sintomi di un tumore alle meningi, l’autoritratto di uno scrittore in crisi che si sta sforzando di reinventarsi e ritrovarsi. Non a caso Alexander scoprirà che l’unico neurochirurgo disposto a tentare di operarlo risiede California. La guarigione è a ovest? Non è impossibile, anche se per tutto c’è un prezzo da pagare, come scoprirà il giocatore in un finale nient’affatto avaro di sorprese decisamente amare, in un’atmosfera di pessimismo e squallore che, per Lethem, è una novità.
Va anche detto che, dopo tre romanzi decisamente voluminosi (La fortezza della solitudine, Chronic City e I giardini dei dissidenti), rispondenti alla maniacale ricerca da parte delle case editrici statunitensi del great American novel (come se non ce ne fossero già abbastanza…), con Anatomia di un giocatore d’azzardo Lethem torna a una misura che a mio modesto avviso gli è assai più congeniale, quella del romanzo da 200-250 pagine, come ai vecchi tempi; e sicuramente questo romanzo convince di più del precedente.
E se tiriamo le somme del percorso letterario del nostro autore, l’ultimo arrivato, The Feral Detective, ambientato anche questo in California, anche se c’è un breve tratto newyorkese (scusate se non spiego come mai, sarebbe criminale farlo), cerca di riconciliare gli opposti. Grazie all’absolute New Yorker Phoebe e al selvatico californiano Charles, i due poli immaginativi di Jonathan Lethem si scontrano ma s’incontrano anche; si cerca di gettare un ponte tra le due coste, di far dialogare est e ovest degli Stati Uniti, pur con tutte le loro differenze. Questo accade, forse non casualmente, proprio quando assistiamo al trionfo di Trump, eletto soprattutto coi voti di quello che californiani e abitanti della costa orientale chiamano il flyover, cioè tutto l’enorme territorio che sta tra le due coste, considerato – non senza un certo disprezzo – una sorta di spazio vuoto tra i due poli della vita economica e culturale nazionale. Quello spazio che ha votato il presidente col parrucchino: per contrastare il quale forse serve mettere insieme, come nel romanzo, l’estremo ovest inselvatichito e la sofisticata intellighenzia della Grande Mela.
Ma il percorso di Lethem si può anche leggere in un’altra chiave, con l’aiuto della bloomiana angoscia dell’influenza. Sarà pur vero che Lethem ha voluto controbattere la visione agonale, conflittuale della letteratura propria di Harold Bloom, in cui il rapporto tra scrittori diventa un duello (quello sì western) tra poeti forti, con i poeti deboli a costellare il terreno di cadaveri; non a caso ha pubblicato una raccolta di saggi intitolata L’estasi dell’influenza (Bompiani, 2013) che suona come una sfida al faraone della critica accademica americana. Però se uno ha presenti le genealogie della narrativa statunitense dal 1945 in poi, è difficile non vedere che un altro narratore ha alternato New York (nei cui pressi è nato e dove è cresciuto) e la California, aggiungendo alle due coste americane un autentico atlante mondiale di luoghi tra i più remoti e dimenticati. Parliamo ovviamente di Thomas Pynchon, che inizia il suo percorso narrativo con la New York post-beatnik di V., dove torna nell’ultimo romanzo, La cresta dell’onda, ma articolando tra questi due estremi un’affascinante trilogia californiana composta da L’incanto del lotto 49, Vineland e Vizio di forma. Forse ogni tanto Lethem si sentirà un po’ sotto l’ombra del suo ingombrante compaesano; o comunque ci dovrà fare i conti in qualche modo – cosa non proprio facilissima se sei americano e scrivi romanzi postmodernisti.
Bene, il nostro viaggio si ferma qui – per ora. Attendiamo di vedere la traduzione di The Feral Detective prima di dire altro su questo romanzo, che in fin dei conti come hard-boiled, per quanto eccentrico, funziona decisamente bene. Sicuramente si legge molto meglio de I giardini dei dissidenti; ed è già qualcosa.



