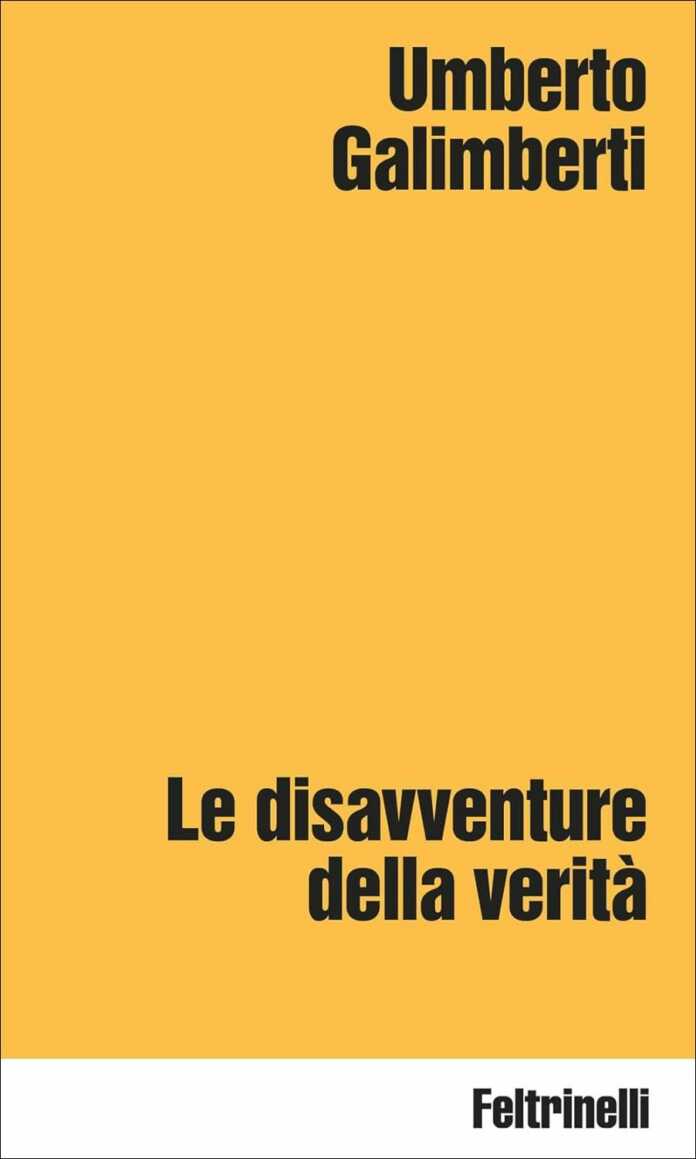Sono ali libere, per nulla ingombranti, quelle usate da Umberto Galimberti nel suo saggio concernente – vivaddio – i gradi di discrezione che si prende, nel corso delle epoche, la verità mentre esce dalla voce umana figlia (per lo più, quasi mai, o quasi sempre) del pensiero. Preferibile usare cautela quando si mette mano a una qualunque azione definita dalla (fin troppo) vivace esistenza umana. Come è bello aver chiaro quanto sia giusto definire “scoperta” l’aver di fronte l’essenza della “verità” senza che alcuno la insegni. Oggi che tutto è rappresentazione, Galimberti scopre gli inganni del populismo quando tenta, riuscendoci, a quanto pare, di compiere “tutto” tramite la persuasione.
Sono molte le voci – intese come termini o lemmi – in questo aureo libretto che definiscono il tempo attuale (“innominabile”, secondo Roberto Calasso), fissandoci una volta per tutte gli indirizzi verso cui stiamo andando a sbattere. Siamo liquidati nell’incontenibile diffusione dei media, una rete diventata “mondo” da cui ben difficilmente qualcuno riuscirà a stare “in disparte”. Il mondo come rappresentazione: è tutto lì. E per spiegarlo il filosofo mette in campo la genealogia della verità nel mondo classico e da lì ai secoli successivi e al contemporaneo. Platone, Socrate, i poeti greci, e il “fare” della tradizione ebraica, e la diversità dei significati delle parole nelle diverse lingue. Gli equivoci rimandati a ogni generazione da traduzione letteralmente “scorrette”. Quanto occorrerebbe puntare i riflettori su questo.
Galimberti poi ci imbarca sui testimoni del “sospetto”, Marx, Freud, Nietzsche, seguendo il filo della loro denuncia (messa in risalto da Paul Ricoeur) verso la persuasione diffusa che la verità sia davvero la verità. Come dire: ecco la misura dei danni apportati dalla falsa coscienza. Poi certo, Nietzsche va oltre, si chiede quanta verità possa osare un uomo. E come possa essere vile la cifra dell’errore. Da qui s’evolve il compito da assegnarsi, quello di liberare la verità dalle incrostazioni, né mai rinunciarvi.
È l’età della tecnica, e il virus della soddisfazione è pericolosamente vicino quanto l’allargamento del ventaglio dei mezzi tecnici verso qualsivoglia fine. La produzione ha i suoi effetti, lo si vede chiaramente. Si digita, non si pensa. Come esseri “antiquati”, che guardano pasolinianamente allo sviluppo anziché al progresso, Galimberti nel finale del suo saggio ci mette in guardia citando Günther Anders quando si chiede cosa la tecnica oggi “può fare di noi”, e non viceversa. Il futuro sarà stabilito dalla memoria procedurale?