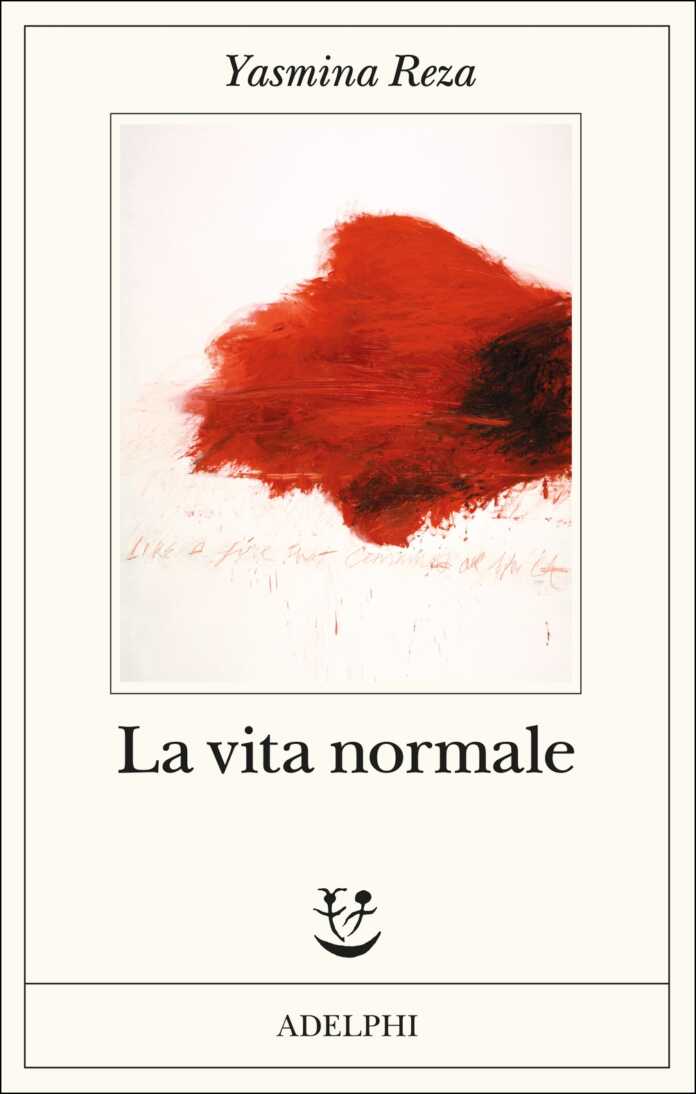Venezia è il luogo dove si può vedere Bruno Ganz, che non è Bruno Ganz, o forse sì, seduto da solo a un tavolo all’aperto di Campo San Canciano in Cannaregio. Occorre lo sguardo di Yasmina Reza per notarlo pensoso e “leggermente curvo”, osservandolo senza richiamare la sua attenzione per poi andarsene. Ricorda qualche incontro avvenuto tempo addietro, dalle parti delle Zattere, cortesie e progetti di vedersi a “casa l’uno dell’altra”. Un mese dopo Ganz muore e Yasmina lo rievoca dentro di sé allo stesso modo chiedendosi alcune cose che fanno parte della vita normale di tutti, del tempo che non contiene le nostre abituali direzioni di spazio, dei rimpianti e dei “momenti unici” a cui assistiamo senza alcuna possibilità d’intervenire. Due anni dopo, Yasmina rivede lo stesso uomo nella stessa posizione: un po’ invecchiato, o forse no, ma stessa solitudine. Un’apparizione gentile cui la scrittrice dedica poche righe che sanno incantarci senza allestire grandiosità proustiane. Fantasmi e similari s’inseriscono nell’anonimato che riguarda tutti, fanno parte dei ghiribizzi e delle fantasie a cui Venezia spesso partecipa come città emblematica di qualcosa che ci ammalia da sempre e che la nostra ammirevole parigina-veneziana abita per lunghi periodi dell’anno.
Attorno a questo centro memorial-geografico ruotano casi processuali a cui Reza assiste da molti anni, seguendo personaggi che rivelano la banalità di un atto criminale emerso dalla loro vita quotidiana, ombrosa e inesorabilmente secondaria. La postura di imputati e testimoni, l’abbigliamento, e l’opaco di parole che fanno della laconicità un’insolenza mal detta e involontaria, sono parte delle scene riunite dalla scrittrice in questi récits “di certi fatti” (dal titolo originale) che parlano di difetti e capricci, di fantasmi che hanno ben poco di sentori gotici ma sono pieni di trascuratezza epocale. Reza raccoglie una serie di personaggi trasparenti e noiosi e che annoiano, perfino incapaci d’essere angosciati dagli eventi e dalle situazioni. Il caso spadroneggia queste esistenze, contraltare polveroso e ben misero della “splendida” casualità che guida i passi per le calli veneziane permettendo architetture visuali adottate nella scrittura di chi sa costeggiare il mondo come Reza e, per esempio, Sebald. La disarmonia delle relazioni è presente, in La vita normale, semplice e categorica: perfino la facilità alla noia di Roberto Calasso durante il primo incontro con la scrittrice. A lei l’editore piace, con tutto il suo terrore di dover sostenere una conversazione mondana con un proprio autore. “Materia preziosa”, afferma Reza in una recente intervista, per il racconto di un universo contenente esseri sconosciuti l’uno all’altro e che prima o poi saranno testimoni di molteplici catastrofi, ordinarie ma vaste nella loro implacabile tragicità.
Teatro del dolore a bassa voce, in questo libro contenente gran parte del “rovescio della vita” a cui assistiamo come spettatori e attivi interpreti di “massacri” più o meno privi di volontà o spiegazioni: non ci sono mostri rappresentati ma molti virgulti spezzati preventivamente da coloro che temono la congenita noia immessa alla nascita nel corpo fisico e mentale. A questa genìa diffusa rivolge l’attenzione Reza, non potendo ignorare i fagotti di vittime e carnefici invasi da una tristezza immensa. La stessa Venezia, l’ultima rimasta dopo episodi infausti, deve resistere alla calamità del turismo fanatico, grata dello sguardo innamorato della scrittrice che ogni volta tesse romanzi, lampi narrativi e pièce teatrali capaci di scardinare conflitti latenti e operativi, dolori e rancori mai sopiti nell’umano consorzio.