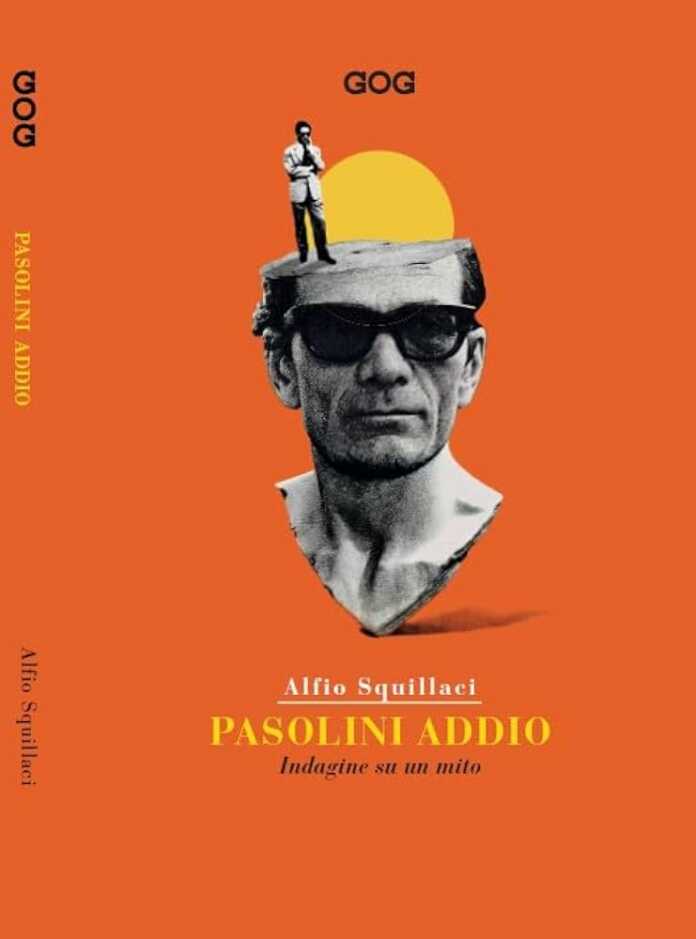Conosco Alfio Squillaci, autore di Chiudiamo le scuole di scrittura creativa (GOG, 2020), come un lettore ostinato e fedele di Gustave Flaubert, a cui torna con costanza. Chi lo segue da tempo conosce la precisione e il piacere con cui affronta lo scrittore francese negli interventi sul suo profilo Facebook: una scrittura concentrata fino alla pignoleria, spesso più persuasiva di molti saggi accademici. Anche Pasolini addio – uscito qualche mese fa sull’onda lunga dei saggi legati ai cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini – nasce, con ogni evidenza, come raccolta di lunghi post successivamente accorpati in volume. Questa origine spiega le ripetizioni, i continui ritorni sugli stessi nodi, la scrittura non rifinita: quasi una mimesi ironica della scrittura pasoliniana, sempre rilanciata e mai definitivamente chiusa. D’altra parte è lo stesso Pasolini che, con la sua ingombrante personalità e la sua diversità esibita, autorizza il lettore a interpretazioni radicalmente personali, trasformando ogni lettura in un corpo a corpo.
L’oggetto del libro non è tanto l’opera complessiva di Pasolini (non si parla, per esempio, né di cinema né in modo specifico di poesia), quanto il suo mito, cresciuto fino a diventare totalizzante, spesso sostitutivo dei testi. Squillaci prende di mira l’uso morale e simbolico di Pasolini, la sua trasformazione in figura profetica e quasi sacrale, continuamente evocata come autorità: un Pasolini monumentalizzato, iperinterpretato, messo al riparo da una lettura criticamente esigente. Un punto rilevante è quello della “diversità” di Pasolini. Qui Squillaci si richiama esplicitamente ad Alberto Arbasino e a Giovanni Dall’Orto (giornalista e attivista del movimento di liberazione omosessuale): due posizioni molto distanti tra loro, ma entrambe critiche verso Pasolini. Dall’Orto legge l’omosessualità come fatto storico e politico, prodotto da un sistema repressivo, e rifiuta ogni sacralizzazione del dolore; in Pasolini vede una moralizzazione regressiva dell’esperienza omosessuale, che rischia di trasformare l’oppressione in destino tragico. Arbasino, all’opposto, rifiuta il patetico e la tragedia permanente, concependo l’omosessualità come stile di vita, mondanità, ironia colta. Se Dall’Orto vuole politicizzare l’esperienza, Arbasino vuole normalizzarla, sottraendola alla colpa e al sacrificio. Squillaci utilizza entrambe le linee per ridurre l’eccesso simbolico del Pasolini “diverso”, riportandolo a una dimensione meno esemplare e meno intoccabile.
Il confronto più aspro resta però quello con il Pasolini critico del consumismo e della conseguente mutazione antropologica degli italiani. Nato alla fine degli anni Cinquanta in un quartiere sottoproletario di Catania, Squillaci contesta con decisione la lettura di quel passaggio storico come pura catastrofe. Per chi ha attraversato in prima persona l’uscita dal sottosviluppo nel Mezzogiorno degli anni Sessanta e Settanta, la modernizzazione ha significato anche accesso ai beni, ampliamento dei diritti, possibilità di mobilità sociale. Il dissenso, qui, è insieme biografico e politico. Non lo convincono neppure le riletture contemporanee in chiave biopolitica che, anche quando si richiamano a Michel Foucault – come nel caso di Paolo Desogus e del suo ponderoso saggio In difesa dell’umano. Pasolini tra passione e ideologia (La nave di Teseo, 2025) – gli appaiono astratte e scarsamente aderenti alla storia concreta.
Per la sua ricognizione sul “mito Pasolini”, come modestamente definisce il suo libro, Squillaci si appoggia a una tradizione critica severa: Walter Siti, Franco Fortini, Alberto Moravia, Critici inflessibili, ma mai astiosi come talvolta risulta Squillaci, che sembra attraversato dal malanimo di chi ha avuto infanzia e giovinezza durissime e quindi non è assolutamente disposto a negare che nello sviluppo ci sia stato progresso nel mentre legge le posizioni di Pasolini come reazionarie di sinistra. Eppure c’è un punto in cui anche Squillaci è costretto a fermarsi e quasi a inchinarsi: quando incontra, in Descrizioni di descrizioni, il Pasolini più alto come critico, lucidissimo, feroce, convincente anche quando è ingiusto (per esempio nei confronti di Fenoglio). In queste pagine Pasolini giudica senza indulgenze, stronca e loda con la stessa durezza, rifiuta la neoavanguardia e formula sentenze provocatorie. Lettore vorace e implacabile, arriva persino a liquidare Cent’anni di solitudine – ma oggi chi legge più? – come barocco spettacolare più che vera invenzione letteraria.
La prova massima della sua acutezza è la rilettura di Madame Bovary: Pasolini individua un “grave errore” d’impianto nella prima pagina, dove il romanzo inizia con un “noi” intradiegetico (“Eravamo…”) che poi scompare per sempre, contraddicendo il progetto di oggettività impersonale. Squillaci, appassionato di Flaubert, va in brodo di giuggiole – ed è forse la parte più divertente del libro – ma, conoscendo il personaggio, non si fida. Sapendo quanto Pasolini fosse poco interessato a citare le fonti e incline all’improvvisazione, va a controllare: verifica se quell’intuizione su Flaubert fosse davvero sua o se l’avesse ripresa altrove. Scopre che Pasolini scriveva quelle righe già nel 1973, anticipando Steiner, Brombert e Vargas Llosa. Nessun plagio, nessuna scorciatoia. Solo genio critico,
Va infine riconosciuto a Squillaci un elemento non secondario: la morte di Pasolini resta sullo sfondo. In un panorama che ancora oggi non si dà pace per la tragica banalità dell’omicidio di Pasolini, questa scelta è tutt’altro che scontata. Una considerazione finale: la scrittura ripetitiva e di getto, figlia dei social, conserva una freschezza reale. Facebook, per quanto spesso vituperato, resta uno spazio interessante di scrittura micro-saggistica, e Squillaci ne è senza dubbio un rappresentante.