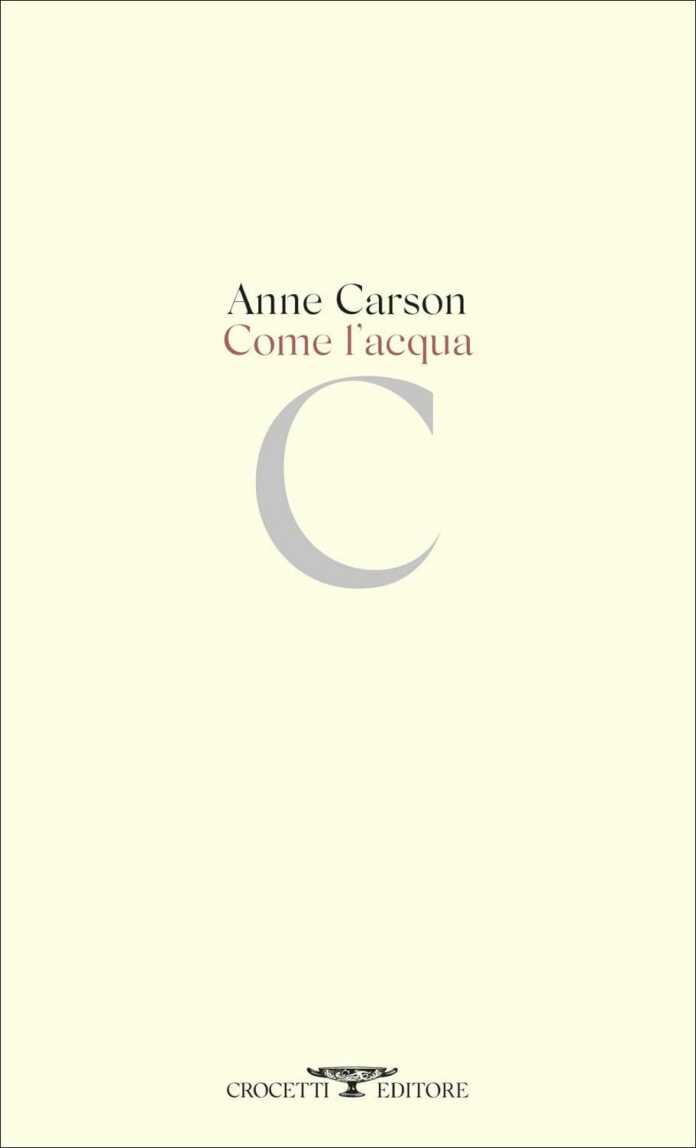Uno degli elementi rilevanti di questo volume di Anne Carson (pubblicato da Crocetti nella traduzione e cura di Patrizio Ceccagnoli) edito nel 1995 con il titolo Plainwater, sta nella involontaria distopia letteraria che esso rappresenta, per i lettori italiani, comparendo trent’anni dopo. Carson ha già rivelato questa sua capacità di una contemporaneità aumentata già in Eros the Bittersweet (1986) e Glass Irony, God (1995) che conferma con questo quarto libro, spingendo verso l’urgenza di cambiare metodo, prospettiva e tanto sprofondare nella storia poetica, tanto liberarsene, attraverso l’exit strategy della persona singolare. Si dirà: ma allora è “lirico-assertiva”? O “autofiction”? A mio avviso no.
La sua contemporaneità è nel modo singolare e unico con cui mescola materia letteraria, classici senza tempo, registrazioni di vissuto, descrizioni del mondo attorno a sé, sottraendosi a tutto, lasciando frantumare ogni categoria, recinto e classificazione di lirica, antilirica e archeologia polemica varia. Si affida alla scrittura. Un’analisi stilistica, formale, più completa di un testo straniero, dovrebbe essere fatta sull’originale. Anche in traduzione però si possono apprezzare le molte qualità letterarie e in particolare per Carson la struttura logica del discorso, le sue capacità di sorprendere, come anche la qualità di analisi psicologica e il lessico.
Una materia composita, che va dal calco di una frammentazione interrogativa, tra lirica e filosofia, riscrivendo i fragmenta del poeta greco Mimnermo alle micro-didascalie dell’inafferrabile che sono i magnifici “Discorsi brevi”, in cui si tirano in ballo da dettagli laterali, autori come Ovidio, Kafka (e la sorella Ottla), Silvia Plath, le sorelle Brontë, per dei brevi pronunciamenti tanto affermativi nella struttura, quanto spiazzanti nel dire qualcosa che non si ferma al concetto, in un procedere metaforico e ragionativo assieme, con accostamenti impervi di deriva dal surrealismo poetico-filosofico (alla Char) e insieme l’applicazione di quella forza ragionativa non consequenziale e non ordinaria con la quale molti filosofi nutrono la loro prosa di poesia. Sono proprio i “Discorsi brevi”, insieme all’“Antropologia dell’acqua” (già pubblicato con altre traduzioni da Donzelli anni fa) il risultato più alto di questo libro, che contiene anche l’ampia sezione di “La vita nelle città” in cui il meccanismo formale sembra incedere, usando qui un “tic formale” (l’uso del punto alla fine di ogni verso) che forza e distorce, interrompendo di fatto l’enjambement e anche la connessione sintattica, creando una spezzatura innaturale. Non diversa da altri “scarti dalla norma” novecentesca, certo, ma Carson migliora sé stessa, in questo libro composito, proprio là dove esce dalla necessità di mostrare che la gabbia è rotta, perché sempre nella gabbia si resta.
Invece Carson pratica in poesia al meglio quello che già da quegli anni stava succedendo nella letteratura, un processo di liberazione dagli steccati di genere di fatto in un’unica grande categoria ovvia: scrittura. Unica, polimorfa. Si tratta di una liberazione e forse la rottura dell’enjambement dice anche questo: da un lato, fare a meno di tutta la tradizione anche formale, ma compresi i post-formalismi “installativi” che praticano le rotture specchiandosi nel “senhal” meta-poetico della rottura, essa stessa “gabbia” tanto quanto un sonetto, perché esibito, ostentato, programmatico, poet-ideologico. Invece Carson pratica, in questa capacità libera di affidarsi nient’altro che all’ esattezza della scrittura e al caso della composizione o montaggio, un cinema di poesia restituito alla poesia, che produce meraviglia, pensiero.
Carson attinge a materiali vari, esperienze che legge di volta in volta in forma di breve narrazione, di notazione saggistica, di icastica fraseologia in “a capo” o no, ma sempre immettendo una lente personale ma sempre inafferrabile, lasciando spazi di immaginazione all’io-minimo che non vuole definire nessun “Io” maiuscolo, e irrompe con riflessioni su sé, sui propri amori sulle proprie relazioni dentro questo spazio di ricerca e composizione che fa la scrittura. Ceccagnoli cita una definizione per Carson emblematica: “poetry is aversion of conformity in the pursuit of New forms”. Nella lettura scritta il gioco di parole evidenzia come “l’avversione” del poeta che si ponga volutamente contro, sia di fatto anche “una versione” di conformismo, che sta già dentro la ricerca di nuove forme.
Carson invece utilizza quello che sempre Ceccagnoli definisce la “idiosincrasia” a nessun a-version, sottraendosi e praticando una mescolanza irriducibile di tutti i generi. Un flusso costante, qui fluidità Come l’acqua, per l’appunto, parola chiave per questa poesia ben prima che diventasse parola-baule, ed etichetta dei nostri anni iper-identitari. La fluidità di Carson è antropologica, cerca vita minuta dentro la classicità dai greci, nella grande pittura, nella letteratura del ’900, con una continua libera combinazione in cui il testo diventa lo spazio che si apre nel pensiero, approfitta di angoli e spigoli logici, di cortocircuiti concettuali e percettivi di una persona-mente che vive e vede il mondo intorno a sé e lo reinterpreta. La scrittura è o, meglio, diventa scrivendo, come un continuo appunto saggistico-frammentario-diaristico, la continua sperimentazione di quella realtà, da cui emerge questa compartecipazione attiva di una soggettività. Certo è un soggetto che fa, che ha fatto letture plurali ma è come se si nutrisse, e assorbisse in sé, un “noi”, attraverso quello che ha lasciato depositato dentro il “noi” anche se in una intervista Carson ha detto che “il linguaggio è molto molto personale e privato”. Facendola finita con enjambement e altri punti fermi di ciò che è poesia (l’“acapo”, ineliminabile anche se si pratica una confluenza di parole intercettate o un “dripping” alla Pollock in parole.
L’idiosincrasia radicale della soggettività di Carson alla fine porta a una letteratura che torna a misurarsi con il dato interiore ed emotivo, senza nella registrazione narcisistica di palpitazioni di dolori affanni proiettate dall’ego al mondo. Carson è autrice vivente che a costo di una produzione anche abbondante, se non strabordante, ricca e stratificata di scritture, mostra la continua vitalità e trasformazione dell’atto disperato di voler significare qualcosa di fronte all’enigma continuo che ti pone la vita e il visibile. Una continua energia che rischia l’errore, che si fa erranza, ma anche libertà di cammino fuori da ogni ossessione normativa così come da ogni forma canonica, ma nella ricchezza dei materiali. Non è la liberazione del poeta delle semplificazioni, spacciate per sacra semplicità a lettori poco esigenti. Si scende nelle pieghe di una coscienza, ma non si erige nessuna statua della stessa. Eccolo il processo di decreazione al centro di un libro che scriverà tredici anni dopo questo. Mentre parlo, compongo, e mi sfaldo. Divento ciò che dissipo, disseto il mare, dopo aver portato ad essere foce la sorgente.