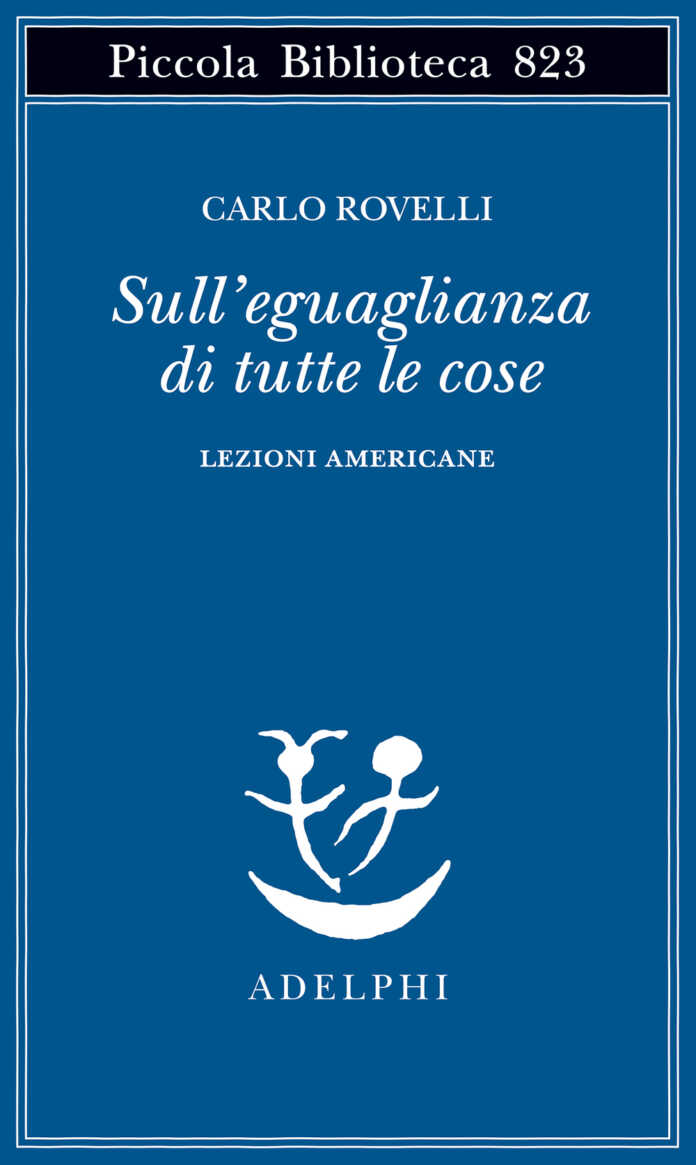La natura della realtà e la natura della conoscenza viaggiano insieme nella mente di questo bipede apparso sulla superficie del pianeta Terra – luogo per niente comune nell’ambito dell’universo – in mezzo a tutte le altre specie che si sono succedute nel corso delle ere temporali. Strano accennare al tempo quando si ha a che fare con uno scienziato come Carlo Rovelli che nella fisica su cui lavora – la gravità quantistica – lo sforzo continuo è da sempre quello di comprendere (e far comprendere) un mondo senza tempo. Ma il tempo con cui abbiamo a che fare è relativo, e la massa dei corpi (pianeti, stelle, buchi neri) ne modifica la struttura: la massa della terra, per esempio, rallenta il tempo vicino a sé. In definitiva: “c’è un tempo diverso per ogni punto dello spazio”. È dal 2014, da quando lo scienziato ha pubblicato La realtà non è come ci appare, e Sette brevi lezioni di fisica, di grande impatto divulgativo, che le più belle teorie regalate dal Novecento, la relatività di Einstein, e la meccanica quantistica di Planck e Bohr, hanno iniziato a sorprendere un pubblico sempre più vasto, nonostante la complessità (talvolta abissale) della faccenda.
Numerosi i volumi usciti negli anni successivi, tutti per Adelphi con grande successo, mentre Rovelli proseguiva la propria ricerca ai livelli sempre più alti. L’ultimo nell’ordine è questo Sull’uguaglianza di tutte le cose, che porta nel sottotitolo – “Lezioni americane” – l’omaggio a Italo Calvino che, invitato in America, scrisse quei testi che uscirono in libreria proprio come “Lezioni americane”. Rovelli, ricevendo l’invito da Princeton, ha tenuto le sue lezioni nel novembre e dicembre 2024 al Dipartimento di filosofia di quell’università. Ora sono raccolte in queste pagine, e si rivolgono a coloro cui interessano le implicazioni filosofiche portate dalla rivoluzione scientifica originata in quel Novecento per altri versi terribile e oscuro. Ma il pensiero che Rovelli dispiega avviene nell’ampio spazio relazionale del “Zhuangzi”, dove nel secondo capitolo di questo grande libro dell’antichità si parla appunto dell’uguaglianza di tutte le cose.
Ogni sistema ha variabili relative a un altro sistema, dunque ogni oggetto non ha proprietà proprie e definite. E il valore di un fenomeno quantistico avviene solo quando c’è un’interazione. Esempi e descrizioni si susseguono a ogni pagina, rendono ben chiaro al lettore come un radicale sovvertimento del senso comune deve avvenire nelle nostre menti se vogliamo immergerci, con un minimo di consapevolezza, nella realtà di cui facciamo parte. Le note inserite a piè di pagina vanno incontro a chi desidera (e si sente in grado di) approfondire matematicamente le questioni. Importante è comprendere – e Rovelli si sforza senza mezzi termini – come il valore dell’“assoluta certezza” sia nullo e del tutto oscurantista. Lo dimostra la strategia adottata dalla scienza del XX secolo: scoprire continuamente gli errori e correggerli.
Tutto cambia, anche un sasso, più gli orizzonti si allargano più il tempo svanisce. Nessun tempo è comune, così come la geometria fisica è curva e dinamica, cambia nel tempo. Le distanze sono una manifestazione del campo gravitazionale. La realtà è un insieme di campi e questi non sono nello spazio, ma “definiscono essi stessi l’estensione spaziale”. Tutte novità concettuali che ci portano a viaggiare in questo libro sovvertendo l’ordine, avanzando e ritornando indietro sui propri passi, con un loop teso ad approfondire sempre più un concetto, una frase. È sempre stato il metodo principe dello scienziato quello di portarci in spazi via via sempre più profondi di consapevolezza, senza essere in grado di capire fino in fondo la bellezza di una equazione riportata nel libro come quella che ci dice che campo gravitazionale e spazio sono la stessa cosa. In fondo che ne sappiamo della Missa Solemnis di Beethoven? Vi restiamo sospesi dentro, ma l’ascoltiamo. Dunque “ascoltiamo” Rovelli e Beethoven.
Siamo in un mondo strano, certo, ma andiamo avanti curiosi, non stranieri ma esseri pensanti che stanno “a casa”. Osserviamo e studiamo il mondo, come parte di quel mondo. Ma attenzione, “non ci sono ricette, a parte tentativi ed errori”.