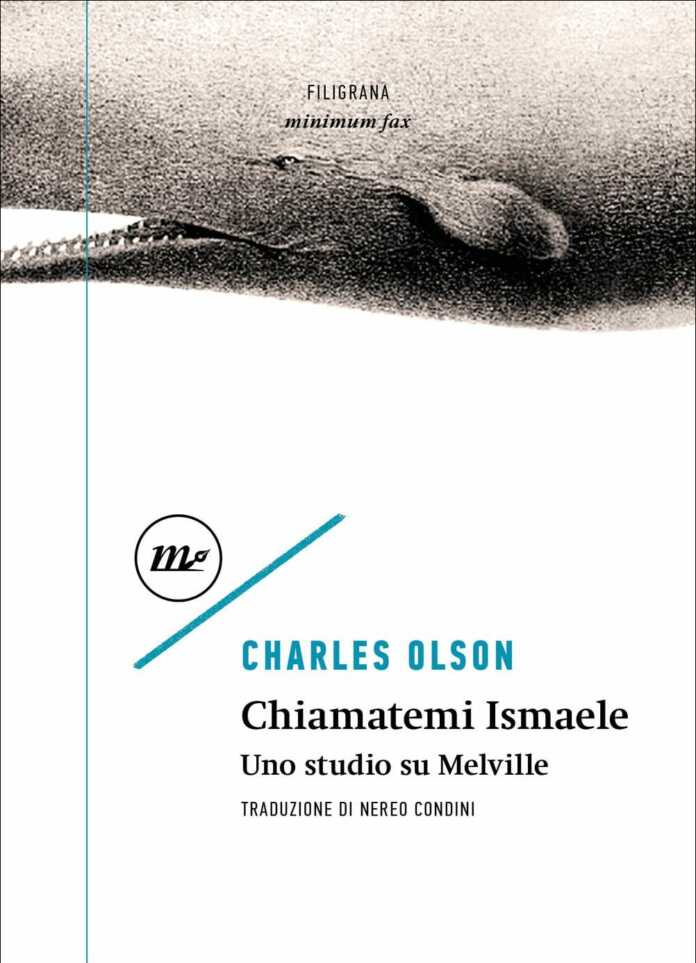Il breve saggio di Charles Olson (1910-1970) che minimum fax ha appena ristampato (esisteva una precedente edizione Guanda del 1972), rivoluzionò alla sua uscita nel 1947, non solo gli studi su Moby Dick e su Herman Melville, ma il modo stesso di concepire e scrivere la critica letteraria. Olson, che fu anche poeta e che avrebbe molto influenzato la Beat Generation, introdusse nella saggistica letteraria non solo una radicale novità di temi, ma soprattutto uno stile e una scrittura assolutamente dirompenti che avrebbero stupito o addirittura scandalizzato il coevo mondo accademico. Alle pagine di analisi e critica del testo, la cui tesi più originale è il leitmotiv shakespeariano che animerebbe e sostanzierebbe il capolavoro di Melville e l’essenza dei suoi protagonisti, Ahab e Ismaele, si alternano pagine libere in cui si descrivono episodi marinari analoghi e, se possibile, ancora più macabri e sanguinosi di quelli raccontati nel romanzo: naufragi, ammutinamenti, cannibalismo.
La carriera di navigatore di Melville viene poi delineata nella sue varie fasi esperienziali e narrative, dalla marina mercantile (Redburn), a quella militare (White Jacket), ai contatti con le marinerie non statunitensi (Benito Cereno, Le isole incantate, Billy Budd), all’esotismo e all’espansionismo Pacifico (Typee, Omoo, Mardi), con l’Oceano che, nella visione di Olson, Melville pone come una nuova frontiera, una sorta di West marino in cui si eserciterà, con tutte le sue terribili contraddizioni, il Manifest Destiny della democrazia americana: non la Grande Interiorità di Poe o di Hawthorne, o il Progresso sociale di Whitman, ma l’immensità dello Spazio. E la baleneria vi si impone come grande impresa statunitense, impresa nel senso dell’avventura ma soprattutto impresa nel senso di espansione economica e dominio e gestione delle risorse. A scandirne il massimo controllo nell’epopea manifatturiera di Nantucket emerge una radicalità veterotestamentaria, la dimensione biblica, la legge israelita dell’occhio per occhio, l’eco di Noè e di Giona, del libro della Legge del Sangue, in cui Mosè si contrappone a un Cristo del tutto assente da Moby Dick, un libro empio – come lo stesso Melville lo descrisse a Hawthorne – in cui perfino la perversa benedizione rivolta da Ahab al rampone, Ego non baptizo te in nomine patris, sed in nomine diaboli, non fa nemmeno cenno alle altre due persone della Trinità. Melville anni dopo viaggerà in Terra Santa e scriverà il lungo poema Clarel quasi per riconnettersi ad un’esperienza cristiana negata nel suo capolavoro e i suoi ultimi personaggi, Bartleby, Benito Cereno, Billy Budd, non saranno che rifrazioni diverse e diversi ritratti di Cristo.
Ma tutto questo passa inevitabilmente attraverso Shakespeare: Ahab è un po’ Amleto, e molto Macbeth e, come lui, “ha ucciso il sonno”. Il rapporto tra Ahab e Pip, il piccolo mozzo impazzito dopo essere caduto in mare, rispecchia quello tra Re Lear e il Buffone; il Pequod è la Roma e l’Oriente di Antonio e Cleopatra, l’opera shakespeariana che Melville annotò di più; Fedallah appare e scompare come le Tre Streghe del Macbeth e, se Jago diventerà Claggart in Billy Budd, confermando fino all’ultimo l’influenza su Melville dei personaggi negativi e totalitari del Bardo, sarà invece Ismaele, l’“Orfano”, a correggere Shakespeare in senso democratico dando voce e dignità all’equipaggio marinaro, composito e multietnico, unito fino all’epilogo della tragedia senza alcuna remissione dei peccati: Ismaele perennemente orfano ma, almeno in nome e memoria di tutti gli altri, salvo come Noè dopo il Diluvio.