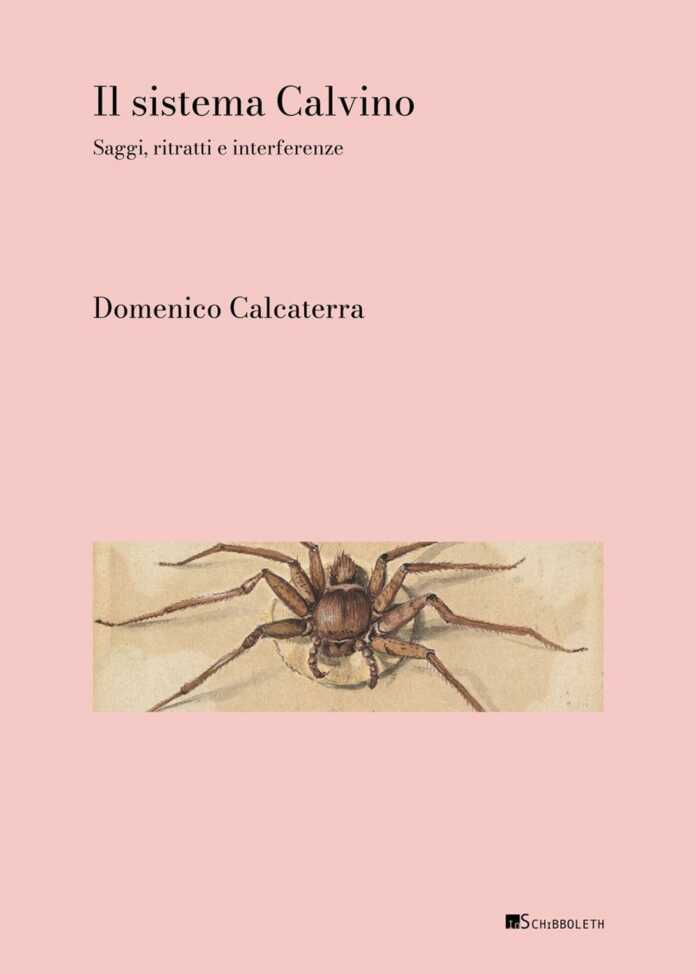Su certi autori non si smette di lavorare; o meglio, non si può smettere di lavorare. Uno di questi è indubbiamente Italo Calvino, uno che (a differenza di Moravia o Tobino) non è mai entrato in fase calante di notorietà, e che non ha mai mancato di lettori, ma che ci pone ancora sfide interpretative. Per farla breve, come mettere insieme il Calvino realistico, potremmo dire addirittura neorealista, degli esordi (cito a mero esempio Il sentiero dei nidi di ragno) con quello metaletterario, postmodernista, sperimentalista delle Città invisibili o Se una notte d’inverno un viaggiatore? Dobbiamo pensare a uno scrittore che a un certo punto si è accorto di aver sbagliato il suo approccio alla narrazione, che ha in qualche modo rinnegato una parte della sua opera (quella che arriva fino a La giornata di uno scrutatore, che Calcaterra indica come punto di svolta, e non è il solo a vederla così)? Oppure le due fasi della produzione di Calvino sono comunque da inquadrare in un processo di crescita, di evoluzione, di maturazione, nel quale si ritrovano ripetutamente temi, immagini, idee, domande alle quali lo scrittore risponde in modo diverso, ma animato dagli stessi interessi e spinto dalle stesse inquietudini?
In questa raccolta di saggi Calcaterra, che dà prova di conoscenza profonda e attenta dell’opera del grande ligure, intende “dimostrare testi alla mano la continuità tra il Calvino degli esordi e quello cosmicomico e combinatorio”, quindi propende per la seconda ipotesi interpretativa; e va detto che difende la sua tesi in modo assai convincente, riuscendo anche a offrire prospettive inedite su alcuni testi che crediamo di conoscere anche troppo bene. Soprattutto il critico ci apre gli occhi su quello che potrei definire un dato di fatto: la “presenza nel primo Calvino di nuclei concettuali e motivi strutturali che diventeranno cruciali ed esclusivi nelle opere dei decenni successivi”. Tra questi, in particolare, “l’attitudine a concepire il discorso letterario nel suo sviluppo come un ragionamento (ricerca di un modello e di un metodo), che può condurre a rischiarare una verità etico-morale, anche se di per sé utopica”. E in questi termini mi viene da dire “ecco il Calvino che conosco!” – segno che Calcaterra ha un argomento cogente nel suo libro. Ovviamente, trattandosi di una raccolta di saggi (in parte già pubblicati in diversi periodi), abbiamo anche ripetizioni, sovrapposizioni, e manca l’impianto ordinato e ferreamente strutturato della monografia accademica; ciononostante, il critico riesce a delineare il processo che porta Italo dalle tragicomiche disavventure di Pin alle vertiginose meditazioni di Palomar.
Se il valore di un saggio sta in quel che ci dice, ma anche nelle riflessioni che suscita, il semplice fatto che me ne abbia suggerite diverse attesta il valore degli scritti di Calcaterra. Mi viene da chiedermi, quindi: ma la ricerca di un metodo, di un modo affidabile di consentire al “mondo scritto” (la letteratura) di accedere al “mondo non scritto” (il reale), e di rappresentarlo, e di misurarlo, di analizzarlo, non risente anche del prima, cioè dell’orgia retorica del ventennio fascista? Non è una reazione a quel diluvio di parole in libertà, la cui vuotezza si manifestò brutalmente l’8 settembre 1943? Inoltre, si sarebbe potuto mettere Calvino nel contesto degli altri scrittori della sua generazione? Calcaterra giustamente menziona, e non una sola volta, Levi e Volponi quali compagni di strada (specie riguardo al rapporto con le scienze); ma a me, leggendo le sue pagine, tornava continuamente in mente quel Fenoglio che Italo venerava come vero grande cantore (e cronachista) della Resistenza; e non mi pareva tanto lontano da un altro grande il cui valore ancora non è stato riconosciuto a sufficienza, e cioè Luigi Meneghello. Tutti e tre hanno dovuto lavorare sul linguaggio, in modo radicale, per liberarsi dai liquami dell’ideologia, della propaganda e della retorica littoria, esempio nefasto di quel “falso uso” delle parole e delle immagini che Calvino denunciava in Due interviste su scienza e letteratura.
Ultimo, ma non in ordine di importanza, il caveat di Calcaterra: l’autore del Cavaliere inesistente e delle Città invisibili non è né un giocoliere delle narrazioni, né un attardato illuminista. A tutti gli effetti è un autore del Novecento, ben consapevole dei suoi drammi e dei suoi disastri, che non manca di un suo lato oscuro (al metodo il critico contrappone la nevrosi che individua tra le pieghe dei suoi testi); un autore che ha prediletto le forme brevi, e proprio per questo ci richiede di non leggere una sola delle sue opere e fermarci lì. Anche solo per questo ammonimento, Il sistema Calvino è un libro da leggere.