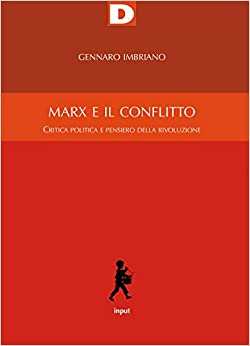Frutto di un seminario sul pensiero di Karl Marx svolto un anno fa presso la Medieteca Gateway di Bologna e però rivolto a compagne e compagni, nelle intenzioni di Gennaro Imbriano Marx e il conflitto vuole essere un utile strumento per un ritorno a Marx dopo la presa, a sinistra, di certe filosofie ‘critiche’ che avrebbero contribuito non poco a condurla nel vicolo cieco in cui essa, la sinistra intendo, si trova. Un rischio, questo, che lo stesso Marx giovane avrebbe a suo tempo schivato facendo i conti – lui sì con nettezza e determinazione – con il pensiero dell’autonomia del politico (§ I), con la filosofia e la sua miseria (§ II), con l’economia politica (§ IV). Il tutto all’insegna di quell’idea di critica radicale che di fatto è lo “snodo decisivo che ci aiuta a scoprire la differenza marxiana”[1]. Filosofia della differenza, post-strutturalismo, teorie della decrescita, assieme al correlato di filantropismo umanista, mutualismo e democrazia radicale, figurerebbero come la versione aggiornata di quel vecchio paradigma che tutte le comprendeva. Ma in questione non è la semplice ricostruzione del pensiero del giovane Marx perché su questo versante Imbriano è riuscito, senza dubbio alcuno, nel suo intento di offrire al giovane lettore un’esemplificazione esauriente di quello che, a parere di chi scrive, è però solo la vulgata del marxismo nella versione trasmessaci dalla tradizione del Movimento Operaio. Le pagine del III § sono lì a dimostrarlo. Nell’economia del saggio questo capitolo, dall’accattivante titolo “Contro il socialismo”, è forse rivelatore delle vere ragioni politiche e di quel seminario e del libro. Qual è infatti il Marx che i nostri giovani militanti dovrebbero conoscere?
Ma prima, un passo indietro nel tempo. Ci ricordiamo della vecchia collana degli Editori Riuniti, Le idee? Anche quella, un’iniziativa editoriale meritoria del Pci che proprio alla fine degli anni Sessanta scelse di anticipare la pubblicazione delle MEOC (Marx-Engels Opere Complete) con una serie di scritti, soprattutto giovanili, di Marx ed Engels. Ricordo bene le Forme economiche precapitalistiche del 1967, La questione ebraica e il Ludwig Feuerbach del 1969, L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza del 1970, La concezione materialistica della storia del 1971. Per non parlare poi dei curatori, intendo Palmiro Togliatti, Giuseppe Prestipino, Fausto Codino, finanche Eric Hobsbawm e Maurice Dobb! Poi, d’un colpo, tra il 1972 e il 1976, i volumi III, IV, V e VI delle Opere Complete. Se durante gli anni Sessanta al Partito non era riuscita l’operazione di disciplinare la classe operaia in fabbrica col Marx dei Manoscritti[2], ora il tentativo si ripete con la piccola borghesia scolarizzata e ribelle. Che dal materialismo storico di un Marx maturo avrebbe dovuto apprendere che la rivoluzione ha i suoi ritmi, che non sta bene mordere il freno anzitempo, soprattutto, che la sua uscita dallo stato di minorità abbisognava di un Principe paterno e illuminato. È così che il Partito per tutti gli anni Settanta non si stanca di ricordare a studenti e giovani meridionali, divenuti nel frattempo operai, l’adagio kantiano: ragionate quante volete e su tutto ciò che volete; solamente obbedite! Sappiamo tutti com’è finita.
Di cosa aveva paura il Partito? Dell’altro Marx, quello del primo libro del Capitale rivisitato da Mario Tronti nel 1965 nel bel mezzo delle lotte operaie[3]. E poi quello, ancor più inattuale, del secondo libro del Capitale avanzato nel 1977 da Negri per dare ragione del nuovo ciclo di lotte promosso dall’operaio sociale[4]. Che poi questo sforzo teorico di andare oltre Marx sia finito lì, è un’altra storia, magari da ricostruire collegandola alla sconfitta dei movimenti alla fine degli anni Settanta. Comunque sia, resterà impresso nella storia del marxismo di questo paese come un segno indelebile dei suoi vent’anni più gloriosi di lotta di classe. Quanto al primo Marx, il suo materialismo storico dovrà vedersela per ironia della sorte direttamente con la vita reale: la fine senza gloria alcuna del soggetto che l’aveva sponsorizzato, l’implosione di uno Stato, l’Unione Sovietica, sorto in suo nome, il trionfo del capitalismo in tutto il globo terracqueo. La sinistra storica neppure accuserà la perdita per cui c’è poco da meravigliarsi se da lì a poco si getterà sua sponte tra le braccia del primo venuto – le varie “forme di pensiero «critico»” cui allude Imbriano – per decidersi alla fine di passare armi e bagagli nel campo dell’avversario sposandone le ragioni. Il tutto, in coerenza con una storia vissuta all’insegna della modernità come la scelta meditata di Togliatti di tradurre e apporre la sua Prefazione al Trattato sulla tolleranza di Voltaire lasciava intendere già dal lontano 1949. Certo, il bersaglio erano allora la chiesa e il suo strapotere, ma la sfida vera era la modernizzazione del paese da perseguire all’insegna di quella stessa esperienza razionalista che aveva caratterizzato il Secolo dei lumi[5]. Il connubio togliattiano di socialismo e democrazia aveva questo solo significato sicché riforme di struttura e rivoluzione divennero presto sinonimi. Agli occhi del partito e dei suoi militanti le prime non negavano la seconda: le riforme di struttura erano la rivoluzione. E non senza ragione. “Rivoluzione” è concetto della modernità al pari di “Riforma” e di “Progresso”, e insieme stanno a indicare l’urgenza di un’apertura al futuro. È quanto Togliatti aveva colto scegliendo il ritmo e la direzione da seguire per la sua idea di socialismo. Non me ne voglia Imbriano, ma a me pare di scorgere qua e là nel suo libro tracce dello stesso marxismo che aveva ispirato a suo tempo il dirigente comunista. A partire da quell’idea principe di un Marx campione della Modernità, con in più la classica lezione sulla sua complessità e sul come fattivamente governarla evitando i classici “discorsi ‘critici’ ampiamente deficitari, o perché non in grado di scorgere le dinamiche di affrancamento immanenti al processo storico […] o perché, al contrario, infantilmente protratti verso un futuro utopisticamente connotato”[6].
Torno a bomba per riprendere come si dice il filo del discorso. Se di quel marxismo oggi non c’è traccia e nessuno lamenta la sua assenza, forse una ragione c’è, più seria a mio avviso delle giustificazioni di comodo avanzate qua e là, poche per la verità per la stessa inattualità, oggi, del tema.
Gli è che la modernità ha concluso il suo travagliatissimo periplo di guerre e rivoluzioni appena ieri, diciamo tra Il 1968 e il 1991[7]. In questo lasso di tempo, poco più di cinquant’anni, quelli della mia generazione si sono trovati immersi in una dimensione temporale che Reinhart Koselleck, uno studioso caro a Imbriano, ha chiamato accelerazione[8]. E in effetti in questo ultimo mezzo secolo tutto nel mondo è andato più in fretta. Non che prima fosse rimasto fermo a guardarsi l’ombelico e infatti questa accelerazione di per sé non è una novità; è registrabile già nel Diciottesimo secolo, in campo politico con la Rivoluzione francese, in quello economico con la rivoluzione industriale. Proprio perché espressione di movimento e mutamento radicale, Koselleck ne farà il simbolo qualificante e distintivo della modernità[9]. Rettilineo e irreversibile il suo tempo, è la rivoluzione a garantire la rimozione degli ostacoli al suo avanzamento accelerando il tempo della storia là dove esso pare bloccato. È questa l’immagine della Storia del mondo che la modernità ci restituisce: un avvio rumoroso e, a seguire, strappi improvvisi su una strada in salita di cui non si vede la fine. Un’immagine pur sempre fascinosa per via del futuro insieme ignoto e rassicurante che ci prospetta. Senza questa apertura al futuro parlare di Rivoluzione non ha senso. Ma è quanto accade oggi. Ha ragione Koselleck: quando l’accelerazione comincia a bruciare il tempo fino a raggiungere “un grado di saturazione oltre il quale è impossibile procedere”[10] – e di questa cosa tutti abbiamo conferma nella nostra esperienza quotidiana –, la modernità è finita perché giunti a questo punto non possiamo neanche più parlare di tempo prospettico in cui a predominare è per l’appunto il futuro. A quella prospettiva – che indubbiamente è anche di Marx[11] – a me sembra che resti ostinatamente ancorato Imbriano.
[1] G. Imbriano, Marx e il conflitto, DeriveApprodi, Roma 2020, p. 11.
[2] K. Marx, Opere filosofiche giovanili, Editori Riuniti, Roma 1963.
[3] M. Tronti, Prime tesi. Marx, forza-lavoro, classe operaia in Opera e capitale, Einaudi Editore, Torino 1966.
[4] A. Negri, Dall’ “Estremismo” al “Che fare?”. Per la critica della costituzione materiale: autovalorizzazione operaia e ipotesi di partito in La forma stato, Feltrinelli Editore, Milano 1977.
[5] P. Togliatti, Prefazione al «Trattato sulla tolleranza» di Voltaire in Opere scelte, Editori Riuniti, Roma 1974.
[6] Marx e il conflitto, cit., p. 73.
[7] M. Hardt/A. Negri, Impero, Rizzoli, Milano 2002; E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, RCS Libri, Milano 2000.
[8] R. Koselleck, Accelerazione e secolarizzazione, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli 1989.
[9] R. Koselleck, Criteri storici del moderno concetto di rivoluzione in Fututo passato, Marietti, Genova 1986.
[10] Accelerazione e secolarizzazione, cit., p. 43.
[11] Marx e il conflitto, cit., p. 133: “In ogni caso, ciò che sempre più chiaramente matura nella prospettiva marxiana è la convinzione del carattere processuale della rivoluzione. La sua lunga durata. La rivoluzione è un processo, non un evento