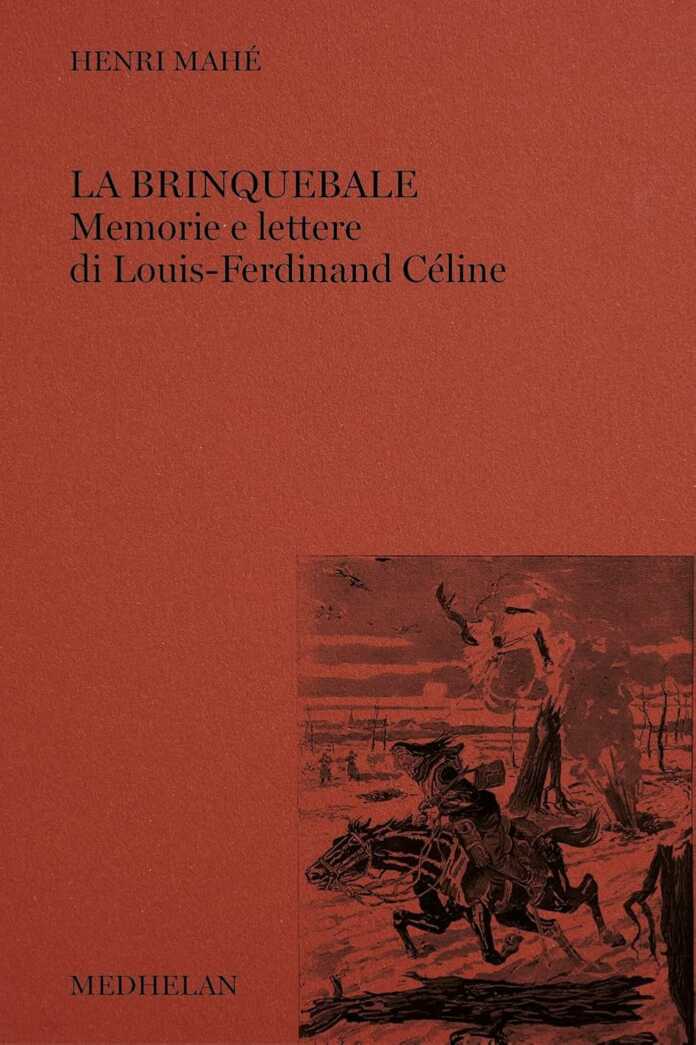Henri Mahé (1907-1975), pittore e decoratore (specializzato nell’affrescare circhi, locali come il Moulin Rouge e bordelli), scenografo teatrale e cinematografico, illustratore della prima edizione del Voyage celiniano, marinaio per diletto sui mari della nativa Bretagna o su chiatte e bateaux-mouches (dove visse per anni) lungo la Senna, fu intimo amico del dottor Louis Destouches prima che diventasse Louis-Ferdinand Céline e naturalmente anche dopo e per tutto il periodo della damnatio memoriae del Dopoguerra e dell’esilio a Meudon. Il libro che Medhelan ha da poco tradotto, fu pubblicato dall’artista alla fine degli anni ’60, parecchi anni dopo la morte di Céline, e nelle intenzioni dell’autore vorrebbe essere una testimonianza sulla vita randagia e “traballante” (brinquebaler in argot è il barcollare dell’ubriaco) di due amici sui generis attraverso la debauche giovanile e la guerra, un percorso tortuoso attraverso sorti propizie e avverse. È seguito da La genesi con Céline, scritto qualche anno dopo da Mahé a New York, che avrebbe dovuto essere la continuazione del primo ma rimase incompiuto per la morte dell’autore. In appendice una raccolta di lettere di Céline a Mahé e a un altro comune amico, Paul Marteau, più una raccolta di notizie biografiche sugli innumerevoli personaggi (per noi italiani totalmente sconosciuti) citati nel testo.
Chi si aspettasse chissà quali notizie inedite sui retroscena privati del grande scrittore francese, sulla concezione e la stesura delle sue opere o sulle compromissioni del suo ondivago collaborazionismo durante l’occupazione nazista, rimarrà (come chi sta scrivendo queste righe) ampiamente deluso. In realtà l’uso del nome di Céline da parte di Mahé è abbastanza pretestuoso e il pittore parla molto di sé stesso e abbastanza poco dell’amico medico e scrittore, che resta più che altro sullo sfondo: Mahé è del tutto reticente, suggerisce, accenna e non sparla mai del coupin, in questo mostrando ammirevole fedeltà e lealtà verso la sua memoria, ma così facendo nasconde molto più che svelare e non ci racconta su di lui davvero niente di particolarmente interessante. Nemmeno le avventure erotiche (assai più esplicite nella corrispondenza celiniana pubblicata da Adelphi qualche anno fa: L.F. Céline, Lettere alle amiche, 2016) che pure i due amiconi, questo lo si capisce bene, separati o insieme non hanno affatto disdegnato, vengono precisate più di tanto: il massimo che sfugge al testimone è l’ammirata lode della bellezza suprema di Elisabeth Craig, la ballerina americana a cui è dedicato il Voyage e compagna di Céline ai tempi della sua stesura, e il vago accenno al fatto che la coppia era molto aperta, che a lei piacevano anche le ragazze, che lui non era affatto geloso e che lei alla fine lo lasciò perché stremata…Tutto e nulla. Nemmeno sulle competenze professionali del dottor Destouches emerge molto: era un bravo medico? Curava le puttane e dai poveri non si faceva mai pagare, più facile che gli allungasse lui qualche banconota… ma questo già lo sapevamo. Perché poi odiava così tanto gli ebrei? Anche questo tema non viene in alcun modo indagato: Céline raccoglieva perfino cani e gatti randagi per strada e li sfamava, ma era ferocemente antisemita, così come qualcun altro era strabico o aveva i foruncoli.
La struttura narrativa del testo inoltre è abbastanza ripetitiva, in genere si parte da una cartolina o poche righe di una lettera di Céline all’amico, una sua comunicazione o una notizia in genere banale, e Mahé risponde come dialogando con Louis a distanza di anni, chiamandolo per nome, rievocando episodi (spesso neanche troppo collegati con le parole celiniane) e così via per pagine e pagine. E qui si entra in quella che – è una mia discutibilissima opinione – è la parte più debole del testo: Mahè fa il verso a Céline, cerca di scrivere come lui (ci mette perfino i classici tre puntini), lo scimmiotta in uno stile argotico e cinico-umoristico, un flusso di coscienza continuo pieno di punti esclamativi e frasi spezzate, la petite musique celiniana che qui però – Mahé non è Céline – passa dall’ensemble jazz alla filarmonica dei pompieri. Utile leggere la postfazione di Éric Mazet magari (come ho fatto io) prima di affrontare il testo – così almeno ci si capisce qualcosa – dove si dice che la scrittura del primo Céline aveva cercato di riprodurre sulla pagina le tirate di Mahé quando raccontava e affabulava oralmente: non si può stabilire se l’affermazione sia vera o se si cerchi più che altro di giustificare e spingere il libro, di fatto ci viene da dire che allora sarebbe stato meglio per Mahè incidere un disco invece di riempire più di cinquecento pagine di una scrittura che appare come la sbiadita copia carbone di un originale inarrivabile. Cinquecentosessanta pagine tutto compreso. È raro che abbandoni un libro a metà – di solito seguo sempre il precetto enunciato (parlando in quel caso di film) da Fritz Lang in Le Mépris di Jean-Luc Godard: “Bisogna sempre finire quello che si è cominciato” – ma questa volta non riesco: mollo a pag. 260.