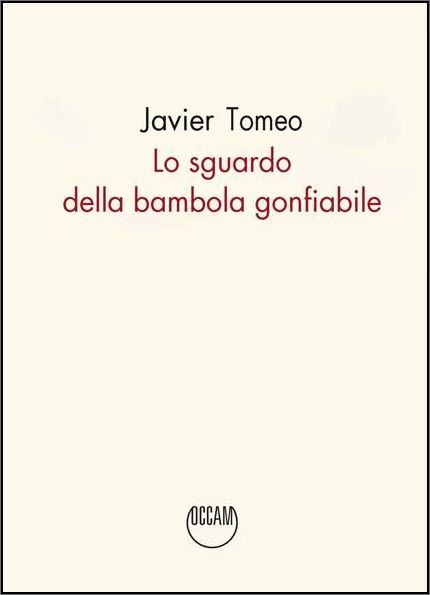Cosa può una bambola gonfiabile è senz’altro differente da cosa può un corpo, secondo la nota definizione deleuziana, ma, nella penna dell’autore spagnolo Javier Tomeo (1932-2013), può comunque essere una – a tratti divertente, a tratti terribile – sorpresa. In effetti, se Deleuze interrogava da par suo l’opera di Spinoza, il protagonista di questo libro, Juan P, interroga costantemente, come recita il titolo, lo sguardo della bambola gonfiabile Dorotea. Qui terminano gli improvvisati parallelismi e le mis-letture: Juan P non trae certo verità filosofiche dalle sue conversazioni, venendo anzi rimbeccato spesso a monosillabi, con una certa asprezza, proprio da Dorotea.
Juan P, anzi, è via via sempre più deluso dalla laconicità di Dorotea – che pure gli parla, ovvero sembra che gli parli – ma non soddisfa, per quanto ne può sapere chi legge, alcun suo desiderio o pulsione: il suo destino – probabilmente scritto sin dall’antefatto della narrazione, come si scoprirà nelle ultime righe – è di chiudersi in un solipsismo folle e paranoico, oscillante tra sessuomania e sessuofobia, e forse, quindi, proto–incel (il testo è del 2003), ma sicuramente incardinato in una cultura patriarcale e misogina che non riesce a dare, e a darsi conto, di un mondo altrettanto impazzito.
Chi legge scopre in effetti rapidamente – venendo catapultato nel giro di poche pagine da una narrativa che procede per tratti sommari, a partire dal più classico degli incipit («Mi chiamo Juan P…») nel vortice delirante del monologo interiore di Juan P, più congeniale alla narrativa radicale e debordante di Tomeo (e assai ben rappresentata dalle arguzie del suo traduttore, Loris Tassi) – che il mondo di Juan P è quello dei primi anni Zero, agitato da quei fantasmi del terrorismo internazionale che si sono nuovamente manifestati, nel combinato disposto di politica e media, con l’11 settembre 2001. È per questo, tra l’altro, che una delle ribellioni impossibili di Juan P riguarda non tanto la bambola gonfiabile Dorotea, quanto l’apparato televisivo, cui pure dovrebbe restare legato non solo dalle sue inveterate abitudini voyeuristiche ma anche da alcune disposizioni – che appaiono terribilmente orwelliane – dell’autorità vigente.
Juan P appare dunque prigioniero, innanzitutto, di una realtà affetta da una sostituzione simulacrale ubiqua, esperita – con quella punta di sentimentalismo kitsch che non abbandona mai il narratore, essendo a tutti gli effetti una dimensione dell’affettività incel – come predominio del dato onirico su quello materiale, e come dice a un certo punto Juan P all’amico Torcuato, «in fin dei conti gli uomini non sono colpevoli dei loro sogni». Juan P, tuttavia, è responsabile, e presumibilmente lo è stato anche in passato, di alcune efferatezze in funzione del suo continuo delirare e ciò accelererà inevitabilmente il suo destino, più tragico che tragicomico.
Beninteso, quella di Tomeo non è in alcun modo una narrazione consolante, anche se pervasa di un umorismo grottesco, occasionalmente ridondante; vi aleggia sempre, per contro, una terribile aura di mistero sulle sorti individuali e collettive, che Tomeo proietta riflessivamente anche sulla propria scrittura, in uno dei passaggi più deliranti e al tempo stesso più ludici di Juan P, che qui conviene riportare per intero: «Perché gli uomini scrivono cose impossibili? Lo fanno perché sanno che non potranno mai vederle trasformate in realtà? Perché Torcuato sogna padelle e io uomini senza naso? Sogniamo queste sciocchezze solo per ricordarci che viviamo circondati dal mistero?».