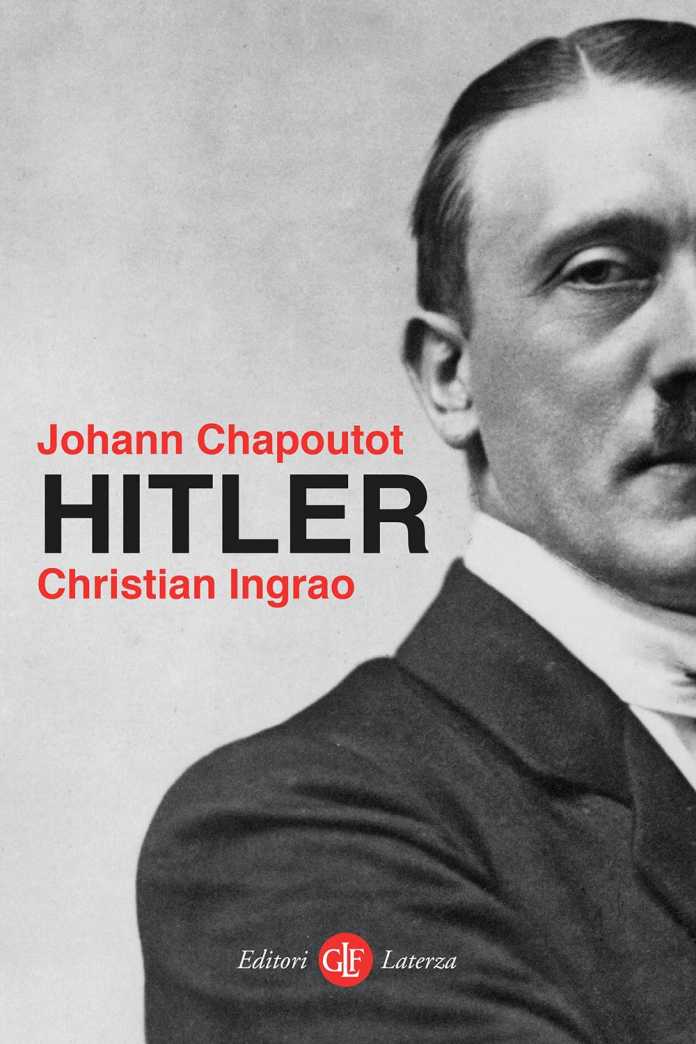Condensare in solo 140 pagine la biografia personale e politica di Adolf Hitler potrebbe apparire un’impresa insensata. Decine di volumi monumentali, come quelli di Ian Kershaw o di Joachim Fest, ne hanno riempite a migliaia per scandagliare e documentare ogni dettaglio ricostruibile sulla vita e la personalità del Führer del Terzo Reich e il libretto di Johann Chapoutot – professore di Storia contemporanea alla Sorbona – e Christian Ingrao – direttore dell’Istitut d’Histoire du Temps Présent di Parigi – non aspira a fare altrettanto. Come spiegano i coautori nell’introduzione “abbiamo cercato di considerare Hitler un condensato, o se si preferisce come il catalizzatore di forze che si sprigionano dalla vertiginosa mutazione di quei sistemi economici, sociali e cognitivi che costituiscono l’Europa […] tra la fine dell’Ottocento e la Grande Guerra…”. Il testo, scorrevolissimo, riesce a sintetizzare egregiamente i contenuti essenziali dell’oggetto della ricerca in dieci capitoli in ordine cronologico: la gioventù, fino all’abbandono della nativa Austria per la Baviera; la Prima guerra mondiale; le conseguenze della guerra; la nascita dell’ideologia nazionalsocialista fino al Putsch del 1923; l’esordio in politica e la conquista parlamentare della Cancelleria; la presa di potere e l’instaurazione del regime; l’inizio dell’espansione, la militarizzazione e l’avvento del Grande Reich; la Seconda guerra mondiale; l’adozione delle politiche genocide; la caduta finale.
Utilissimo compendio, il denso volumetto riesce a riepilogare con grande chiarezza e precisione gran parte delle questioni principali attinenti al nazionalsocialismo e al suo capo. I due storici per altro sono fra i maggiori studiosi di lingua francese dell’argomento: Chapoutot ha scritto numerosi volumi di grande interesse – ricorderemo solo gli ultimi titoli: Il nazismo e l’Antichità (Einaudi 2017), La rivoluzione culturale nazista, (Laterza 2019), Nazismo e management: liberi di obbedire (Einaudi 2021) – mentre Ingrao è noto in Italia solo per il suo Credere e distruggere. Gli intellettuali delle SS (Einaudi 2012). L’intenzione degli autori – perfettamente realizzata – non è però in questo caso l’approfondimento di un tema specifico ma l’elaborazione di “una rapida sintesi che dia testimonianza di un modo di fare storia a largo raggio, internalista, che arriva al cuore di quel fenomeno tormentato che è il nazismo passando dal cupo ingresso rappresentato dal suo dittatore”.
Il “ritratto del tiranno da giovane” viene tracciato nel primo capitolo individuando già tutti gli aspetti nodali del problema Hitler: il rapporto conflittuale col padre Alois e quello quasi morboso con la madre Klara; la mediocrità dello studente; l’atmosfera asfittica di un’Austria provinciale e ipercattolica e l’insofferenza per l’ancien régime multinazionale e multietnico della monarchia asburgica; la marginalità sociale a Vienna, dopo il fallimento delle sue ambizioni artistiche e l’avvicinamento alle pubblicazioni pangermaniste ed etnonazionaliste dell’estrema destra völkisch. Infine la decisione di abbandonare l’Austria-Ungheria nel 1913 per non dover ottemperare agli obblighi militari in un esercito multietnico e il trasferimento oltre le Alpi, a pochi chilometri di distanza, a Monaco di Baviera. Viene sottolineata l’essenza parassitaria del suo periodo da bohémien, del tutto privo però di qualsiasi contatto reale con la modernità, con i movimenti dell’espressionismo tedesco e con la Lebensreform intellettuale e artistica.
L’esperienza della guerra lo vede arruolato volontario nel 1914 in un reggimento bavarese sul fronte dell’Yser in Belgio. Nominato staffetta e agente di collegamento dimostra attitudini ad avanzare sul campo che non lo portano però oltre il grado di caporale. Non è un soldato inetto, viene ferito due volte nel 1916 e nel 1918, da schegge di shrapnel e dagli effetti dei gas: sarà decorato con tre medaglie, croce di ferro di seconda classe. La capitolazione lo coglie incredulo, perfettamente allineato alla narrazione, diffusa dagli alti comandi militari per scaricare la responsabilità della sconfitta sui civili, della pugnalata alle spalle da parte dell’anti-Germania dei socialdemocratici, delle sinistre e degli ebrei. Defilato e attendista nel primo dopoguerra resta nella Reichswehr e, dopo un corso ideologico di una settimana, esercita per la prima volta nel 1919 le sue capacità oratorie in un corso di formazione rivolto alle giovani reclute per la causa nazionale e contro il bolscevismo.
In missione politica di sorveglianza il caporale Hitler raccoglie informazioni sui molti gruppuscoli che agitano il sottobosco bavarese ed entra in contatto con il DAP, Deutsche Arbeiterpartei, Partito tedesco dei lavoratori, di Anton Drexler, una di quelle organizzazioni social-nazionali finanziate da industriali e borghesi perché in grado di attrarre le masse proletarie reindirizzandole da potenziali simpatie bolsceviche verso la causa nazionalista. Qui si farà prendere dal gioco, terrà discorsi, verrà applaudito e in breve aderirà entusiasticamente alla DAP, con la tessera n. 55. Nel giro di pochi mesi dalla sua iscrizione, per rendere più convincente l’appello rivolto sia a destra che a sinistra, il DAP cambia nome e aggiunge l’aggettivo “nazionalsocialista” alla sigla, che diventa NSDAP, ottiene finanziamenti dalla borghesia imprenditoriale cittadina e si dota di un giornale, il Völkischer Beobachter. Hitler non è quindi il fondatore del partito nazionalsocialista, né, tantomeno ne è il capo. Almeno per ora. È solo nel 1921 che, minacciando le dimissioni se non gli sarà riconosciuta la supremazia, Hitler diventerà il Führer, il capo incontrastato, per ora solo del partito.
Altri capitoli particolarmente interessanti sono quelli che analizzano il fallimento del Putsch del 1923 e l’irrealistico progetto di una marcia su Berlino una volta assicuratisi il controllo del Land bavarese; i nove mesi di detenzione privilegiata nel carcere di Landsberg e la scrittura del Mein Kampf; la scarsa fortuna del partito durante il “quinquennio aureo” della Repubblica di Weimar, tra il 1924 e il 1929, e il suo affermarsi solo dopo la crisi di Wall Street e la rottura politica della Grosse Koalition tra SPD e destra: crisi politica ed economica innescano un’avanzata che porterà il NSDAP dal 2,8 % dei voti del 1928, al 37 % del 1932. La strategia parlamentare si è rivelata vincente e il presidente Hindenburg e il cancelliere uscente Von Papen, sottovalutandolo, chiamano Hitler alla Cancelleria. Un comportamento, notano acutamente gli autori, che ricorda quello di Adolphe Thiers nel 1848-49, quando conservatori e liberali sostengono Luigi Napoleone Bonaparte portandolo alla carica di Presidente della Repubblica francese nell’illusione di poterlo in seguito manipolare e addomesticare. Scommessa persa sia nei riguardi di Bonaparte che di Hitler.
Poi la “messa al passo”, la Gleichschaltung, della Germania dal 1933, lo slittamento rapido verso il partito unico e la formazione del Deutsche Arbeitsfront, DAF, il Fronte tedesco del lavoro: la via corporativa germanica, fine di ogni possibile ipotesi di lotta di classe. L’eliminazione delle SA di Ernst Röhm nel 1934 – cioè del nazismo “di sinistra”, plebeo, proletario, che dopo la rivoluzione politica vuole una rivoluzione sociale – da parte di Gestapo, SD e SS, che segna l’affermarsi definitivo di Heinrich Himmler soddisfacendo il bisogno d’ordine delle classi medie. Il cappio della Volksgemeinschaft è ormai ben stretto.
Il 1936 è l’anno che vede contemporaneamente l’affermazione internazionale di un’immagine rassicurante e pacifista della nuova Germania ai Giochi olimpici di Berlino (il rituale ancora in uso dell’accensione della torcia fu un’idea di Goebbels) e in contemporanea il riarmo e la rimilitarizzazione – con il conseguente entusiastico e incondizionato appoggio delle gerarchie militari che già dall’anno precedente passano da poche centinaia di migliaia di effettivi a oltre tre milioni, mentre la Reichswehr si trasforma in Wehrmacht – che porta ad una progressiva e inarrestabile espansione. Già nel 1935 la riannessione della Saar, poi della Renania nel 1936, l’Anschluss dell’Austria nel 1938, i Sudeti pochi mesi dopo, il resto della Cecoslovacchia all’inizio del 1939, infine nel settembre di quell’anno, dopo il Patto di non aggressione con i Sovietici dell’agosto, l’invasione della Polonia. Si parla ormai di Grossdeutsches Reich, e i quadri militari ne diventano gli artefici: Rommel è l’esempio tipico, capitano nel 1933, maresciallo del Reich nel 1941.
I successi della Blitzkrieg infatti non furono merito del presunto genio strategico di Hitler, ma interamente dei suoi generali – Guderian e Rommel in particolare – che disattesero o ignorarono gli ordini di arresto fino a Dunkerque, quando non poterono evitarlo. L’unico comando di Hitler, capo supremo dell’esercito dal 1938, a venir ottemperato dai sottoposti è stato dunque un madornale errore. Con la conquista del Lebensraum inizia la germanizzazione ad est e il genocidio: il “lasciar morire” per fame le popolazioni autoctone depredandole di ogni risorsa alimentare, diventa dall’estate del 1941, dopo l’attacco all’URSS, “far morire”, e infine, dopo l’attivazione degli Einsatzgruppen sul territorio, “uccidere”.
Tra il 1942 e il 1943 però le sorti del conflitto si ribaltano, la Fortezza Europa perde un pezzo dopo l’altro. Il 1944 vede lo sbarco delle forze alleate in Normandia ma soprattutto l’accerchiamento di Minsk da parte dell’Armata Rossa e la cattura di più di 200.000 soldati tedeschi: l’esercito dell’Est ha finito di esistere. Eppure, evidenziano Chapoutot e Ingrao, “il 50 % dei soldati destinati a morire in questa guerra dalla parte tedesca non sono ancora morti […] milioni di uomini adotteranno su vasta scala comportamenti generalizzati improntati al combattimento suicida per Hitler, per il nazismo e il Terzo Reich”: tra il ’44 e il ’45 infatti, due milioni e mezzo di soldati tedeschi moriranno in combattimento, in numero pari ai caduti dei cinque anni precedenti.
È proprio dal 1944, quando le cose vanno peggio per il Reich, che l’ossessione antisemita nazista spinge al massimo il massacro e il genocidio degli ebrei: “Con le spalle al muro non si può tornare indietro, abbiamo bruciato le nostre navi e alle nostre spalle c’è il mare” – annoterà Goebbels nel suo diario. Nel frattempo Hitler si rinserra nel bunker a dirigere plotoni inesistenti per difendere Berlino. Il suo suicidio, il 30 aprile del 1945 – non a caso Walpurgisnacht – viene presentato alla radio tedesca come la morte eroica di un soldato caduto con le armi in pugno contro il bolscevismo. Il nuovo cancelliere Goebbels lo segue poche ore dopo con tutta la famiglia e sarà l’ammiraglio Karl Dönitz ad ereditare l’ingrato compito di firmare la resa incondizionata alle forze alleate. Hitler ha voluto, fino alle ultime ore, trasmettere in eredità ai posteri un mito organizzato con cura da anni, come i progetti faraonici per gli edifici del Reich millenario commissionati ad Albert Speer in modo che, se distrutti, sembrassero false rovine romane: “Voleva foggiare la propria morte e la propria memoria mediante rovine peculiari e prefabbricate”.
Proprio contro la prefabbricazione di questo mito nefasto – ultima ambizione di Hitler e Goebbels – il lavoro dello storico è indispensabile, per ristabilire la verità contro i negazionismi sempre pronti a tentare di cancellare o minimizzare i crimini nazisti, e per smontare pezzo per pezzo il mito personale di Hitler, svelando la natura puramente congiunturale del suo temporaneo successo, nient’affatto dovuta a eccezionalità, onnipotenza o genialità. Questo libro ci riesce egregiamente.