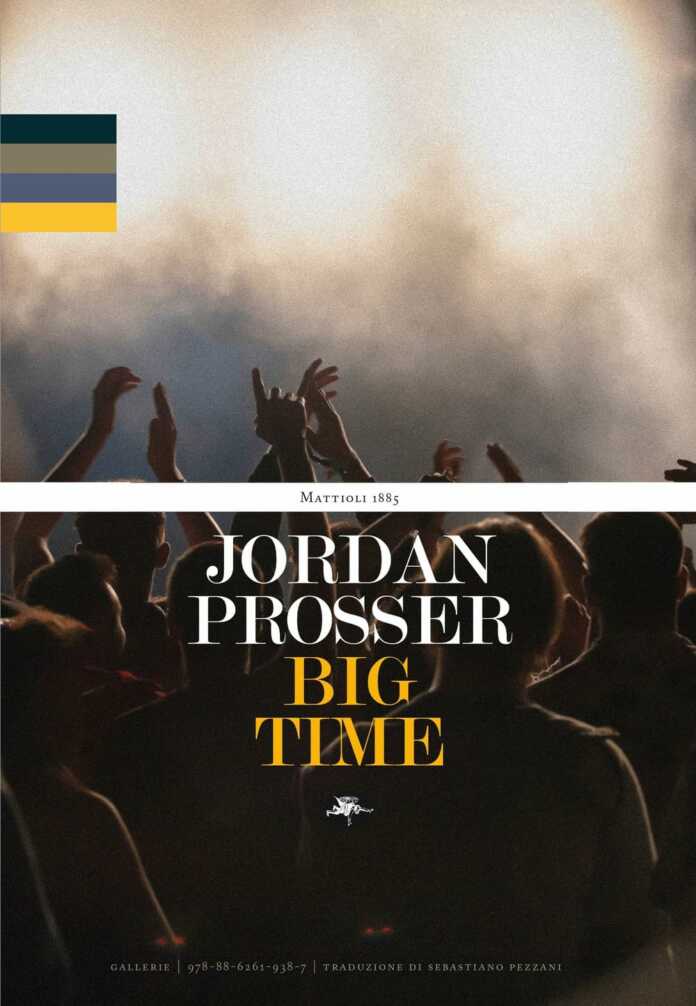Ci sono esordi letterari che lasciano il segno. È il caso di Big Time, di Jordan Prosser, che dalla regia e produzione cinematografica è passato alla penna (o alla tastiera di un computer) per creare una storia ambientata in un futuro prossimo, nella sua Australia, che immagina divisa all’altezza del 129° meridiano: nella FREA (Repubblica Federata dell’Australia Orientale), vige un feroce regime autocratico dalla “giurisdizione remota e assurdamente paranoica” che ha azzerato i diritti e proibito la scienza, con tanto di gulag e “Legge per la Purificazione Culturale”. Al centro della vicenda dai vari punti di fuga (Americhe, Russia, Europa, Giappone) si staglia Julian Ferryman, bassista di una band pop, gli Acceptables, che, tra liti interne, da commerciale si trasforma in centro di irradiazione del dissenso.
Tutto ha origine sul volo che dalla Colombia – dopo una vacanza e dove accidentalmente ha commesso un omicidio – lo riporta in patria, durante il quale scopre “F”, un potente allucinogeno sintetico che – simbolicamente – si instilla in gocce oculari, ed è in grado di proiettare la coscienza nel futuro, per lo più di poche ore; Julian però ha il “dono” di vedere molto più in là, facoltà che ne determina il destino, facendo di lui un telepredicatore eteroguidato, in una umanità sempre più alla deriva.
Scandita in quattro parti, un prologo e un epilogo che chiude come un cerchio un (forse) incubo lisergico, la vicenda si dipana con prosa scorrevole – da segnalare l’ottima traduzione di Sebastiano Pezzani, il testo presenta non poche difficoltà, anche per la inventività terminologica – lungo l’arco di alcuni decenni. Numerosi i personaggi, delineati con tocco lieve che non ne sacrifica la profondità: le interazioni tra i membri della band e il suo pittoresco entourage (suggestivo il personaggio di Skinner, manager e tuttofare, stagionato fricchettone pateticamente fuori epoca), sono convincentemente articolate, in particolare le dinamiche tra Julian e Ash, carismatico leader del gruppo, contrastata amicizia venata di tentazioni omoerotiche, e tra i due e Oriana, legata sentimentalmente ad entrambi nel classico triangolo amoroso, studiosa degli effetti di F (che non assume, è l’unica che preferisce “vivere il momento”), cospiratrice e deus ex machina della direzione ribellistica imboccata dagli Acceptables, creatori di una “musica incendiaria e apertamente politica, per quanto grezza”.
Nello psichedelico viaggio on the road che copre buona parte del racconto, in uno scenario da guerra civile dall’allure cyberpunk, tra “allucinazioni condivise”, “anomalie cronologiche”, “versioni degli eventi”, “scommesse con più alternative”, Julian è il tipico narratore unreliable: le sue visioni frammentate indotte dalla droga attingono ad un grado di surrealtà. Ma i livelli del racconto sono molteplici, a partire dalla voce narrante che si rivolge direttamente al lettore con l’uso del presente, quella di un suo amico aggregato al tour della band, che nella quarta parte afferma metaletterariamente la propria scomparsa, cedendo il posto alla narrazione in terza persona. Insomma, un ibrido narrativo, pieno di flashback e punteggiato di brani di canzoni, che se da un lato si espone al rischio di una certa confusione formale, dall’altro è rispecchiamento stilistico di uno dei motivi indagati dall’autore: il disorientamento esistenziale, la difficoltà di apprendere e trasmettere il reale a causa dell’impatto invasivo della tecnologia, della manipolazione delle coscienze, che rendono inattingibile la verità, nella lezione, ben assorbita da Prosser, di un Philip Dick. Una presenza ben discernibile insieme a quella di William Burroughs e James Ballard, per quel certo filone della science fiction che predilige lo spazio interiore dell’uomo a quello esterno, ed anche di Borges, con le sue suggestioni alephiane, la vertigine della numerologia, delle coincidenze e delle combinazioni infinite.
Di viaggi nel tempo la letteratura abbonda, ma Prosser trova il modo di attualizzare questo espediente letterario e metterlo al servizio del romanzo sociale. La possibilità di vedere ciò che accadrà genera un effetto dirompente: non più spazio della possibilità, il futuro si restringe in una trappola che riduce i margini di libertà, svuota di senso il momento presente privando di significato le decisioni, le scelte. Una dinamica che genera un senso di fatalismo e impotenza, un blocco emotivo e relazionale: “Stupefacente” riflette Julian “quanto, nonostante il dono delle preveggenze, tu possa sentirti paralizzato dall’indecisione”.
Tramite F, quindi, si invita il lettore a riflettere sul modo in cui le nostre aspettative plasmano la realtà, sulla consapevolezza che si ha o meno del reale, sulla libertà di scelta; e sulla natura del tempo, “big” in ogni senso, considerato “come un essere vivente”, lui sì consapevole “di essere osservato, manomesso e modificato. Esplorato, abusato e dissacrato”, dunque “sempre meno affidabile”. In balia della “tirannide della temporalità”, l’umanità qui rappresentata opera “una violazione senza precedenti dell’ordine naturale dell’universo”, con conseguenze esiziali: “abbiamo manomesso i confini naturali della nostra esistenza e delle nostre conoscenze, confini presidiati dal tempo”.
L’esplorazione – narrativa e filosofica – della percezione temporale in un contesto distopico si rivela vincente: vedere nel futuro trasforma il flusso temporale in uno spazio narratologicamente sempre riscrivibile, in una critica al vetriolo: Big Time è una pungente metafora della condizione umana contemporanea – in ciò ravvisiamo il suo più autentico significato. La rappresentazione della FREA come stato retro-fascista, i temi della sorveglianza di massa, della manipolazione dell’informazione, della mercificazione dell’esperienza umana, offrono una chiara visione di una realtà in cui siamo già immersi, motivi afferenti appunto alla tradizione del romanzo sociale, qui arricchito da humor nero, dal grottesco e dal surreale, che conferiscono un distintivo sapore a queste pagine, come nel caso delle visioni collettive di un presunto paradiso post mortem, che lasciamo alla scoperta del lettore.
Ma che il romanzo sia una “ode antifascista al potere della musica pop”, come si legge sul sito dell’editore italiano, è dubbio e fuorviante. La critica proposta dal suo autore è ben più smaliziata; la lotta al sistema degli Acceptables (nome, ormai sarà chiaro, ironico) fallisce miseramente: i fan a cui il messaggio sovversivo dei loro testi è rivolto appaiono zombizzati, avvolti in una catatonia percettiva: “Quand’è stata l’ultima volta in cui avete pensato con la vostra testa?” è solito chiedere provocatoriamente il frontman, Ash, al suo pubblico. La rivolta, in un mondo che è “una simulazione in 3D della vita”, in cui “le celebrità sono diventate criminali, i banchieri sono diventati celebrità e i criminali l’hanno fatta tutti franca”, avviene infine con distruttiva virulenza ma non passa dalla musica o dall’arte: il concetto della loro intrinseca rivoluzionarietà, romantico retaggio della temperie culturale dei gloriosi Sixties, è solo un nebuloso ricordo nella società postmoderna e tardo-capitalista qui tratteggiata, e ciò conferisce una spietata lucidità al romanzo.
In definitiva, Big Time ci pare un’opera ambiziosa, che fa tesoro della tradizione fantascientifica distopica cercando per certi versi di superarla, radicandosi nell’esperienza, politica ed economica, della contemporaneità. Il risultato è una sorta di “incubo” che, alla luce della devastante esperienza del Covid (nel testo il riferimento è diretto), dei pestiferi venti di guerra che gelano il mondo, dei rischi suscitati dal proliferare di tecnologie distruttive della privacy e minacciose per le nostre stesse intelligenze, del tramonto dei principi e dei valori democratici che hanno segnato una lunga stagione dell’Europa e del mondo occidentale, assume una concretezza allarmante. Questo parto della fantasia appare più reale di quanto osiamo immaginare, e la sua conclusione, che magari non soddisferà alcuni lettori per la sua visionarietà pessimistica, ci sembra la degna, coerente chiusa di pagine spaventose e avvincenti. In fondo, “in queste cose ci siamo tutti”, tutti siamo “una forma su una sfera in orbita nel tempo”.