Prima parte
Nell’ultima prova di “biologia della letteratura” di Alberto Casadei – per prendere in prestito il titolo di un suo saggio, piuttosto fortunato, del 2018 e applicarlo a un’opera dello stesso autore che non si lascia facilmente perimetrare nelle tassonomie letterarie conosciute – ovvero in Anni ombra (ed. Polidoro, 2025), fa a un certo punto capolino un’entità pronominale ibrida, un “io-lui”. Non è soltanto la manifestazione di una determinata alienazione sociale, ma anche un’allusione iper-consapevole, per quanto da una certa distanza, a un genere letterario che negli ultimi anni ha conosciuto un grande sviluppo, forse ipertrofico, e adesso è probabilmente in una sorta di declino, o di ritirata – analogamente alle dinamiche intradiegetiche della prima persona singolare, nei singoli testi – come l’autofiction.
A suggerire questa parabola, o anche ad anticipare una certa chiusura del cerchio, si aggiunge ora la ripubblicazione, dopo vent’anni esatti, di uno dei primi libri italiani ad avere intrattenuto un rapporto, complesso e articolato con la categoria di autofiction, ovvero Anatomia della battaglia (ed. TerraRossa, 2025) di Giacomo Sartori – testo che, peraltro, invoca una declinazione più immediatamente referenziale della biologia citata in apertura. La battaglia citata nel titolo, infatti, è una battaglia vissuta nel corpo dal padre del narratore, contro un tumore maligno; il lessico militare non proviene tanto dall’ormai tristemente nota retorica militare del discorso medico, quanto da una chiara analogia, istituita fin da subito nel testo, tra la malattia del padre e il suo personale culto della guerra, di marca fascista. Come ha rilevato Jacopo Manna in un’acuta recensione pubblicata su Laletteraturaenoi, Anatomia della battaglia «non [è] l’ennesima saga di famiglia: […]. Non una storia di conflitto generazionale […]. Nemmeno un romanzo sugli anni di piombo. […] E tutto sommato nemmeno un Bildungsroman, almeno nel senso usuale del termine», perché, pur condividendo elementi di tutti questi generi e sotto-generi, «[t]ra gli eventi in cui è più evidente l’investimento di energie e risorse da parte dell’autore spicca senz’altro la storia della malattia e morte del padre […]. Anatomia della battaglia è anche la storia di una costruzione di sé che però sceglie di attenersi a ciò che abbiamo di più immediato e di più sfuggente, il nostro corpo appunto».
Allo stesso tempo, però, quella di Sartori non è neppure soltanto la biologia di un padre – per ricalcare l’espressione di Magrelli nel titolo della sua fortunata opera einaudiana del 2013 (dove alla biologia si sostituiva, in realtà, la geologia) – ma anche un esempio assai rilevante di autofiction. E non tanto perché, come vorrebbe la vulgata, si tratti di un testo che allarga la dimensione della prima persona singolare, includendo elementi ad essa esterni (in funzione di una loro qualità più chiaramente fictional), ma proprio per il costante, e irrisolto, ondeggiamento della prima persona singolare nei confronti di tali elementi. Un ondeggiamento già esplicitamente descritto come tale, ovvero come «perpetua oscillazione tra autobiografia e fiction», in uno dei primissimi esempi di autofiction mai rivendicati come tali, ovvero Fils (1977) di Serge Doubrovsky, e che torna, in Sartori, con particolare evidenza nei due paratesti di cui è ora corredato Anatomia di una battaglia.
Nella nota del 2005, è forse più evidente l’orientamento verso la fiction: «Nelle pagine di questo libro vivono personaggi che possono sembrare persone reali. Essi nascono invece nelle parole che si succedono una dopo l’altra e muoiono nelle parole», e così via, fino a decretarne la qualità onirica: «Sono lì forse per capriccio, o magari per suggerire verità che fatichiamo a penetrare. Come succede nei sogni» (Sartori 2025, p. 264). Nella postfazione del novembre 2024, il movimento sembra essere, à rebours, verso l’io: «Io non avrei dovuto esserci in questo romanzo. E nemmeno un personaggio che per tanti aspetti mi assomiglia», inclusione che poi diventa necessaria come quella degli «esami di coscienza», all’interno di un tormentato processo di assunzione di responsabilità: «era soprattutto la mia vita privata a aver ricevuto le eredità di quell’epoca che i più consideravano ormai lontana, e che io stesso avevo faticato a disseppellire. Quindi parlare di [mio padre] era anche parlare di me e del mio percorso, e riesumare l’origine delle mie scelte di vita» (p. 265).
Nella sua recensione per Allegoria, Andrea Inglese definiva una simile oscillazione come «piena realizzazione delle potenzialità conoscitive proprie del genere romanzesco»; pur riconducendola qui alle maglie, spesso larghe o larghissime, dell’autofiction, non si intende di certo sminuirne il grado e la complessità del processo di formalizzazione. Peraltro, quel «non avrei dovuto esserci» della postfazione getta una luce ancora diversa sulle varie dichiarazioni di inettitudine del protagonista, e narratore in prima persona, ad esempio su questa: «Come il solito non ero né da una parte né dall’altra, ero dove non avrei voluto essere» (p. 246). Rispecchiamento che sfiora addirittura la mise en abyme quando il narratore parla del proprio libro, un «romanzo per certi versi autobiografico» (p. 122) in uscita nello stesso periodo dell’agonia del padre.
Con ciò, non si vuole sottolineare un preziosismo formale fine a se stesso, o il fatto che tutto si tenga, nella narrazione; al contrario, lettura e scrittura restano sullo sfondo di tutto il testo, venendo di volta in volta trattate con spietata lucidità autocritica come forma di escapismo, battaglia a propria volta persa con la realtà, palliativo. Spietatezza che non di rado sfiora l’autoflagellazione: «ero quello che viene definito un debole, lo sono sempre stato» (p. 10), si legge già nelle prime pagine del libro, dichiarazione seguita da numerose conferme nel resto del libro, che vanno dalla scarsa resistenza a un desiderio sessuale attraversato da ineludibili questioni di potere, nel corso dell’esperienza africana del narratore, alla manifestazione di quella specifica forma di odio che è il lascito introiettato del culto fascista della violenza e della guerra del padre.
Ed è proprio in questa eredità scomoda che si delinea più compiutamente la fisionomia del fascismo, e non solo della personalità autoritaria, nella scrittura di Sartori. Più che retorica mussoliniana, fascismo è allora un disciplinamento della persona e, in seconda battuta, della collettività: «comportarsi come un vero fascista, o comunque – quando il fascismo non esisteva più da anni – come la sua nostalgia del fascismo gli faceva credere che bisognasse comportarsi» (p. 156), legittimando quindi il culto della violenza, simboleggiato in primo luogo dal frequente ritorno della «GUERRA». Quest’ultima una delle tante parole scritte in maiuscolo che costellano il testo, con un’enfasi diversa da quella che potrebbe dare il corsivo, e che denota, quindi, un travaso della violenza fascista anche nel linguaggio quotidiano; l’importanza simbolica della guerra, tuttavia, è preminente, laddove impone una serie apparentemente senza fine di comportamenti, mentre agita il fantasma di quel conflitto armato che avrebbe reso impossibile la deviazione da una certa norma.
In questo senso, uno dei pilastri del fascismo è l’esaltazione della giovinezza, emblematicamente usata come titolo di una famigerata canzone del ventennio: «il fascismo è sempre stato dalla parte dei giovani e dell’energia vitale» (p. 124). La malattia del padre interviene, da un lato, a rafforzare questo mito della giovinezza e, dall’altro, a scardinarlo; il libro si apre infatti con la decisione del padre di mangiare i prodotti del proprio orto anche durante l’interdizione per la radioattività in fuga dai reattori di Chernobyl – decisione commentata così dal figlio: «Io sono sicuro che se l’è preso mangiando l’insalatina radioattiva e gli altri prodotti contaminati del suo orto, il linfoma» (p. 105). Mostrandosi sprezzante del pericolo, il padre agisce secondo un monolitico dettato vitalista – nutrito peraltro, nei primi anni Novanta, da una generalizzata e qualunquista sfiducia verso il panorama politico e mediatico dell’Italia di Tangentopoli.
La narrazione segue poi, con afflato spesso diaristico, il decorso della malattia del padre, assumendo via via sempre di più i toni della Lettera al padre kafkiana; la battaglia contro la morte non esclude nemmeno momenti di resipiscenza autoritaria, o anche fascista, nel caso di un doppio compleanno vissuto, durante la fase finale della malattia come «una celebrazione fascista, un perfetto rito nazifascista» (p. 185). La guerra, evocata con nostalgia per tutti i decenni post-conflitto mondiale, continua così a svolgersi su più livelli, da quello biologico a quello famigliare a quello ideologico-politico, continuando così, letteralmente fino allo stremo, lo stato di guerra civile – secondo la definizione dello storico Claudio Pavone, ormai accolta nella storiografia italiana della seconda guerra mondiale – inaugurato dall’insorgere della Resistenza.
Due capitoli di importanza decisiva, nell’economia del libro, si hanno tuttavia in precedenza, con l’adesione da parte del figlio e narratore alla lotta armata di ispirazione comunista, prima, e con il lavoro di cooperazione in un paese africano: meritano trattazione separata, nella seconda parte di questo intervento, poiché completano il quadro di storia dei generi – tra autofiction e “nostalgia dell’azione”, secondo la fortunata definizione coniata da Gianluigi Simonetti per la “fortuna della lotta armata nella narrativa italiana degli anni Zero” – in cui si è inserita, e torna ora a inserirsi, Anatomia della battaglia.
Seconda parte
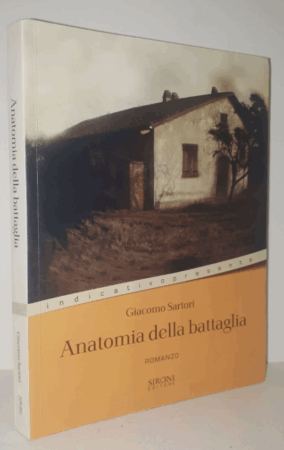 Nella molteplice battaglia “anatomizzata” da Sartori, riveste un’importanza fondamentale il travaso del culto della violenza – nella sua forma forse più semplice e immediata, dell’odio – dalle nostalgie di fascismo del padre alla lotta armata del figlio. Quest’ultima è di segno politicamente contrapposto, ma non “opposto”, per non cedere a quella dicotomia liberal degli “opposti stremi” su cui nemmeno il testo, a dire il vero, si adagia mai del tutto.
Nella molteplice battaglia “anatomizzata” da Sartori, riveste un’importanza fondamentale il travaso del culto della violenza – nella sua forma forse più semplice e immediata, dell’odio – dalle nostalgie di fascismo del padre alla lotta armata del figlio. Quest’ultima è di segno politicamente contrapposto, ma non “opposto”, per non cedere a quella dicotomia liberal degli “opposti stremi” su cui nemmeno il testo, a dire il vero, si adagia mai del tutto.
Come sottolinea anche Simonetti in questo importante saggio di qualche anno fa, nel libro di Sartori è possibile ritrovare anche le «tracce di una riflessione sui legami profondi tra l’eredità della Resistenza e i “compagni che sbagliano”, e tra questi e il cuore del Movimento» – aspetto che l’accomuna a testi, per altri versi dissimili, come Tuo figlio (2004) di Gian Mario Villalta e Piove all’insù (2006) di Luca Rastello. Sartori, in particolare, perviene a una critica serrata dell’antifascismo post-bellico più salottiero e opportunista (come in quest’asserzione indubbiamente fondata, benché utilizzata spesso, e spesso da destra, come cliché: «Prima erano quasi tutti fascisti convinti, adesso invece sono altrettanto sfegatatamente antifascisti», p. 85): una sorta di moto delusivo e reattivo, per il narratore, che sembra collocarsi all’origine della sua adesione alla lotta armata almeno tanto quanto il rapporto con il padre e le sue nostalgie fasciste.
Naturalmente, l’impresa armata, per quanto porti con sé la violenza dell’astrazione, non è soltanto una conseguenza dell’analisi politica, rivelandosi un’esperienza capace di coinvolgere interamente il narratore, con una serie di gravi implicazioni morali. Lasciandone la scoperta a chi vorrà leggere o rileggere Anatomia della battaglia, risulta però evidente il senso di colpa provato dal narratore per questa stagione esistenziale e politica. Non sono, in ogni caso, i vaghi tormenti del rimorso (lasciati sullo sfondo di questa narrazione, che pur essendo anche una storia della provincia montanara clerico-fascista italiana, si mantiene, dal punto di vista culturale, laica), ma un percorso di autoanalisi spietata, che porta infine a un’assunzione di responsabilità precaria, priva di quella maturazione piena che avrebbe luogo in un Bildunsgroman più ortodosso.
La medesima ferocia nell’autoanalisi è applicata anche al periodo di lavoro che il narratore svolge in una nazione africana, la cui realtà – più volte definita «postcoloniale», in ossequio a uno studio che negli ultimi decenni ha attecchito anche in Italia – induce la sua inettitudine a invischiarsi presto in comportamenti e azioni neocoloniali (un aspetto persistente, anche in epoca postcoloniale, per la permanenza del dominio e del discorso ideologico del dominio di marca occidentale). In questo contesto, assurge a possibile contraltare soltanto il successivo matrimonio del protagonista con Nora, donna che invece porta l’eredità del conflitto anticoloniale algerino, in un processo di elaborazione generalmente più positivo e compiuto di quello abbozzato dal narratore.
Così come la relazione affettiva tra i due è infine destinata a naufragare, tutte le tensioni politiche che attraversano il testo non trovano mai sintesi: sembra valere, dunque, anche per Anatomia della battaglia il giudizio che Simonetti, nella sua ricognizione critica, limita ad altre opere, ossia il fatto che «il romanzo» o, in questo caso, un esempio peculiare di autofiction, «tende […] a mettersi a lato della Storia; a parlare di impotenza, a illuminare ciò che non si vede». Quella di Sartori è, anzi, la narrazione paradigmatica dell’impotenza che, da groviglio psicanalitico individuale, riverbera anche su un livello autoriale e intellettuale più generale; Anatomia della battaglia, è vero, indulge sporadicamente nella spettacolarizzazione del terrorismo che emerge in una porzione dei testi censiti da Simonetti, ma ha anche – si ricorderà la nota di Sartori del 2005 – quella qualità onirica della narrazione che poi sarebbe esplosa in uno dei romanzi più importanti degli anni Zero, Il tempo materiale (2008) di Giorgio Vasta.
In conclusione, Terrarossa edizioni ha senza dubbio individuato nel libro di Sartori – già apparso vent’anni fa in una collana importante come quella curata da Giulio Mozzi per Sironi – uno di quei testi “Fondanti” (questo è, senza timori di sorta, e anzi con molte conferme, il titolo della collana che ha accolto Anatomia della battaglia) per la letteratura italiana contemporanea che oggi pare davvero necessario riproporre. Esponendo con estrema, talora feroce, lucidità la permanenza di un’educazione e, più in generale, di una cultura fascista nel secondo Novecento italiano – e da verificare ancora, fino allo scenario odierno e al prossimo futuro – Anatomia della battaglia è un testo che interpreta in modo peculiare le questioni aperte dalle declinazioni autofinzionali della scrittura, approfondendole a tal punto che la sua riproposizione, dopo vent’anni circa dalla prima pubblicazione, sembra la chiusura del cerchio, e di un ciclo, dal punto di vista della storia dei generi nella letteratura italiana contemporanea.
Chissà che non se ne apra presto un altro.



