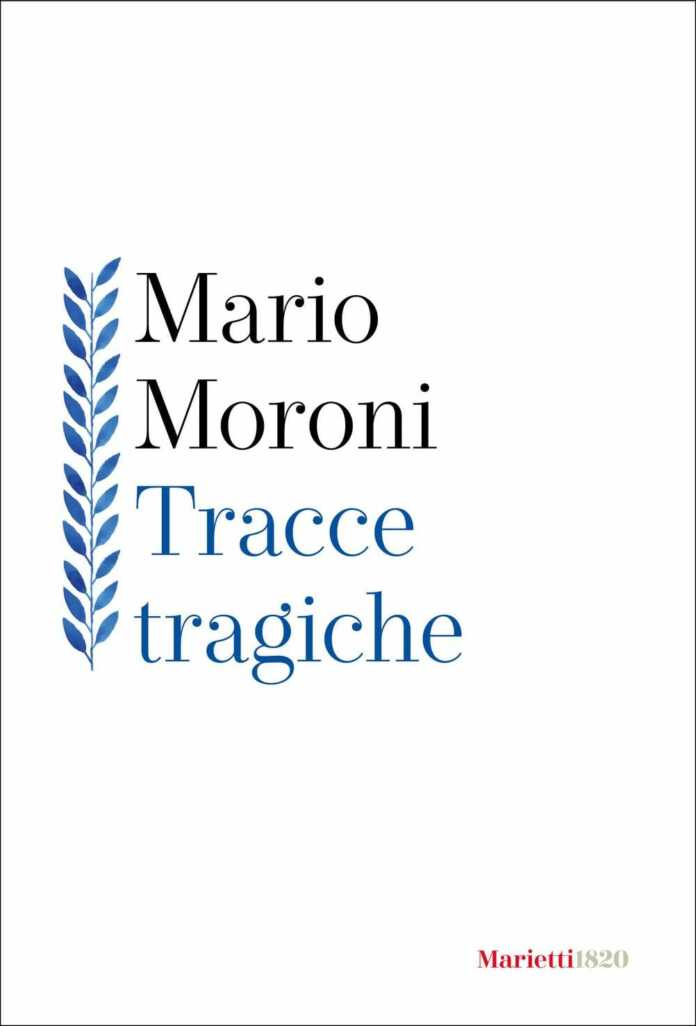Mario Moroni, classe 1955, ha attraversato gran parte della scena poetica italiana mai uniformandosi al mainstream che creava diversità presuntuose e tribù a dir poco esigenti e enfatiche nel pieno delle loro prove. Mario ha viaggiato razionalmente da Tarquinia al Maine e New York, l’Oceano di mezzo ha sostenuto mutamenti dall’esordio nel 1979 dalle parti del Mulino di Bazzano dove le semine poetiche avevano i nomi di Adriano Spatola e Giulia Niccolai e quelli erano davvero “altri luoghi” e “assolutamente attuali” per quel tempo e – possiamo dire – oggi, se vogliamo far leggere e intendere ai più vogliosi una storia della poesia italiana esente d’intelligenze aliene.
L’esperimento poetico di Moroni ha attraversato i decenni con libri sempre più antropici, nati in luoghi adatti a lavorare in pace, che non significa stare lontani dagli eventi, anche i più terribili. Uno scrittore serio ma non severo ha saputo raccogliere le ceneri del mondo con ferma levità. Ha ricomposto resti, manufatti e carne umana: nomi precisi, una decina di raccolte poetiche, collaborazioni a riviste, insegnamenti alla Yale University, al Colby College, alla Binghamton University.
Esperimenti e leggibilità, scritture che non sempre hanno avuto bisogno della cosiddetta realtà, e infine in questo ventennio impazzito Moroni fa ri-nascere il proprio linguaggio dove come poeta non deve niente al buio attuale. Ma, improvvisamente, supera il lutto trasfigurando la classicità greca e latina. Poemi e tragedie non vengono imitati ma riverberano immagini di sforzo senza distrazione: l’esistenza di uno sguardo è testimoniata da Tracce tragiche, ripresa delle grandi tragedie classiche di Antigone, Elettra e Medea. Sfida e interazione con l’originale riportano nuovamente all’antico gesto del narrare la ferita di queste voci e corpi lontani. Gesti eroici di donne, efficacia di tradimenti, gesti di pietà che annunciano la civilizzazione, è quanto interessa a Moroni mentre costruisce tre lunghi poemi sulle tracce di Sofocle e Euripide. Ambienti e personaggi femminili vengono strappati dal tempo del potere originale la cui struttura viene ribaltata nella metropoli contemporanea, nella per niente simbolica figura della “T-Tower”, erede negativissima delle distrutte Twin Towers”.
Corinto regno del dissesto si ribalta nella New York attuale, dove i destini attraversano l’ombra, creatori essi d’ombre che atterrano chi credeva e sperava, e chi non credeva: Moroni accompagna le Medee pasoliniane e i Giasoni con sospensioni, interazioni e Cori di scena finale. Al centro del libro il “Monologo elettrico di Elettra” apre la storia vocativa, in attesa dell’Epilogo, e sembra riprendere la vocazione analitica di Moroni che consente alle strofe di recitare sia se stesse sia Elettra con la sorella Ifigenia. Queste ci sfiorano ancora, poiché i versi multiformi del poema invogliano a non essere più astemi di miti incarnati d’eroine più che di dèi migrati altrove per sempre.
Con Tracce tragiche è giunto il momento in cui le acque del mito, agitate tanto da consegnarle alla torbidità da coloro che vantano modesta conoscenza, trovano nitidezza d’antica poesia a cui pochi oggi sono accordati. Laggiù, dove vive Moroni, qualcosa si muove, c’è una domanda che pretende atto di risposta. Il presente e il passato non si assimilano, oggi un poeta come Moroni prende il canone classico non come funerario assemblement e felicemente scrive: «Su scena rovesciata, / coro che tace, incapace, / tragedia da riscrivere, / da rivedere altrove».