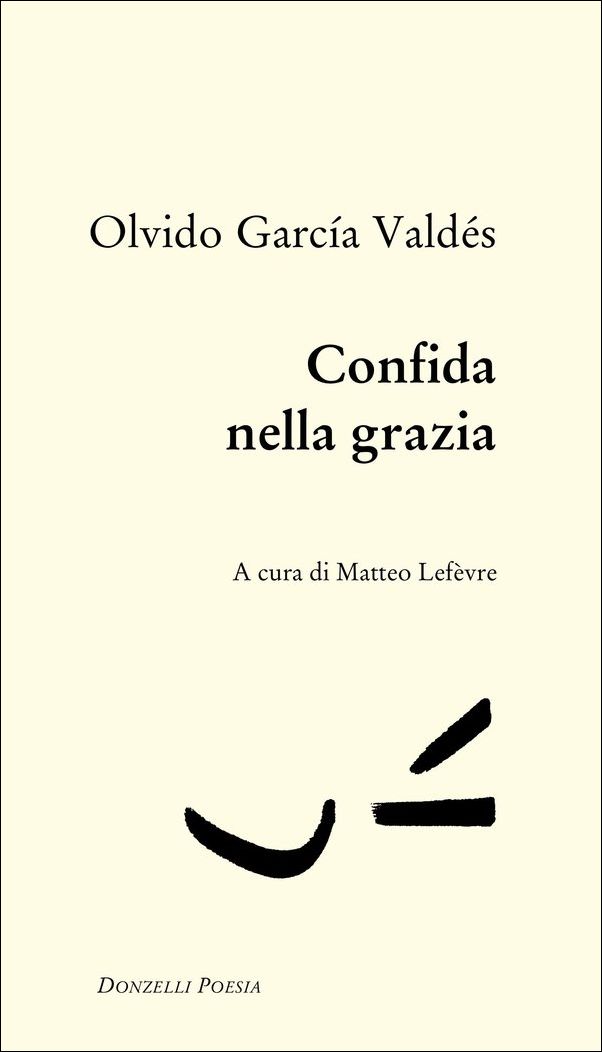Finalmente! Questo, innanzitutto, si può dire della nuova pubblicazione della collana di poesia della casa editrice Donzelli: Olvido García Valdés, finalmente! L’esclamazione, tuttavia, necessita di una precisazione: l’autrice, nata nel 1950 in un piccolo centro delle Asturie, non era del tutto inedita in italiano: già nel 2012, Matteo Lefèvre – raffinato traduttore e curatore anche del presente volume – aveva tradotto una selezione antologica di Poesie di García Valdés a cura del poeta e musicista Mariano Peyrou per la piccola ma preziosa casa editrice Raffaelli. Tuttavia, Confida nella grazia è il primo libro di García Valdés che trova traduzione integrale – l’originale Confía en la gracia era uscito in originale per Tusquets nel 2020 – rendendo così conto di un percorso letterario che nel frattempo si è definitivamente consolidato, come dimostrano, ad esempio, riconoscimenti importanti come il Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2021) e il Premio Reina Sofia de Poesía Iberoamericana (2022).
Naturalmente, i premi di poesia non sono quasi mai un buon metro di giudizio, specie se adoperato in modo esclusivo rispetto ad altre considerazioni: la loro recentissima acquisizione da parte dell’autrice testimonia piuttosto, e con qualche motivo di interesse in più, di come l’opera di García Valdés abbia «faticato a essere pienamente riconosciuta», come scrive Matteo Lefèvre nella densa postfazione, «e ciò non per ragioni di merito, bensì per i comodi (pre)giudizi di una critica – quella delle istituzioni accademiche, in primis – che ha perpetuato per anni una storia letteraria fondata in modo fin troppo automatico sul metodo generazionale e sull’apprezzamento dei gruppi più rumorosi e “visibili”, ai quali García Valdés non ha desiderato appartenere». Con questo, non si tratta soltanto di smentire considerazioni assai censurabili, anche dal punto di vista critico, come quelle di Chus Visor – patron di una delle case editrici di poesia più importanti di Spagna: Visor, appunto – che, ancora nel 2015, sentenziava come «dalla generazione del ’98 e in tutto il XX secolo non c’è stata nessuna grande poetessa [in Spagna], nessuna». È una dichiarazione abnorme, facilmente attaccabile (basti ricordare, tra i tanti, il nome di un’autrice coetanea di García Valdés come Ana Rossetti), che è stata ricordata da Laura Pugno su “Tuttolibri”, in una delle pochissime recensioni a questa traduzione italiana (a conferma, tra l’altro, di una consuetudine all’invisibilità che trova riverbero anche nel panorama italiano). A questo si aggiunga anche il nome di uno dei «gruppi rumorosi e “visibili”», peraltro esplicitamente menzionato da Lefèvre: si tratta di quella poesía de la experiencia, dai contorni sfumati come solo possono essere quelli di una sedicente “poesia dell’esperienza”, il cui esponente più noto, anche in Italia, è Luís García Montero (di qualche anno più giovane di Olvido García Valdés e, dal 2018, direttore dell’Instituto Cervantes).
Come anticipato, la scrittura poetica di García Valdés trae invece vantaggio dalla propria resistenza alle tassonomie (o meglio, dalla propria continua ricerca di nuove tassonomie, come ad esempio quelle che sono state elaborate negli ultimi anni dal marito, il critico letterario Miguel Casado); come recita l’attacco di un suo testo: «tutte le forme sono oggi possibili / anche in una città piccola, pensa / alle donne, ai modi di vivere, o / più in generale, a un io che sa incassare / forti colpi…».
Rilevava José-Miguel Ullán (poeta di importanza capitale nel secondo Novecento spagnolo, e assai diverso da García Valdés, se non per l’interesse comune per le arti visive) che di García Valdés si potrebbe dire quello che lei stesso ha scritto di Patti Smith: “la sua voce nasce dalle viscere e brucia in gola”. Nessun maledettismo, tuttavia, e nessun misticismo d’accatto: è vero che il titolo del libro, Confida nella grazia, è una sorta di mantra ripetuto in vari testi del libro, ma – pur essendo certamente accattivante e al tempo stesso insidioso – non è paragonabile alla melassa che potrebbe sortire dal medesimo titolo in un libro di poesia italiana contemporanea. García Valdés, che ha dedicato un saggio a Teresa di Lisieux nel 2001 e mostra, in questo libro, una frequentazione profonda di un “mistico non-mistico” come Edmond Jabés («il silenzio ci rende informi, ci rende / in forma di nube o in forma di lago, dice / Guirao e cita Jabés…»), conosce bene la mistica e i suoi segreti più reconditi e sorprendenti e, proprio per questo, confida spesso in una grazia più laica e diffusa di quella cristiana (lo si nota bene nel titolo di una delle sezioni più intense e, per chi scrive, impressionanti: «che ridere ero (sacramentale laico)».
A tratti, tuttavia, si sente “troppa grazia” – si potrebbe forse ironizzare, raccogliendo una suggestione di Laura Pugno: “Ogni testo di questa raccolta inizia e finisce, ma è come se non iniziasse e non finisse, si genera in un flusso continuo che può sempre dar luogo ad altra poesia”. Se è certamente vero che il libro avrebbe potuto essere scorciato e reso, così, più compatto e incisivo, ciò non deve dare adito al sospetto – schivato anche da Pugno – che la scrittura poetica di García Valdés sia in qualche modo automatica (molti passaggi sono certamente legati a matrici surrealiste, ma queste ultime vanno ben oltre l’automatismo), o comunque infinitamente replicabile, perché, ad esempio, cristallizzata in alcuni, determinati stilemi.
Il segreto di questa sorgente continua – di questa “grazia”, appunto – sta in uno dei testi conclusivi, in alcuni versi, che conviene riportare pedissequamente: «ci sono colori che riempiono gli occhi, sono l’allegria / […] sono / l’allegria – non è allegria la mistica? – forse un’altra / allegria più assorta – non era / in cucina? – certo che lo era // – e tutto ciò apparteneva al presente? – a un presente / che non finisce e non esiste, non è una cosa anche se / si costruisce, subito passa e resta lì / invisibile, ma è reale e indica o annuncia / quanto accade nel giorno». Allo stesso modo, la poesia di García Valdés, che è restata a lungo invisibile in Spagna e, di riflesso, anche in Italia: è una poesia reale, concretissima, e indica o annuncia quanto accade nel giorno, sempre più breve, della poesia.