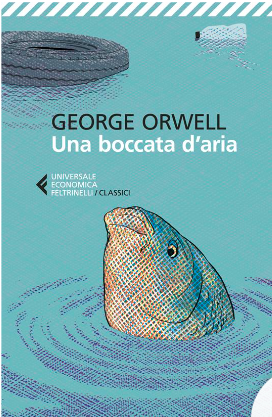 In una conversazione con il curatore di questa nuova edizione (con una traduzione finalmente all’altezza della situazione) di Coming Up For Air (Una boccata d’aria, a cura di Andrea Binelli, Feltrinelli, pp. 354, € 13,00), l’ultimo romanzo di Orwell prima dell’accoppiata che gli diede fama imperitura (Animal Farm e Nineteen Eighty-Four), Andrea Binelli mi diceva che l’autore britannico considerava quest’opera, scritta e ambientata nel 1938 e uscita nel 1939, come la sua più riuscita, quella che più gli corrispondeva nel dosaggio di elementi d’invenzione, di osservazione della realtà e di diagnosi su un presente impoverito moralmente nelle sue convenzioni sociali e nelle ricadute di queste sul comportamento degli individui, sulla loro etica ristretta a un orizzonte senza gloria. Non solo, diceva Binelli: in Una boccata d’aria echeggiano già le campane fantastico-fantascientifiche di quei due romanzi successivi: quelle della satira e del grottesco della Fattoria degli animali e quelle distopiche di 1984. Ora, confesso di dissentire da entrambe queste affermazioni. Una boccata d’aria è una bellissima, quasi irresistibile esperienza di lettura, il memorabile ritratto psicologico della miseria umana, di un esemplare in cui la miseria umana – quella dei tempi, della civiltà dei consumi, della mancanza di senso e di scopo in una società parcellizzata in unità individuali incapaci di riconoscersi in un disegno più complesso, negli altri – si incarna e si mette alla prova di un’ennesima Odissea moderna, raggrinzita al tempo di una settimana rispetto al modello classico e irriducibile alla dimensione neo-epica della dissacrazione joyciana: l’odissea di un modesto impiegato, un quarantenne piccolo-borghese già decrepito nel fisico (memorabile l’incipit del romanzo in cui il protagonista descrive le proprie abluzioni mattutine, il cui momento culminante è il posizionamento della dentiera in bocca) e soprattutto negli orizzonti ideali, che tenta la fuga dalle pastoie di una vita familiare e lavorativa infelice (perché non può esserci felicità in quelle istituzioni) attraverso il ritorno alla vagheggiata condizione edenica della propria infanzia, identificata con il paesello di campagna natio e simboleggiata da un laghetto scoperto dal protagonista nei suoi giovani anni e a lui solo noto, traboccante di carpe enormi e grasse, in attesa solo di essere pescate. Non le pescherà mai, quelle carpe, George Bowling (questo il nome del protagonista che narra la storia in prima persona), e anzi scoprirà che quello specchio d’acqua segreto non esiste più, è stato prosciugato e le sue cavità sono state adibite a deposito per i rifiuti del quartiere residenziale che ha preso il posto della campagna intorno al suo paese natale, ormai sfigurato da edifici popolari e da fabbriche fumanti, il cui principale compito è quello di produrre bombe per l’industria bellica di un conflitto che sembra ormai imminente. George si chiede se quell’epoca da lui vagheggiata sia perduta per sempre e si risponde in tono di disincanto: “Non ne sono sicuro, ma posso dirvi che era un bel mondo in cui vivere. E io gli appartengo. Anche voi”.
In una conversazione con il curatore di questa nuova edizione (con una traduzione finalmente all’altezza della situazione) di Coming Up For Air (Una boccata d’aria, a cura di Andrea Binelli, Feltrinelli, pp. 354, € 13,00), l’ultimo romanzo di Orwell prima dell’accoppiata che gli diede fama imperitura (Animal Farm e Nineteen Eighty-Four), Andrea Binelli mi diceva che l’autore britannico considerava quest’opera, scritta e ambientata nel 1938 e uscita nel 1939, come la sua più riuscita, quella che più gli corrispondeva nel dosaggio di elementi d’invenzione, di osservazione della realtà e di diagnosi su un presente impoverito moralmente nelle sue convenzioni sociali e nelle ricadute di queste sul comportamento degli individui, sulla loro etica ristretta a un orizzonte senza gloria. Non solo, diceva Binelli: in Una boccata d’aria echeggiano già le campane fantastico-fantascientifiche di quei due romanzi successivi: quelle della satira e del grottesco della Fattoria degli animali e quelle distopiche di 1984. Ora, confesso di dissentire da entrambe queste affermazioni. Una boccata d’aria è una bellissima, quasi irresistibile esperienza di lettura, il memorabile ritratto psicologico della miseria umana, di un esemplare in cui la miseria umana – quella dei tempi, della civiltà dei consumi, della mancanza di senso e di scopo in una società parcellizzata in unità individuali incapaci di riconoscersi in un disegno più complesso, negli altri – si incarna e si mette alla prova di un’ennesima Odissea moderna, raggrinzita al tempo di una settimana rispetto al modello classico e irriducibile alla dimensione neo-epica della dissacrazione joyciana: l’odissea di un modesto impiegato, un quarantenne piccolo-borghese già decrepito nel fisico (memorabile l’incipit del romanzo in cui il protagonista descrive le proprie abluzioni mattutine, il cui momento culminante è il posizionamento della dentiera in bocca) e soprattutto negli orizzonti ideali, che tenta la fuga dalle pastoie di una vita familiare e lavorativa infelice (perché non può esserci felicità in quelle istituzioni) attraverso il ritorno alla vagheggiata condizione edenica della propria infanzia, identificata con il paesello di campagna natio e simboleggiata da un laghetto scoperto dal protagonista nei suoi giovani anni e a lui solo noto, traboccante di carpe enormi e grasse, in attesa solo di essere pescate. Non le pescherà mai, quelle carpe, George Bowling (questo il nome del protagonista che narra la storia in prima persona), e anzi scoprirà che quello specchio d’acqua segreto non esiste più, è stato prosciugato e le sue cavità sono state adibite a deposito per i rifiuti del quartiere residenziale che ha preso il posto della campagna intorno al suo paese natale, ormai sfigurato da edifici popolari e da fabbriche fumanti, il cui principale compito è quello di produrre bombe per l’industria bellica di un conflitto che sembra ormai imminente. George si chiede se quell’epoca da lui vagheggiata sia perduta per sempre e si risponde in tono di disincanto: “Non ne sono sicuro, ma posso dirvi che era un bel mondo in cui vivere. E io gli appartengo. Anche voi”.
Romanzo felice, divertente, agro e anche attuale, per quanto il mondo che raffigura sia ormai tramontato (e lo sia da quando i cacciabombardieri che qui sono una minaccia spaventosa, ma ancora sospesa nelle ipotesi del divenire, hanno di lì a poco cominciato davvero a scaricare i loro carichi di morte sull’Europa e sul mondo): ma non ha forza trascinante, l’afflato epico e visionario, la spinta verso l’alterità che possedeva la prima prova narrativa di Orwell dopo il semiautobiografismo di Down and Out in Paris and London (1933), ovvero quell’autentico capolavoro che è Burmese Days (1934), e non ha nemmeno la visionarietà scioccante di 1984. Poco importa, comunque. Più interessante è soffermarsi sulla seconda affermazione di Binelli: e qui la questione si fa più sottile. Io, leggendo Una boccata d’aria, ho tentato di individuarne gli elementi che lo proiettassero quantomeno in una direzione fantascientifica o comunque utopico-preveggenziale, e alla fine mi sento di dire di averli trovati, anche se non ci sono. Non ci sono, in quanto il romanzo è immerso in una quotidianità disarmante, perfino avvilente, con il diario minuzioso di giornate sospese tra l’inerzia dell’impotenza di questo piccolo uomo che racconta la sua vita e il desiderio, la pulsione a sfuggire alla trappola, alle acque avvelenate in cui si trova a dibattersi: senza successo, perché le acque pulite che cerca, in realtà, non sono mai esistite e quelle che a lui apparivano tali, nella sua ingenuità di ragazzo, erano già pronte a trasformarsi nel veleno che ammorberà la sua vita adulta. Eppure, ciò che aleggia su George Bowling e sul mondo che lo circonda è l’ombra di un futuro ineluttabile, di una guerra che sta per scoppiare e cui Orwell dà la voce di un’ansia opprimente, di una catastrofe già scritta che sta per abbattersi sul mondo e non offre nemmeno l’illusione di una palingenesi, è fatta solo di distruzione. Il futuro entra così nel romanzo: un futuro nero, simile a quello di altre opere coeve, come quelle – di opposto segno – di L. Ron Hubbard, Final Blackout (1940), o di Katharine Burdekin, Swastika Night (1937), e non a caso uno dei pochi elementi letterari cui si appella George, uomo di formazione scolastica e approssimativa, è H. G. Wells:
Vi siete fatti un’idea sbagliata se pensaste che tutt’a un tratto scoprii Marcel Proust, Henry James o qualche nome del genere. Non li avrei letti nemmeno per dovere. Le letture di cui sto parlando non erano affatto ricercate. A volte accade di imbatterti in un libro che è in perfetta sintonia con lo stato mentale che hai maturato in quel frangente, a tal punto da sembrare scritto appositamente per te. Uno di questi fu Storia di Mr Polly di H. G. Wells in un’edizione da uno scellino così scalcagnata da cadere a pezzi.
Ma la molteplice gamma di futuri dischiusi dall’opera di Wells, che riecheggia anche in alcune considerazioni sul tempo e sulla sua natura inafferrabile, oggettiva e soggettiva insieme, qui si contraggono in uno solo, e nero. Un mondo in cui il nazismo è sorto ed è andato al potere non lascia scampo: questo sembra dirci Orwell con i suoi reiterati riferimenti a Hitler e alla guerra che la Germania inevitabilmente scatenerà e alla quale George guarda con una sorta di cupio dissolvi:
Se fossi Hitler, sguinzaglierei i caccia nel bel mezzo di una conferenza sul disarmo. Un mattino tranquillo, mentre i fiumi di impiegati attraversano il London Bridge, il canarino cinguetta e una vecchia attacca le culotte al filo del bucato… FIUUUU… BOOOOM! SKRRASH! Le case che saltano per aria, le culotte fradice di sangue, il canarino che cinguetta sui cadaveri.
Con simili premesse, la diagnosi del presente e l’ipotesi sul futuro passano inevitabilmente per una fenomenologia della guerra, maturata attraverso l’esperienza del primo conflitto mondiale, in cui si palesa la natura profonda di un esistente innervato nel profondo della logica di relazioni che nella guerra viene più vistosamente alla luce:
In cosa consiste questa realtà? Be’, in primo luogo consiste in un’eterna, frenetica battaglia per vendere cose. Per la maggioranza delle persone si traduce nella vendita di se stessi […]. Nella gente maturò uno stato d’animo nuovo, agghiacciante. Un po’ come trovarsi in diciannove su una nave che va a fondo e dispone di quattordici salvagente. Vi chiederete se tutto questo sia davvero caratteristico della modernità e se abbia a che fare con la guerra. Be’, sì, l’impressione era che fosse legato alla guerra. La sensazione di dover continuamente sgomitare e fare a botte, l’idea che non otterrai mai niente se non lo strappi di mano a un’altra persona, che c’è sempre qualcuno intento a soffiarti il posto, che il mese prossimo o quello dopo faranno tagli al personale e sarai tu a tirare su la pagliuzza corta; tutto ciò, ve lo giuro, non esisteva nella vecchia vita prima della guerra.
La guerra è origine e al tempo stesso conseguenza della miseria morale che l’ha portata a inverarsi, rendendola imprescindibile. E alla fine la guerra, che innerva ogni fibra di questa realtà disumanizzata, sembra scoppiare davvero, e il romanzo sembra prendere la direzione di un’ucronia:
Dopo colazione passeggiai fino alla piazza del mercato. Era una mattina deliziosa, piuttosto fresca e senza un filo di vento. […] Ma a un tratto si intromise un rombo sordo dietro le case e quindi saettò in cielo una squadriglia di enormi cacciabombardieri neri. Li guardai ed ebbi l’impressione di averli proprio sopra la testa.
Un attimo dopo sentii qualcosa e, se foste stati presenti, avreste testimoniato quasi in contemporanea un episodio interessante di ciò che credo chiamino riflesso condizionato. Perché quello che avevo udito, e non c’era possibilità di sbagliarsi, consisteva nel fischio di una bomba. […] Scattai così rapidamente che nel microsecondo durante il quale la bomba planò fischiando, ebbi persino il tempo di temere di essermi sbagliato facendo la figura del pollo per niente.
E invece, neanche un istante dopo… Ah!
BUUUMMM – BRRRR!
Dapprima un frastuono da giudizio universale e poi il clamore di una tonnellata di carbone che precipita su un foglio di lamiera. Era una pioggia di mattoni. Mi sembrò di sciogliermi sul marciapiede. “È iniziata”, pensai. “Lo sapevo. Il vecchio Hitler non ha aspettato e ci ha mandato i suoi bombardieri senza avvisare”.
In realtà, lo sappiamo, la storia è andata diversamente. Ben presto apprendiamo che la bomba è stata sganciata per errore da un aereo britannico durante un volo di prova, e tutto ritorna nell’alveo della normalità. Ma è una normalità ingannevole. Quell’esplosione ha prodotto vibrazioni nel reale attraverso le quali occhieggia e si palesa il mondo da incubo che seguirà, e al quale Orwell dà voce con passi che anticipano 1984:
La guerra! Mi scoprii di nuovo a pensarci. Sta per scoppiare, questo è sicuro. Ma chi è che ha paura della guerra? Voglio dire, chi ha paura delle bombe e delle mitragliatrici? “Tu hai paura”, direte. Sì, io sì, e come me chiunque ne abbia fatto esperienza. Ma a spaventarci non è tanto la guerra quanto il dopoguerra, il mondo in cui precipiteremo, un mondo di odio e di slogan: le camicie nere o grigie, il filo spinato, i manganelli di gomma, le celle segrete dove la luce resta accesa giorno e notte, con la polizia che ci controlla mentre dormiamo. E ancora, i cortei, i poster con sopra un faccione enorme, folle assordanti di un milione di persone che acclamano un leader fino a convincersi di adorarlo quando sotto sotto lo odiano al punto di voler vomitare. Sta per accadere tutto questo. O forse no? Alcuni giorni so che è impossibile, in altri so che è inevitabile.
Ecco allora che Binelli aveva anche ragione. Non è un romanzo di fantascienza, questo, ma il sogno, anzi l’incubo della fantascienza orwelliana già lo sta attraversando.



