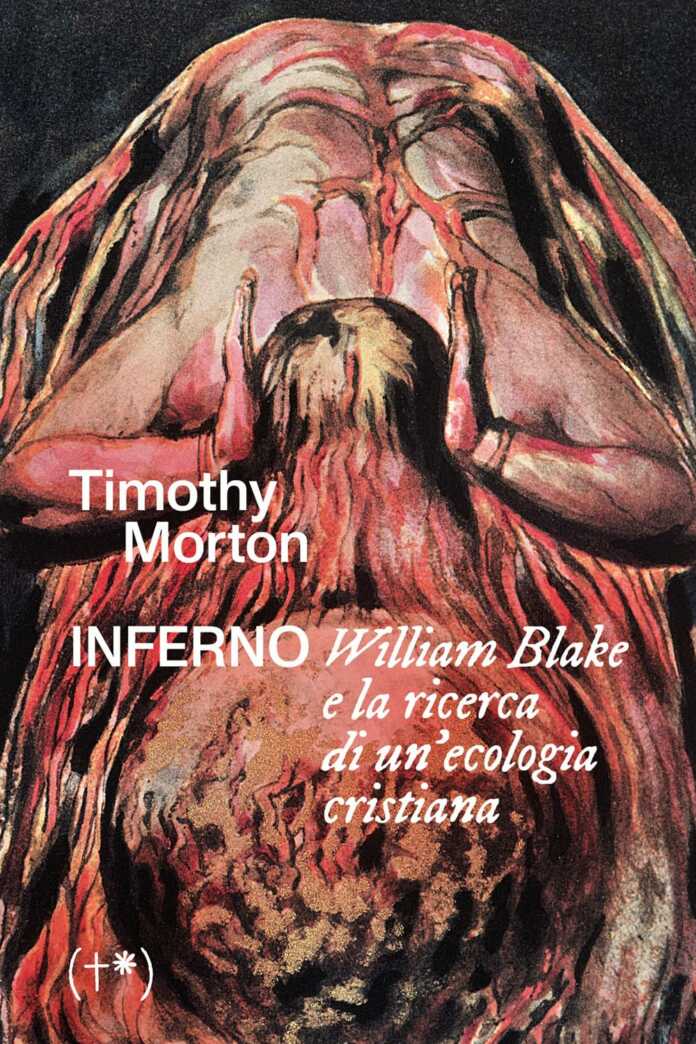Le narrazioni postmoderne sono morte, le narrazioni postmoderne sono vivissime. Forse è all’interno di questo paradosso, già intuito da qualche altro recensore anglofono, che potrebbe iscriversi con maggior certezza Hell (2024) di Timothy Morton – ora tradotto da Valerio Cianchi per Timeo – e risolvere così, almeno in modo provvisorio, il possibile dubbio di chi si approcci al libro e al suo titolo in modo un po’ naif: si tratta di un libro di critica letteraria sull’opera del poeta inglese William Blake (1757-1827), o di un libro di “ecologia cristiana”? Come si può dare una sintesi, o una compresenza, di queste due piste di ricerca, che in principio sembrano un po’ distanti?
Nella scrittura, innanzitutto; per un pensatore a-dialettico – che ogni tanto bordeggia il misticismo ma non se ne lascia, infine, rapire – la scrittura permette la compresenza di questi elementi, senza necessariamente produrne una sintesi ulteriore rispetto alle risultanze formali della scrittura stessa. Quest’ultima, del resto, risulta essere gratia plena, nel suo tentativo di fornire la traccia personale di un approccio teorico che non si lascia ingabbiare dalle astrazioni della teoria né dagli esiti più facili, e intrinsecamente soggettivisti, del memoir o del personal essay. Una prova eccellente di saggismo, dunque, che già per questo merita in pieno di essere affrontata; a invogliare la lettura non manca, tuttavia, anche un côté forse più pruriginoso, quello per cui Morton – con mossa largamente anticipatrice, nell’esordio – si prefigura i tanti e le tante cui «verrà voglia di andare su Twitter e scrivere: “Ma che cazzo, Timothy Morton è un cristiano rinato”».
In effetti, Hell è anche il racconto di una conversione, avvenuta il 28 marzo 2023, al cristianesimo – per essere più precisi, in qualità di born-again Christian, un “cristiano rinato” – declinata, comunque, secondo modi assai peculiari ed eterodossi: se si gratta la patina, comunque leggera, di moralismo, virato in chiave anti-social, della citazione appena riportata, le posizioni di Morton evitano ogni possibile deriva integralista o “religionista” – neologismo dell’autore, che non sarebbe forse dispiaciuto a un altro gnostico estremamente sui generis come Blake – risultando idealmente e politicamente molto distanti e anzi contrapposte alla destra cristiana che sosteneva George W. Bush, nonché all’alt-right come brodo di cultura del trumpismo. In questo senso, il libro, pur occupandosi di tutt’altro, offre stoccate molto argute sull’attuale panorama (anti-)woke, rivelando la «tremenda violenza proiettiva dell’attuale estrema destra» che utilizza la parola woke «in maniera derisoria verso la consapevolezza politica» – non solo in quanto woke, ma come consapevolezza politica in generale – e «a cascata finisce per deridere gli alleati bianchi delle persone nere e poi il dialetto afroamericano prima dell’abolizione della schiavitù». Meglio ancora, e nei termini sincretici adottati dalla scrittura di Morton in questo libro: «Non è difficile accorgersi di come l’attuale bullismo “antiwoke” della destra prenda la forma del Diavolo che mi stuzzica a puntare una pistola contro me stesso o contro gli altri. Shaitan è il diavolo nelle vesti di un jinn accusatorio o un pubblico ministero nel libro di Giobbe. “Woke” significa che mi ritrovo in un processo farsa shaitanista».
Se la rapida liquidazione del dibattito pro o contro le posizioni woke evidenzia nettamente la caratura ideologica di quel dibattito, la scrittura di Morton non smette mai di sottolineare il proprio posizionamento politico in uno scenario poco rassicurante, e a tutti gli effetti infernale, così descritto: «Morte del pianeta alla nostra sinistra, fascismo alla nostra destra, mentre gli umani e le altre forme di vita arrancano nella gola angusta che vi corre nel mezzo».
Un primo, fondamentale passaggio, è quello di individuare la propria relazione con il Nobodaddy di Blake: una «figura paterno-divina vuota: un padre di nessuno e un nessun padre», e proprio per questo carica di tratti autoritari e oppressivi, che il grande traduttore di Blake, Ungaretti, aveva tradotto, con un latinismo, “babbonemo” e che Cianchi decide invece di tradurre, con altrettanto sofisticata e riuscitissima scelta, “Padreserto”.
Ripensare il sacro, e insieme l’ecologia, come suggerisce nel suo complesso il libro di Morton, è un’opzione effettivamente praticabile solo dopo aver fatto i conti – anche dal punto di vista psicanalitico, come dichiara Morton: «Freud è uno dei buoni in questo libro – non Freud di per sé, ma la psicanalisi, dalla quale ho tratto enormi benefici» – con il cinismo del “Padreserto”. A quel punto, suggerisce Morton, sarà molto più facile identificare il sacro come «sentore della biologia, la sua fenomenologia» e cioè più come senzienza senza “oggetto” né “soggetto” (o anche, senza “servo” né “padrone”) che non come esperienza soggettiva: qualcosa dove «tutto ride», come nella Laughing Song (“Canzone ridente”, 1789) di Blake, oppure esulta in Cristo, come nella biosfera di Morton.
Passaggio particolarmente delicato, quest’ultimo – «La biosfera è il corpo di Cristo», recita una delle più icastiche affermazioni del libro –, se letto nell’insieme dell’opera di Morton, rispetto alla quale Hell sembra essere continuazione e insieme deviazione consistente. La biosfera continua ad essere un iperoggetto, secondo la teorizzazione forse più nota di Morton, in quegli Iperoggetti (NERO, 2018) pubblicati, tra l’altro, da quello stesso comitato di lettura che oggi propone Inferno; la biosfera, tuttavia, è un iperoggetto peculiare, retto da quella forma biosociale di solidarietà che l’endosimbiosi teorizzata da Lynn Margulis e abbracciata anche da Morton in Humankind (NERO, 2022) e con i toni forse “animisti”, più che cristiani, di Ecologia oscura (Luiss University Press, 2021). Ne cosegue che l’endosimbiosi costituisce forse una declinazione forse troppo laica e orizzontale per questo nuovo approccio di Morton, che pure, per altri versi, continua a celebrare, come in Humankind, la «subscedenza» in luogo e in opposizione alla tradizionale «trascendenza», come caratteristica precipua di quell’altro iperoggetto eterodosso che è la specie umana.
Deviare, almeno parzialmente, da quanto già proposto non è in fondo un problema per un pensatore rizomatico e anti-teleologico come Morton – «La bellezza elimina ogni traccia delle frecce teleologiche», scrive l’autore, in un altro dei tanti apoftegmi del libro – ma rischia di corroborare l’obiezione avanzata da Livio Santoro per gli altri volumi di Morton, in un’esaustiva rassegna pubblica nel 2022: «Tuttavia, […] poco o nulla Morton ci dice su come debba avvenire questa necessaria riorganizzazione dei piaceri, né suggerisce in tal senso concreti indirizzi d’intervento politico-sociale. Il suo resta un approccio all’apparenza ancorato solo al pensiero, cosa che giustamente invita i critici a dubitarne. Ma, nonostante ciò, il suo valore per la pratica resta, o almeno si spera, per quanto in modi che vanno ancora individuati».
L’individuazione dei modi e delle pratiche può, a tutti gli effetti, avvenire in un secondo momento, dopo essere intervenuti sull’immaginario, che ha una preminenza, come si diceva, tutta postmoderna nella riflessione più squisitamente politica di Morton. Occorre, innanzitutto, unirsi al trip vissuto dall’autore e poi rielaborato e riproposto nella sua scrittura; un trip che è debitore della cultura techno e acid, dalla fine degli anni Ottanta a oggi – un altro inequivocabile punto di riferimento del libro, oltre a Blake – perché, se da un lato è vero che da quello spartiacque storico in poi campeggia lo slogan thatcheriano TINA (There Is No Alternative), come sapeva bene Mark Fisher, c’era anche un graffito molto evidente nella Central Line della metropolitana di Londra, a Tottenahm Court Road, che appunto recitava: JOIN THE TRIP.