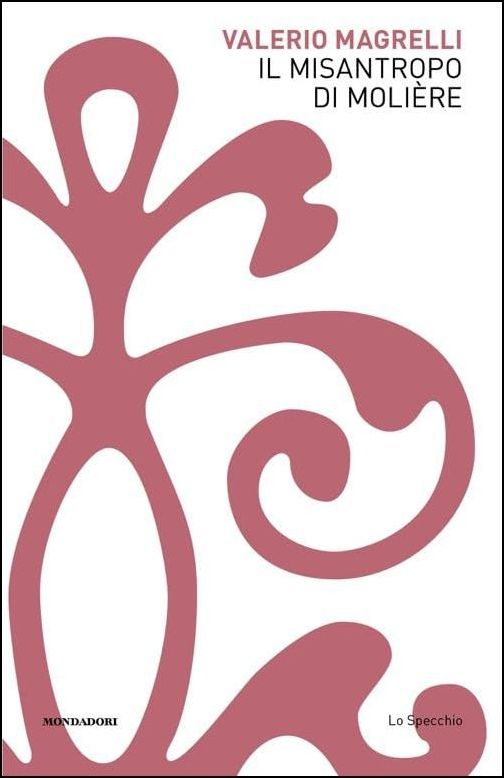Valerio Magrelli traduce Le Misanthrope di Molière seguendo un sentimento dominante e rivelatore verso la lingua francese tanto che il risultato si evidenzia come una solenne prefazione alle pagine seguenti l’opera, intitolate Apologia della rima: dodici pagine che valgono quanto una lectio magistralis diretta a coloro che si devono augurare grandi eredità dalle lingue madri e da quelle ereditate. Uno stile seducente – qualcosa di ben conosciuto da chi ha letto il Magrelli prosatore – oltre che cosparso di finezze filologiche. Nel viaggio dentro la poesia, certo, la cui pratica non prescinde dall’uso della metrica, verso libero permettendo.
Magrelli vola sui secoli europei associati alla metrica per posizionarsi nel periodo precedente la fine dell’Ottocento, quando al di qua e al di là dell’Oceano Atlantico spuntò in vita il verso libero. E cita Pessoa quando nel 1930 in poche frasi appellò come “drogata” la prosa quand’era “ingozzata letteralmente di musica” dalla metrica rimata per trasformarla in poesia. Alcuni nel XIX secolo sistemavano le cose traducendo in prosa i versi in modo che le gabbie metriche si attenuassero non poco: Magrelli dice la sua, precisa che ancora oggi tale metodo è ancora in auge nonostante certi usi “giocosi” allestiti (soprattutto nel Novecento), per esempio, dall’Oulipo, con l’obiettivo di crearsi dei vincoli. Dentro questo punto di vista Magrelli sosta alla svelta nello spazio dove i traduttori Franco Parenti, Vittorio Sermonti e Renato Benvenuto offrirono del Misantropo di Molière versioni in metro e rima italiani. Lavori d’esiti diversi, a cui l’attuale edizione si accosta. In ogni caso l’avvertimento che viene fuori da queste dodici pagine è chiaro: “tradurre è passare fra Scilla e Cariddi”. Una vera sfida strutturale.
Da qui la ben nota domanda: perché tradurre? I giovani, di fronte a certe esibizioni filmiche (più raramente, teatrali) si chiedono “come parlavano questi?” anche se poco dopo, complice la moda del rap, Magrelli confessa che nel 2005 il figlio sedicenne gli chiese in prestito un rimario. Ah la forza della rima! Fra esempi critici e esempi di traduzioni preoccupate dell’equivalenza dinamica o del senso, si arriva – fra scomodità varie e duelli all’ultimo sangue – a quei testi in cui l’azzeramento della rima equivarrebbe a un omicidio (il caso di filastrocche e limericks). Magrelli appena può mette in campo esempi luminosi di vivacità citando Camillo Sbarbaro che vede la vitalità della rima sottendere un evidente stimolo erotico. Un miracolo acustico che “ha fatto versare fiumi di inchiostro”.
E dunque, ecco che la tenzone giunge al termine venendo a capo di questa traduzione del Misantropo, dove la rima accetta la sfida della brutalità, per così dire, perché non si può togliere (Magrelli ne è convinto) l’energia della rima a una pièce di Molière senza renderla inservibile (altro che versione servile!). Con la più severa e lucida delle intenzioni: accettare le soluzioni altrui quando sono migliori della nostra. Come “in alpinismo è consentito usare chiodi piantati da coloro che hanno affrontato la stessa via prima di noi”, vanno accolti i pregi dei migliori precursori. Alceste, il protagonista, ringrazia.