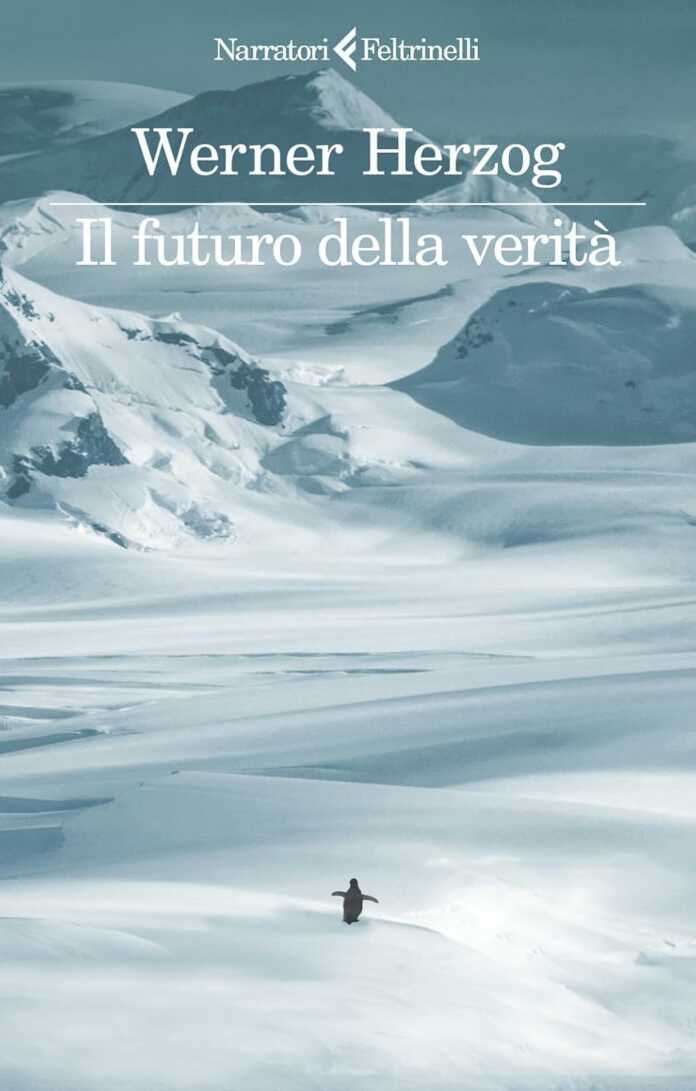Inetichettabili, come sempre, i libri di Werner Herzog sfuggono alle categorie sia della narrativa che della saggistica. Oggetti artistici totali, diari dell’interiorità: si mostrano in qualche modo corrispettivi e paralleli ai suoi film, in cui fiction e documentario sfumano e si compenetrano, si scambiano di ruolo, si annullano e si esaltano a vicenda, per distillare alla fine un’essenza: puro cinema, in quel caso. Il libro appena tradotto da Feltrinelli non fa eccezione: in uno stile sintetico, quasi scarno, l’autore bavarese traccia una serie di considerazioni, di riflessioni, alcune geniali, altre banali, intorno a un tema, la verità. Un tema filosofico per eccellenza, ma Herzog, fin dalle prime pagine, smentisce di avere ambizioni o velleità filosofiche. Il suo approccio è esperienziale: l’argomento è affrontato per il tramite dei suoi film, dei suoi incontri sul piano fisico o puramente intellettuale, attraverso il delinearsi di una realtà poetica e non empirica che vada oltre il semplice dato di fatto.
In un mondo in cui i social media sono dominati dalle fake news, in cui l’intelligenza artificiale può ormai riprodurre e alterare quei dati concettuali che chiamiamo realtà, i fatti non sono più la verità. Non è certo un fenomeno nuovo, ricorda Herzog, la storia è fatta di manipolazioni, di inganni: dalla battaglia di Qadesh nel 1274 a.C. in cui i contendenti, Egizi e Ittiti, si attribuirono entrambi la vittoria, alla natura effettiva dei regni di Numa Pompilio o di Nerone, dalla donazione di Costantino che costruì su una frode il potere secolare della Chiesa, fino ai falsi diari di Hitler e addirittura ai rapimenti da parte degli alieni e ai culti extraterrestri come quello della setta dei Raeliani, la verità si è rivelata elastica e porosa. Non i fatti ma i sentimenti la determinano: Herzog prende esempio dalla sua lunga carriera di direttore di opere liriche, nelle quali le storie più improbabili e talvolta quasi ridicole, diventano vere per lo spettatore solo grazie al potere della musica che evocando sentimenti veritieri riesce a renderle reali. Così in uno dei suoi film più recenti, Family Romance, si racconta dell’omonima società giapponese che affitta “amici” o “parenti” falsi per ricorrenze sociali come matrimoni o funerali o semplicemente come compagnia occasionale per anziani soli: interpretato interamente da attori che lavorano in questa società, costruito su scene e situazioni impostate da Herzog ma con dialoghi interamente improvvisati sul momento, il film fu creduto erroneamente un documentario, mentre quando l’emittente nazionale giapponese realizzò davvero un documentario su Family Romance, un anziano cliente intervistato come testimone diretto dell’esperienza, fu impersonato all’insaputa di tutti da un attore, e l’impostore si rivelò più credibile di qualsiasi anziano vero: nessuno si era accorto dell’inganno.
Ma Herzog non ci sta dicendo che la verità è relativa o che non esiste. Tutt’altro. Ci parla invece di una super verità, una verità che va oltre la presunta o pretesa verità empirica, quella che lui chiama “verità estatica”: la verità dei mistici e dei veggenti. Il tipo di verità che ha sempre cercato nel suo cinema e che sta all’origina della polemica che da anni (la Dichiarazione del Minnesota è del 1999) ha condotto contro i documentaristi del cosiddetto cinéma vérité – contabili, così li definisce – incapaci di comprendere che solo attraverso la stilizzazione, l’invenzione, la poesia e l’immaginazione è possibile esplorare una verità più profonda che vada oltre la semplice trasmissione di informazioni per accendere invece una scintilla interiore. Ne fornisce numerosi esempi nel suo cinema, eventi, ricordi, aneddoti, attribuiti ai suoi protagonisti reali, come Dieter Dengler, ma mai accaduti se non come sogni o metafore, intere citazioni emblematiche attribuite a Pascal, Tommaso da Kempis o Von Clausewitz e in realtà scritte appositamente da Herzog stesso: l’unico suo documentario in cui non c’è alcuna finzione, confessa, è l’intervista che fece a Gorbaciov nel 2018, ma come l’amico Bruce Chatwin, accusato di aver inventato troppi episodi di In Patagonia, anche lui può dichiarare in coscienza di non aver mai detto “mezze verità, ma una verità e mezzo”.