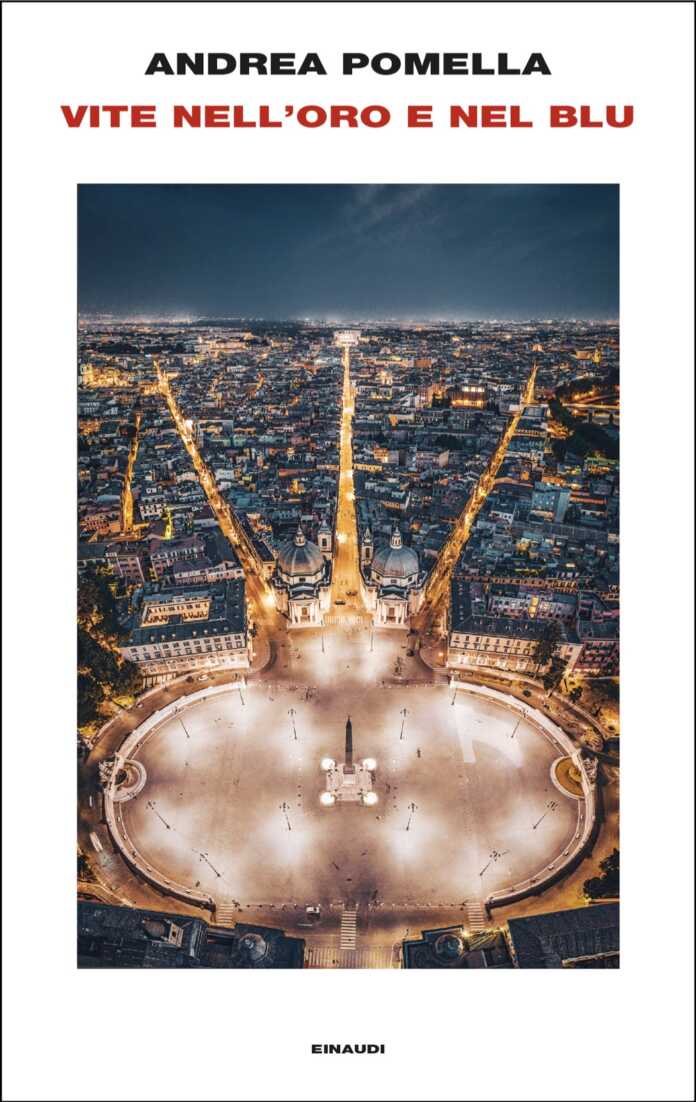Se esistono scritture fatte per restituire l’esperienza umana in tutte le sue forme, quella di Andrea Pomella è una di queste. Già in Anni luce (Add Editore), L’uomo che trema e I colpevoli (Einaudi) ci aveva abituato a un tipo di narrativa ibrida, in cui il rapporto tra fiction e non-fiction si fa complesso e dai contorni incerti; nelle uscite recenti ha rivendicato un vero e proprio spazio per l’invenzione, nel racconto di figure storico-politiche come Aldo Moro ne Il dio disarmato e di personalità artistico-culturali ne Vite nell’oro e nel blu, definito un romanzo biografico.
In quest’ultimo caso, l’autore non si rende protagonista o punto di vista, eppure la sua presenza vibra tra le righe nella sapiente capacità di intrecciare eventi, figure, emozioni. Pomella sceglie una diegesi composta da luoghi e date disposti in un ordine non cronologico e la porta avanti senza una sbavatura, con ritmo ed equilibrio. Non si ha mai la sensazione di perdere il filo, mentre vengono intessuti i caratteri travolgenti di Mario Schifano, Franco Angeli e i fratelli Tano Festa e Francesco Lo Savio.
«Per anni li hanno citati insieme, come una cantilena. Erano quelli di Rosati, i pittori popolari, nella duplice accezione: famosi e al contempo figli del popolo». Vengono considerati un movimento, sebbene non siano mai stati un gruppo coeso nelle intenzioni e nei mezzi al pari delle avanguardie; la pittura ha impregnato e guidato la loro vita, pur essendosi dedicati anche a cinema e poesia. Sono stati ironicamente chiamati maestri del dolore, ad averli davvero legati però è un’amicizia intrisa di rispetto e lealtà quanto di gelosia e profondo risentimento – d’altronde, sono molto diversi l’uno dall’altro: Schifano è l’istinto, Angeli la lotta, Festa la contemplazione e Lo Savio il pensiero. Hanno conosciuto una fase ascendente, l’ora d’oro, e una successiva discesa, l’ora blu.
C’è un senso di rottura a percorrere dal principio alla fine la loro avventura. Una forza, all’inizio, nella fame di rivalsa dalle origini umili e nel desiderio di varcare la soglia della modernità; via via è sempre più radicata nel loro stesso stare al mondo, sintomo di una contraddizione insita dentro ognuno di loro. Schifano è il più celebre, il più carismatico, non trova il modo di conciliare lo sprezzo per ricchezza e borghesia con la fascinazione per fama e consumismo, la volontà di proseguire per la sua strada a dispetto di tutto e tutti con il bisogno di essere amato. Angeli è divorato da rabbia e inadeguatezza per essere nato e cresciuto nella povertà, condizionano la sua relazione d’amore e odio sia con le sue creazioni sia con Marina Lante della Rovere. Festa matura la consapevolezza di un’infelicità generale, all’interno e all’esterno di sé, mentre Lo Savio – figlio illegittimo quanto Festa – non riesce a sentirsi al posto giusto neanche in quella Roma dove gli altri, presto o tardi, finiscono per tornare.
Rottura è il suicidio di Lo Savio nel 1963, segna un prima e un dopo per il fratello e i compagni. Rottura è come Schifano, Angeli e Festa tentino di gestire un’ansia asfissiante, la necessità di annullare il tempo dipingendo, viaggiando, drogandosi, amando smodatamente. «Bruciare. Per un grande artista non può esserci altro che questo», pensa Schifano. «Chi appicca un fuoco sa che le fiamme si dimeneranno seguendo una loro volontà. Ma l’artista, a differenza del piromane, mette in conto che lui stesso potrebbe finire arso». Rottura, ancora, è il graduale allontanamento tra loro, per non dover guardare dentro la propria oscurità. Dal periodo della Seconda Guerra Mondiale in poi, passando per i trionfi degli anni Sessanta; intorno ai quattro, Guttuso, Pasolini, Penna, Ungaretti, la Beat Generation e i Rolling Stones. Sullo sfondo, più protagonista che mai, Roma: quella del Tridente e del bar Rosati, quella degli ultimi nobili e dello sfarzo, quella dei quartieri popolari e dei bombardamenti. Roma nella frattura tra antico e nuovo.