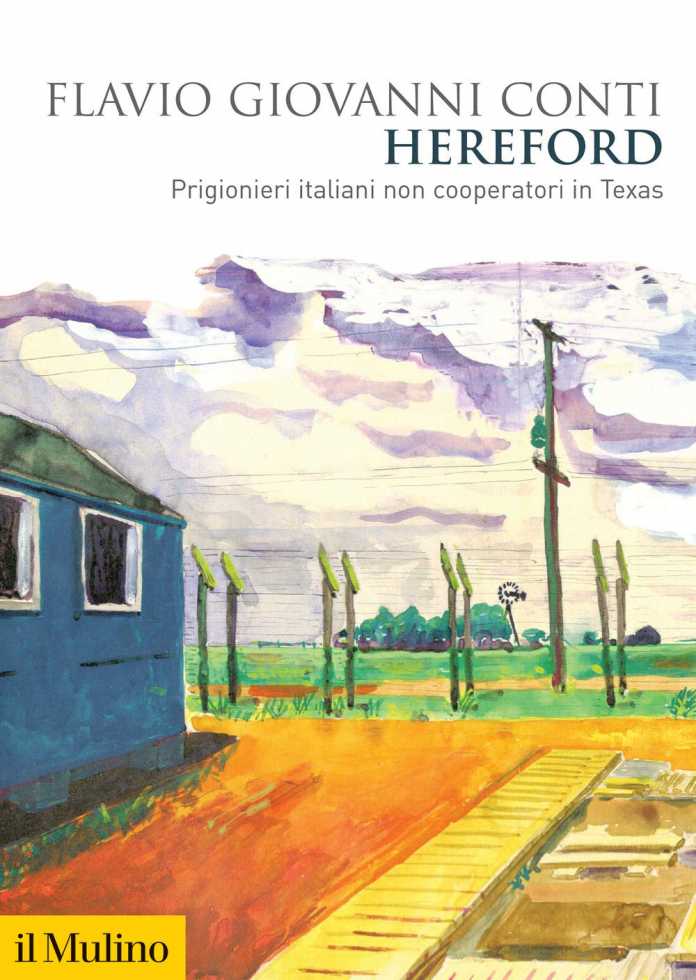Oggi Hereford, Texas, è solo una minuscola cittadina del profondo sud americano, popolata da circa quindicimila persone e da uno dei più grossi allevamenti di mucche degli USA, ma alla fine della Seconda guerra mondiale, tra il 1943 e il 1946, fu il principale centro di raccolta e di internamento di tutti quei prigionieri italiani che dopo l’otto settembre si erano rifiutati di sottoscrivere il documento, passato in tutti i campi di detenzione in Africa, India, Inghilterra e negli Stati Uniti, in cui si dichiarava la piena collaborazione a favore degli alleati “contro il nemico comune, la Germania”, promettendo di non abusare della fede e della fiducia accordata e di ubbidire a tutti gli ordini impartiti. La maggior parte dei soldati, e un alto numero di ufficiali, avevano firmato; i cosiddetti “non-cooperatori” invece, sotto stretta sorveglianza e con drastica riduzione di ogni privilegio, erano finiti nel “Fascists’ Criminal Camp” di Hereford.
Il libro di Flavio Giovanni Conti, già autore di numerosi studi storiografici sui prigionieri italiani del Secondo conflitto mondiale – tutti, come questo, pubblicati da Il Mulino – analizza in profondità i dettagli di uno scenario apparentemente trascurato e minore del nostro recente passato, sulla base di una fitta e densa documentazione di fonte memorialistica. Infatti un gran numero di ex internati a Hereford farà parlare di sé in vari campi della cultura negli anni seguenti: primo fra tutti lo scrittore Giuseppe Berto (1914-1978) che proprio nel campo terminerà la prima stesura del suo romanzo d’esordio, e forse il suo più bello, Il cielo è rosso; poi l’artista figurativo Alberto Burri (1915-1995); lo scrittore e magistrato Dante Troisi (1920-1989); il giornalista e scrittore Gaetano Tumiati (1918-2012), che offrirà nel 1985 una delle più brillanti rievocazioni della propria esperienza concentrazionaria nel suo romanzo autobiografico Prigionieri in Texas; il giornalista e militante comunista Giosuè Ravaglioli; il giornalista sportivo Armando Boscolo, anche lui fin dal 1954 autore di un’efficace memoria del campo, Fame in America; l’architetto e pittore Giovanni Rizzoni; il pittore alfiere del Secondo Futurismo Dino Gambetti (1907-1988), che diresse la realizzazione da parte dei prigionieri dell’apparato decorativo della chiesa di St. Mary di Umbarger, ancora visitabile nei pressi del campo stesso e oggi monumento nazionale; il pittore e incisore Ervardo Fioravanti (1912-1996); e molti altri, uomini politici (di cui tanti nelle file del MSI, ma curiosamente, altrettanti nell’estrema sinistra), accademici, docenti, militari, imprenditori, professionisti, buona parte dei quali autori a loro volta di una qualche propria personale rievocazione scritta o disegnata della vita nel campo.
Attingendo a queste fonti autobiografiche e alla copiosa documentazione burocratica sia statunitense che delle organizzazioni assistenziali vaticane, Conti è in grado di tracciare, corredando il testo di un nutrito apparato di testimonianze fotografiche e figurative, un preciso spaccato delle relazioni effettive fra detentori e detenuti. La prima cosa che salta agli occhi è la semplicistica e talvolta strumentale equiparazione tra “non-collaboratori” e fascisti – spesso incoraggiata proprio dal reducismo politicamente più orientato. Lo stesso termine “Fascists’ Criminal Camp”, mai usato dagli americani, è stato sottolineato soprattutto da Roberto Mieville nel suo omonimo memoriale del 1948, apertamente e “orgogliosamente” fascista. In realtà gran parte dei prigionieri, come Berto, Burri, Manzoni, ecc., era stato catturato in Nord Africa prima dell’otto settembre e i militi della RSI sarebbero arrivati, in numero assai più esiguo, molto più tardi. I motivi della non cooperazione erano dunque assai variegati e non necessariamente dettati da un’adesione ideologica consapevole al regime fascista quanto piuttosto da motivazioni morali o di coerenza rispetto a un ideale patriottico più generico: la fedeltà alla memoria dei commilitoni uccisi in battaglia al loro fianco fino a pochi mesi prima; la ripulsa a contribuire alla costruzione di quelle bombe che sarebbero state sganciate sulle loro città e forse sulle loro stesse case; il fatto che il governo monarchico di Badoglio non avesse dato alcun ordine esplicito riguardo alla collaborazione, nonostante la cobelligeranza, creando come sempre incertezza e confusione; c’era fra loro perfino il gruppo di comunisti e collettivisti di Giosuè Ravaglioli, Fioravanti e Troisi, che non collaborava con gli Alleati in odio al capitalismo. Si trattava quindi sostanzialmente di una decisione non di ordine strettamente politico ma indotta piuttosto da motivi di coerenza, dignità e rispetto formale delle norme militari. Secondo alcune testimonianze, su un numero complessivo medio di circa 3000 prigionieri, di cui meno di un migliaio ufficiali, solo poche centinaia si dichiararono apertamente fascisti e ancor meno aderirono ufficialmente alla RSI.
 Altra questione interessante, sollevata dal libro di Conti, è quella del trattamento dei prigionieri da parte dell’amministrazione americana. Quasi unanimemente il giudizio degli internati su tutti gli aspetti del campo, dai dormitori ai servizi, dall’assistenza sanitaria al vitto, fu molto positivo, almeno fino alla primavera del 1945 quando le condizioni sarebbero bruscamente e drasticamente peggiorate. Rispetto alla miseria e alla fame lasciate in Italia, alle magre razioni del Regio Esercito, il trattamento, pur nelle condizioni di prigionia, era quello di “un centro di soggiorno vacanziero, non un campo di concentramento. Letti con rete, materasso, coperte e trapunta […] docce, lavabi, specchi, portasaponi, spazzolini, water closet, appendiasciugamani, acqua calda e fredda” (Tavella, Io prigioniero). Il cibo comprendeva pancarré, latte, Coca-Cola, marmellate, frittate, corn flakes, hot dog, ecc., e allo spaccio erano acquistabili frutti tropicali della California, gelati, angurie, birra, articoli da toelette. C’era una baracca attrezzata per le attività sportive, un auditorium con radio funzionante, proiezione periodica di film e attività teatrali e concertistiche realizzate dai prigionieri, una piccola biblioteca con testi in inglese e in italiano. Alla fine della guerra però, dopo la scoperta da parte alleata dei campi di concentramento nazisti di Buchenwald e Mauthausen, la forte pressione dell’opinione pubblica scandalizzata sulle autorità, data anche la fine del rischio di ritorsioni contro i propri prigionieri in Europa, portò a un punitivo taglio delle razioni alimentari per gli internati ritenuti fascisti, scendendo ben al di sotto delle 2500 calorie giornaliere prescritte dalla Croce Rossa internazionale: gli spacci si svuotarono di ogni merce e il pasto principale si ridusse a un’aringa affumicata e due fette di pane da dividere in otto, costringendo i prigionieri attanagliati dalla fame, a cacciare topi, gatti e serpenti a sonagli, a friggere grilli e cavallette nella brillantina per capelli (data la mancanza totale di olio o burro), o nutrirsi di bucce di patate e di polpette di lische di pesce. Durante le brevi trasferte lavorative dei soldati (questa fortuna non toccava però agli ufficiali esentati dal lavoro), le guardie, per buon cuore, sparavano alle lepri nei campi lasciando che i prigionieri le raccogliessero. Le condizioni tornarono a migliorare in prossimità del gennaio 1946, data in cui i rimpatri vennero ultimati.
Altra questione interessante, sollevata dal libro di Conti, è quella del trattamento dei prigionieri da parte dell’amministrazione americana. Quasi unanimemente il giudizio degli internati su tutti gli aspetti del campo, dai dormitori ai servizi, dall’assistenza sanitaria al vitto, fu molto positivo, almeno fino alla primavera del 1945 quando le condizioni sarebbero bruscamente e drasticamente peggiorate. Rispetto alla miseria e alla fame lasciate in Italia, alle magre razioni del Regio Esercito, il trattamento, pur nelle condizioni di prigionia, era quello di “un centro di soggiorno vacanziero, non un campo di concentramento. Letti con rete, materasso, coperte e trapunta […] docce, lavabi, specchi, portasaponi, spazzolini, water closet, appendiasciugamani, acqua calda e fredda” (Tavella, Io prigioniero). Il cibo comprendeva pancarré, latte, Coca-Cola, marmellate, frittate, corn flakes, hot dog, ecc., e allo spaccio erano acquistabili frutti tropicali della California, gelati, angurie, birra, articoli da toelette. C’era una baracca attrezzata per le attività sportive, un auditorium con radio funzionante, proiezione periodica di film e attività teatrali e concertistiche realizzate dai prigionieri, una piccola biblioteca con testi in inglese e in italiano. Alla fine della guerra però, dopo la scoperta da parte alleata dei campi di concentramento nazisti di Buchenwald e Mauthausen, la forte pressione dell’opinione pubblica scandalizzata sulle autorità, data anche la fine del rischio di ritorsioni contro i propri prigionieri in Europa, portò a un punitivo taglio delle razioni alimentari per gli internati ritenuti fascisti, scendendo ben al di sotto delle 2500 calorie giornaliere prescritte dalla Croce Rossa internazionale: gli spacci si svuotarono di ogni merce e il pasto principale si ridusse a un’aringa affumicata e due fette di pane da dividere in otto, costringendo i prigionieri attanagliati dalla fame, a cacciare topi, gatti e serpenti a sonagli, a friggere grilli e cavallette nella brillantina per capelli (data la mancanza totale di olio o burro), o nutrirsi di bucce di patate e di polpette di lische di pesce. Durante le brevi trasferte lavorative dei soldati (questa fortuna non toccava però agli ufficiali esentati dal lavoro), le guardie, per buon cuore, sparavano alle lepri nei campi lasciando che i prigionieri le raccogliessero. Le condizioni tornarono a migliorare in prossimità del gennaio 1946, data in cui i rimpatri vennero ultimati.
I rapporti fra americani e prigionieri italiani furono segnati da numerose diffidenze e incomprensioni, non dissimili dagli scontri, anche violenti avvenuti fra prigionieri di contrarie opinioni politiche. Il momento peggiore si raggiunse la notte del 20 aprile 1944, quando in seguito all’incendio di una baracca del campo – appiccato forse da alcuni ufficiali prigionieri, forse premeditatamente dalle guardie per giustificare una repressione – duecento militari americani armati di sfollagente e mazze da baseball e guidati da un tenente italoamericano particolarmente invelenito, fecero irruzione negli alloggiamenti colpendo indiscriminatamente i prigionieri, procurando loro lesioni di varia entità e sparando anche un colpo di pistola per fortuna non andato a segno. In altri casi invece le relazioni furono amichevoli e civili come l’organizzazione di una mostra di arte figurativa nell’agosto del 1945, con esposizione di 219 opere di pittura, scultura e artigianato realizzate dai prigionieri (fra le tante esposte, l’originale scacchiera Scacchi d’Africa di Burri), che trovò eco anche sulla stampa locale, o gli spettacoli musicali e teatrali aperti anche ai comuni cittadini di Hereford. Fra i momenti più positivi vi fu certamente la realizzazione – durata 41 giorni, domeniche escluse – degli affreschi e degli ornamenti di St. Mary’s Church a Umbarger, proposta dal cappellano militare del campo e dal pastore della chiesa e accettata da una quindicina di prigionieri artisti a patto che il lavoro fosse gratuito e venisse considerato un’“attività personale per amore della fratellanza cristiana e della reciproca comprensione” e non un atto di collaborazione.

Conti sottolinea come parlare di prigionia dei militari italiani durante la Seconda guerra mondiale significhi parlare di prigionie molto diverse, con varie gradazioni di trattamento anche fra gli alleati occidentali: molto duro – il peggiore di tutti – quello francese; rigido, pur nel rispetto delle norme internazionali, quello inglese; migliore di tutti, pur in maniera non uniforme né esente da critiche, quello americano. Sostanzialmente gli americani non capivano come mai i prigionieri italiani non-cooperatori (diverso fu il trattamento degli altri) non apprezzassero il loro impegno e non volessero collaborare con i paesi democratici: questo portò ad una coercizione severa per riorientare politicamente i prigionieri e convincerli con tutti i mezzi a cooperare. L’inasprimento di queste tendenze fu considerato anche da molte autorità americane non consono alle norme internazionali e alla tradizione liberale degli USA.
Conclude Conti: “Hereford è stato per molti aspetti un singolare elemento catalizzatore. Da un lato, ha fatto emergere in modo eclatante le ambiguità della posizione dell’Italia rispetto agli Alleati dopo l’otto settembre e la conseguente confusione dei militari prigionieri negli Stati Uniti, privi di indicazioni ufficiali sulla propria effettiva condizione e sul comportamento da tenere nei confronti della potenza detentrice. Dall’altro, ha messo in luce le contraddizioni dell’atteggiamento adottato dalle autorità militari e politiche statunitensi, che non vollero modificare lo status giuridico dei prigionieri, dopo l’avvio della cobelligeranza. Hereford si è rivelato, inoltre, un significativo esempio della realtà complessa, piena di sfumature, che contraddistinse in quegli anni la vita non solo dei prigionieri, ma di tutti gli italiani, travolti dagli eventi bellici e dilaniati dalle divisioni politiche e ideologiche”.