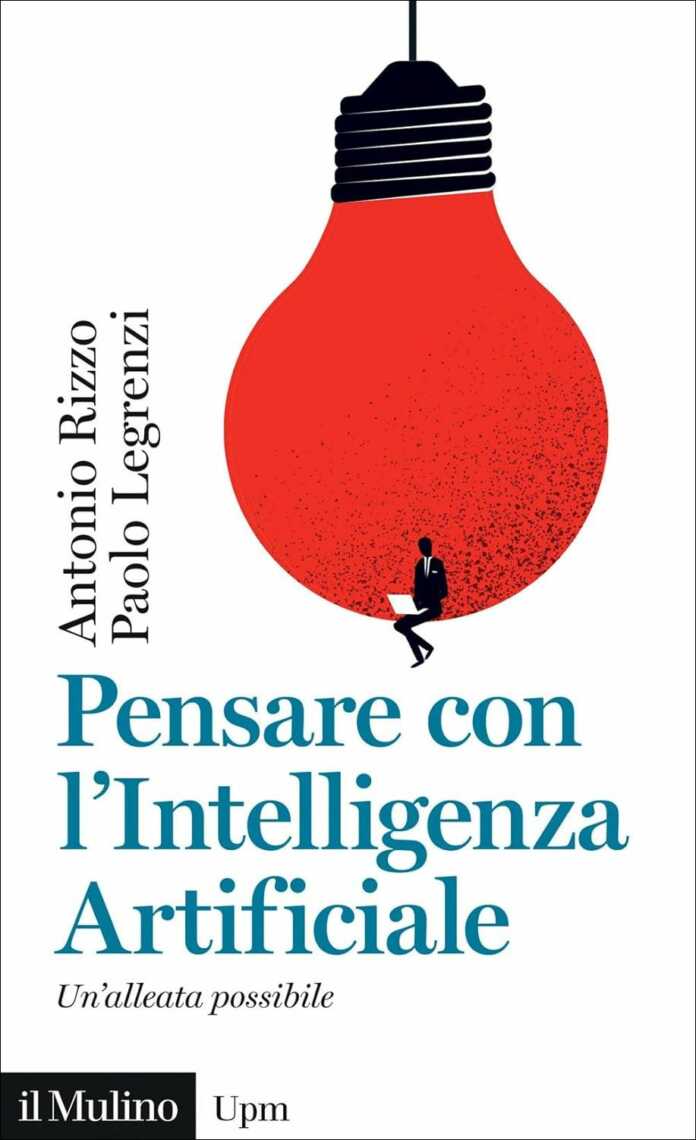La cosiddetta Intelligenza Artificiale è tra gli argomenti più dibattuti nella riflessione pubblica del nostro tempo. Libri, giornali e riviste, social e la Rete, chiacchiere da bar: l’infosfera in cui siamo immersi brulica di discussioni sul tema, dividendo chi vi si dedica, come sempre accade, in due gruppi: gli apocalittici e gli integrati. In questo mare fluttuante, un volume apparso di recente prova a mettere dei punti fermi, a trarre delle conclusioni, per quanto sempre in divenire: Pensare con l’Intelligenza Artificiale. Un’alleata possibile, edito da il Mulino ed opera di due rinomati studiosi di psicologia e scienze cognitive, Antonio Rizzo e Paolo Legrenzi.
Aperto da una corposa introduzione, il saggio si compone di due parti: nella prima, “Una storia dell’Intelligenza Artificiale”, si dà contezza delle origini e degli sviluppi dei concetti matematici e cibernetici poi concretizzati negli strumenti informatici e tecnologici odierni. Sono pagine affascinanti, che ripercorrono un’avventura intellettuale e scientifica tra le più alte dell’ingegno umano, con i loro pionieri, da Alan Turing a Warren McCulloch e Walter Pitts, da John von Neumann a Frank Rosenblatt, da Funihiko Fukushima a Yann LeCun, e parecchi altri. Vi si narra, tra l’altro, delle conoscenze sul sistema nervoso biologico, delle reti neurali, di computer vision e dei Large Language Models. La seconda parte si sofferma sulle possibili applicazioni della “Intelligenza aumentata”, cioè della sinergia tra intelligenza umana e artificiale, in particolare in tre settori: la didattica, la medicina, l’industria. È il cuore dello studio, che mette sul piatto le straordinarie possibilità di ampliamenti cognitivi resi possibili da questa interazione. Non mancano grafici esplicativi – giovevoli, poiché alcuni concetti possono risultare di non semplice comprensione –, “spunti di approfondimento” per chi volesse ampliare le conoscenze sull’argomento, un utile glossario e una puntuale bibliografia.
Il libro è rivolto a un pubblico ampio e, per quanto possibile, prova a rendere accessibili temi complessi evitando eccessivi tecnicismi. Il suo scopo è proporre una riflessione sul rapporto tra intelligenza umana e artificiale, partendo da un assunto euristico ripetutamente sottolineato nel corso dell’esposizione: più che stabilire se l’IA possa superare l’uomo nella facoltà del pensiero, bisogna esplorare i vantaggi che l’umanità può trarre da questa tecnologia, integrandola nei processi cognitivi e dialogici che caratterizzano la specie umana.
Le linee su cui si sviluppa il discorso sono il ruolo del linguaggio e il dialogo come metodo conoscitivo, due strumenti fondamentali per la trasmissione e la creazione del sapere; gli autori evidenziano come l’umanità abbia il destro di estendere le proprie capacità cognitive attraverso l’interazione con l’IA, intessendo con essa un vero e proprio dialogo: una “collaborazione tra mente umana e sistemi artificiali che diventa uno strumento di esplorazione” del reale – un passo enorme per la storia evolutiva della nostra specie. Non si tratta, ripetono a piè sospinto, di sostituire l’intelligenza umana, ma di arricchirla con la cosiddetta Intelligenza Artificiale generativa, considerandola un “alleato cognitivo”, sfruttandone la natura dialogica per appunto generare nuova conoscenza e affrontare le sfide complesse che ci attendono. Siamo dunque nell’ambito del dibattito sulla possibilità di una sinergia tra uomo e macchina, un approccio che valorizza la dimensione relazionale e collaborativa, piuttosto che competitiva. Ad ogni modo, Rizzo e Legrenzi non forniscono risposte definitive – se pur ve ne fossero; il loro è piuttosto un invito a interrogarsi sul potenziale trasformativo dell’IA, sulla sua capacità di influenzare il nostro modo di conoscere, apprendere e pensare, e più che soffermarsi sulle sfide ingegneristiche e tecnologiche, privilegiano una prospettiva filosofica, psicologica e cognitiva.
Al netto di tutto quello che si può apprendere sull’argomento (e non è certo poco), in questo lavoro dal deciso sapore positivistico, impregnato di una visione ottimistica sull’alleanza uomo-macchina, si segnala l’assenza di un tema centrale nel dibattito in corso sulle implicazioni della IA: i rischi etici, sociali e politici che l’integrazione tra essa e l’umano comporta. Non sono certo casuali gli allarmi lanciati da alcuni creatori dell’Intelligenza Artificiale (si pensi a Geoffrey Hinton, noto come “il padre dell’IA”), e questioni come la privacy, la disuguaglianza digitale o il controllo algoritmico, fondamentali per il nostro futuro di individui liberi, sono qui appena accennate.
In conclusione, si ha tra le mani un libro stimolante, pensato con una prospettiva filosofica aperta, il cui maggior merito risiede nell’approccio dialogico, nella valorizzazione delle scienze cognitive e della collaborazione tra uomo e macchina. Tuttavia, ad esso andrebbero affiancate altre letture sull’argomento, affrontato da prospettive diverse – ad esempio, L’intelligenza artificiale. Una guida per esseri umani pensanti, di Melanie Mitchell. Ne varrebbe la pena: in ballo c’è il nostro futuro.