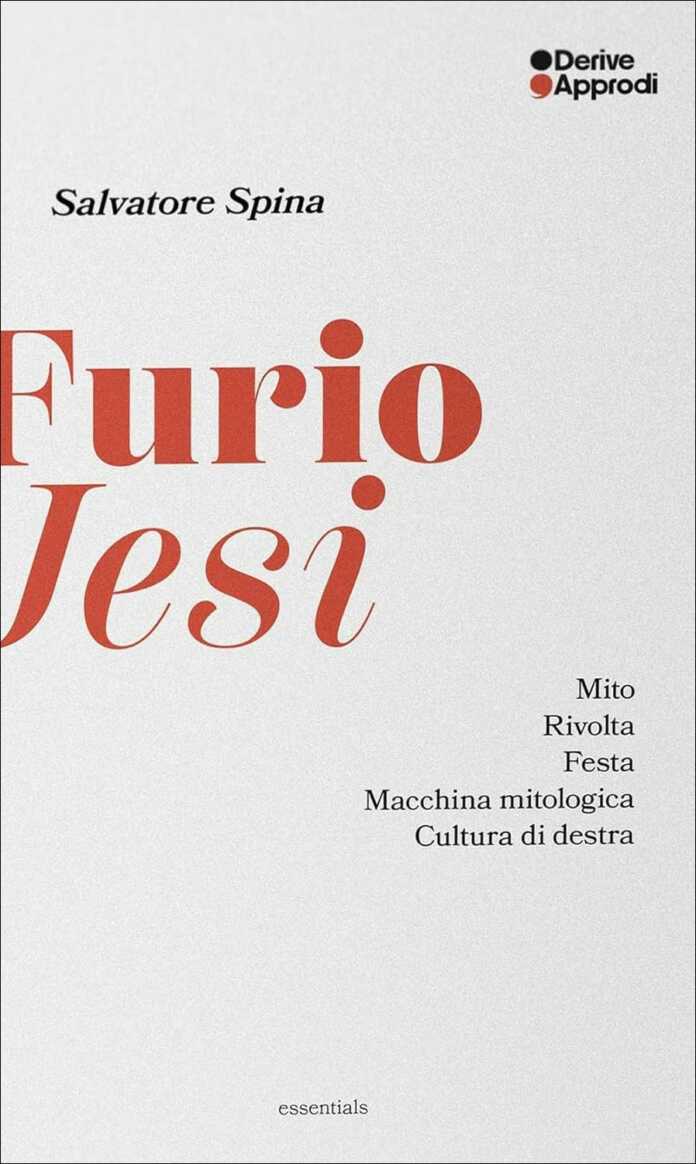La collana essentials dell’editore DeviveApprodi pratica con orgoglio un intento didattico offrendo brevi, sintetiche ma profonde letture di intellettuali, talvolta scomodi, avversati o maledetti, affidate a studiosi che hanno instaurato con loro un rapporto di conoscenza critica e appassionata. Ivan Illich, di cui il prossimo anno si celebrerà il centenario della nascita, Günther Anders, Carl Schmitt, Frantz Fanon, Antonio Negri, tanto per citare quelli più vicini ai miei interessi, ma anche altri fondamentali per questi nostri tempi, sono tagliati con l’accetta e declinati secondo la regola di affrontare “l’essenza di un pensiero in cinque concetti.” Richiamare la brutalità e la violenza dell’azione dell’accetta non è affatto una critica, ma una necessità di creare e difendere una cultura che ha l’obiettivo di eliminare e spingere nell’oblio le menti più radicali che hanno lavorato sulle contraddizioni e le viltà del contemporaneo, magari individuando quelle loro specificità che possono indirizzare ad altre più approfondite letture.
Furio Jesi, nei ragionamenti di Salvatore Spina attorno ai concetti di mito, rivolta, festa, macchina mitologica e cultura di destra, appare come uno studioso e un pensatore originale, provocatorio, incredibilmente anticipatore della nostra epoca caratterizzata da una madornale rivincita/riattualizzarsi del fascismo. Morto a soli 39 anni a Genova per avvelenamento accidentale da ossido di carbonio prodotto da una calderina difettosa, è comunque riuscito a costruire un percorso formidabile sulla natura e uso del mito che ne fa ancora oggi il maggiore studioso italiano sull’argomento. Senza essere né diplomato né laureato, ottiene la cattedra di Lingua e letteratura tedesca prima all’Università di Palermo e poi a quella di Genova, come riconoscimento dei suoi studi da autodidatta e dei molti saggi pubblicati destinati a essere pesanti macigni nella nostra cultura per il rigore e la lucidità che li contraddistingue.
Spina molto giustamente sottolinea il valore di Jesi nel contemporaneo, sia osservando l’incessante lavorio della macchina mitologica operata dal fascismo in Italia, in Europa e nel mondo, chiarendo il nesso che ha con il potere, sia per il richiamo all’ontologia dell’attualità di Michel Foucault, facendo luce sui fenomeni di risorgere dell’identità comunitaria associata alla discriminazione dei “diversi”. Il suo lavoro sul mito, di demitizzazione e di demistificazione, rappresenta un imprescindibile strumento per attaccare la cultura mondiale di destra e i suoi elementi di maggiore successo nella propaganda e nella fidelizzazione. Il suo rapporto con Károly Kerényi consente a Jesi di utilizzare inizialmente la categoria del “mito tecnicizzato” come degradazione del “mito genuino”, dove «il mito tecnicizzato, invece, è lo spazio artificiale, ricostruito in maniera faziosa, a partire da cui i materiali mitologici originari vengono manipolati e corrotti a scopi estrinseci dal mito stesso, al fine di conseguire determinati effetti politico-sociali».
Se Kerény riteneva possibile un accesso al mito genuino, per Jesi l’analisi della macchina mitologica lo porta ad allontanarsi dal suo maestro. Spina sottolinea come Jesi abbia inteso agganciare la lettura del mito alla storia e alle dinamiche di conquista e conservazione del potere a partire dall’analisi della società tedesca. Con Germania segreta. Miti nella cultura tedesca del ’900, Jesi documenta come il mito sia stato manipolato e corrotto per essere asservito ai progetti di potere che dalla Prussia Guglielmina arrivano fino al nazionalsocialismo, diventando strumento di barbarie e di istigazione alla violenza, lontano da ogni aspirazione di verità.
Se Jesi, e ora Spina con questo saggio, non hanno ritenuto di agganciare l’analisi a un saggio di enorme successo come Le origini culturali del Terzo Reich di George Mosse, che condivide con Germania segreta lo spazio storico, è forse perché l’innovazione di Jesi non risiede tanto nella ricostruzione della storia dell’ideologia conservatrice, ovvero marxianamente nell’edificazione di una ideologia come apparenza, ma mostrare i meccanismi di funzionamento del mito, che sono generali e non tipici della realtà tedesca. Si tratta infatti, e questa è forse la più palese contraddizione, di un mito che è né puro né immutabile, non ha nulla di metafisico, ma che nelle diverse epoche assume significati diversi che dipendono dalle necessità politiche e bastarde dei mitologi. Per Jesi, con un ragionamento quasi di logica quantistica, il mito, se c’è, è dentro la scatola della macchina mitologica, e non è neppure detto che ci sia, che esista, e la scatola non può essere scoperchiata, ma è reale e tangibile solo l’uso mondano che se ne fa. Viene da dire che solo il mito degradato esiste, senza un originale, strumento di barbarie come l’antisemitismo tedesco, in mano a mitologi nazisti, assieme a tutte le costruzioni identitarie. Sono miti, per Jesi, non necessariamente appartenenti alla classicità, ma peculiari anche della modernità, come dimostra la sua analisi di Spartakus. Simbologia della rivolta, dedicato all’insurrezione comunista berlinese del gennaio 1919.
L’excursus sui cinque concetti, su cui il tema della festa (altro tema classico della storiografia ufficiale) è l’occasione per una riflessione sulle concezioni spazio e tempo storiche, filosofiche, psicologiche e sociali, si conclude con il tema che l’ha reso noto al grande pubblico e personalmente odiato dagli intellettuali posticci della fascisteria italiana: la cultura di destra. Il saggio Cultura di destra era uscito nel 1979 per Garzanti, pochi mesi prima della sua morte, e rappresenta apertamente il suo impegno politico come critico marxista e studioso militante, ma è anche la componente della prassi dei suoi studi, un approccio analogo a quello che era stato alla base di Germania segreta per l’immaginario tedesco, incentrato su Julius Evola e la squallida storia della cultura fascista e della sua macchina mitologica. “Il mito della cultura di destra è sempre mito del potere”, scrive Spina, riferendosi ai modi in cui il fascismo ha imposto la sua “egemonia simbolica e politica”, e il mito è stato ed è solo un misero feticcio per diffondere l’ideologia della classe dominante e fornire un potente strumento di eccitazione per le masse (e in questo un collegamento a La psicologia di massa del fascismo di Wilhelm Reich offrirebbe molti spunti per supportare le tesi di Jesi).
Se il mito mostra realmente solo il suo carattere artificiale di narrazione riferita a origini che neppure esistono, e quindi è palese la sua funzione conservatrice, non per riacquistare le condizioni di una verità precedente eroica e divina, ma solo per mantenere i privilegi reali e le ricchezze della classe dirigente, ne segue che il lavoro del mitologo non tecnicizzato deve essere quello di smascherare il “carattere artificioso e fazioso di ogni racconto mitologico”, rifiutando “tutti i valori che si presentino come universali e immutabili”. Jesi propone di accettare la provvisorietà della cultura praticando una dialettica che ricorda quella del metodo scientifico (almeno nella misura di Karl Popper), di risultati parziali che si succedono falsificandosi e corroborandosi nel rapporto tra teoria, cultura e natura.