Legno, oro, petrolio: con questo suo libro di giornalismo investigativo incentrato sul racconto di gente ordinaria legata a diverso titolo a queste tre ricchezze ambientali del tuo paese, il Perù, sembra volersi opporre alla narrazione evenemenziale e invece dimostrare come la grande Storia sia fatta di tante piccole storie caleidoscopiche, tra di loro interconnesse: è così?
È proprio così. Quello che cerco di fare nelle mie cronache è mostrare come nelle storie piccole, minime, siano presenti questioni umane che sono universali e riguardano ognuno di noi. È il particolare che contiene l’universale. In questo modo, per esempio, la vita di una contadina che, nelle Ande, cerca di difendere la sua casa dallo sfruttamento minerario può essere connessa con un lettore che vive in città, a migliaia di chilometri da lei, perché tutti comprendiamo che significato ha la propria casa e che cosa saremmo capaci di fare per proteggere quello spazio che definisce chi siamo. Per questa ragione, mi piace pensare alla cronaca come uno specchio attraverso il quale possiamo vederci riflessi nelle storie degli altri.
Citiamo i personaggi del testo che rappresentano altrettante battaglie ambientaliste contro il capitalismo predatorio: Edwin Chota, che abbandona la vita cittadina e si trasferisce nella foresta amazzonica, diventando un leader indigeno e combattendo fino al suo omicidio il disboscamento illegale della comunità di Saweto; Máxima Acuña Atalaya, una contadina analfabeta delle Ande peruviane nelle regione di Cajamarca, che difende i suoi terreni ricchi d’oro dagli appetiti voraci e illegali della compagnia estrattiva Yanacocha; Osman Cunáchí, un ragazzino indigeno awajún della regione di Amazonas che ha ripescato nel fiume del suo villaggio Nazareth il petrolio fuoriuscito dagli oleodotti della compagnia estrattiva Petroperú, riempendo così il suo corpo di sostanze nocive.
Come ha scelto questi personaggi e perché proprio loro tra le tante voci della protesta ambientalista?
Ho scelto di raccontare le vite di queste persone perché sentivo che nelle loro storie c’era qualcosa che andava oltre il tema ambientale. Le loro storie di lotta chiamano in causa categorie universali come l’amore, la morte, l’ambizione, la rabbia, l’inquietudine… Mi interessava indagare le ragioni per le quali queste persone, pur avendo un intero sistema economico, sociale e politico schierato contro di loro, mettevano a rischio le loro vite per ciò che consideravano la loro casa, la loro comunità, la loro identità. Mi sono chiesto che cosa li motiva, quali sono i processi interiori che spingono a prendere determinate decisioni. Quella curiosità genuina nei confronti delle loro interiorità è stata la prima spinta a scrivere su di loro. In questo senso, mi piace parafrasare una frase dello scrittore peruviano Julio Ramón Ribeyro: quando scrivo una cronaca, in realtà, sto raccontando “la storia di una decisione umana”.
Durante la lettura mi ha colpito come a più riprese sottolinea, nei diversi contesti, lo sfruttamento dell’analfabetismo delle comunità indigene e l’impossibilità di reperimento di carte geografiche precise da parte loro: si può quindi sostenere che le ditte sfruttatrici delle ricchezze ambientali locali mettano in atto strumenti di dominio coloniale?
In Perù esiste un complesso di norme giuridiche che, in teoria, dovrebbero aiutare le comunità indigene nelle procedure necessarie, per esempio, a ottenere la proprietà legale delle loro terre. Il problema è che si tratta di procedure molto costose, complicate, e a volte sono le stesse autorità a rendere più lento il processo, per fare affari sottobanco e trarre profitto personale da quelle terre. Quindi le comunità, prive di risorse economiche e informazioni, si vedono impossibilitate a esercitare i loro diritti. Le grandi imprese, invece, che hanno sia le risorse che le relazioni giuste con chi governa, possono fare tutto più rapidamente. La loro capacità di esplorare territori potenzialmente sfruttabili è di gran lunga maggiore.
Dal libro emerge chiaramente il suo metodo di lavoro: conoscenza diretta dei protagonisti, quando possibile; conoscenza diretta dell’entourage dei protagonisti quando questi sono morti (come nel caso di Chota); lavoro sulle fonti d’archivio, storiche, giuridiche, giornalistiche; documentazione indiretta attraverso una poderosa bibliografia sull’argomento: manca qualcosa?
È esattamente come dice. Aggiungerei soltanto, oltre a tutta la documentazione, un lavoro molto personale per arrivare a definire quale è l’idea o la conoscenza che voglio trasmettere attraverso la storia che racconto. Qual è l’àmbito della condizione umana su cui voglio riflettere nel mio testo.
Nel libro cita nomi e cognomi di tutti gli interessi mafiosi che si muovono intorno al volume gigantesco d’affari connesso, mostrando come la corruzione si muova dal livello locale, anche dei capi indigeni, fino al livello politico nazionale e internazionale: non ha mai subito minacce a causa di questo suo coraggioso atto di denuncia?
Fortunatamente, finora non ho ricevuto né minacce né denunce. E dico fortunatamente perché altri colleghi, che vivono in quelle zone di conflitto, sono stati intimiditi. Però sì, confermo, è stato abbastanza rischioso accedere ai luoghi sui quali scrivevo, soprattutto in virtù della loro complessa geografia o per la presenza di poliziotti e militari.
Lo stile della narrazione è antiretorico e si attiene strettamente ai fatti, ma questo non le impedisce talvolta di aprire degli squarci lirici di grande intensità. Mi è venuto in mente, come suo possibile maestro, la lezione di Ryszard Kapuściński: è così? Ha altri debiti verso altre grandi penne del reportage internazionale?
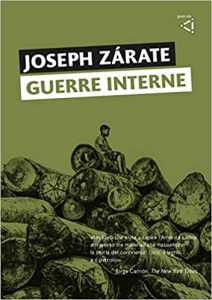 Oltre al maestro Kapuściński, alcuni autori che fanno parte della mia personale costellazione di riferimento nell’ambito della non-fiction sono Svetlana Aleksievic, Emanuele Carrère, Primo Levi, Martín Caparrós, Leila Guerriero, per citare solo alcuni nomi. Poi ci sono, naturalmente, i romanzieri del mio paese come Julio Ramón Ribeyro (soprattutto per i suoi diari) o Manuel Scorza, e poeti come José Watanabe, Jorge Pimentel ed Enrique Verastegui. Cito anche loro perché mentre scrivo leggo molta poesia: sento che è un’altra forma della non-fiction, che nominano una verità che è più interiore.
Oltre al maestro Kapuściński, alcuni autori che fanno parte della mia personale costellazione di riferimento nell’ambito della non-fiction sono Svetlana Aleksievic, Emanuele Carrère, Primo Levi, Martín Caparrós, Leila Guerriero, per citare solo alcuni nomi. Poi ci sono, naturalmente, i romanzieri del mio paese come Julio Ramón Ribeyro (soprattutto per i suoi diari) o Manuel Scorza, e poeti come José Watanabe, Jorge Pimentel ed Enrique Verastegui. Cito anche loro perché mentre scrivo leggo molta poesia: sento che è un’altra forma della non-fiction, che nominano una verità che è più interiore.
Nell’epilogo spiega la triplice stratificazione del titolo che ha scelto, Guerre interne: guerre interiori al tuo paese, che si svolgono spesso all’interno della terra dalla quale vengono ricavate le risorse naturali, ma specialmente una frattura universale, che attraversa ognuno di noi rispetto all’idea di progresso che pratica. Questa potente metafora è destinata a risolversi, secondo lei? Cioè, saremo mai in grado noi esseri umani di mettere in atto un progresso rispettoso dell’ambiente e dei diritti sociali connessi?
Per rispondere alla sua domanda, mi viene in mente una storia. Un paio di mesi fa ho pubblicato un articolo sul New York Times, su quello che sta accadendo adesso nella parte di Amazzonia che si trova in territorio peruviano. Nel corso della prima metà di quest’anno, mentre milioni di persone erano confinate nelle loro case, apparentemente protette dal virus, nella foresta peruviana si sono verificate 14 fuoriuscite di petrolio che hanno contaminato il fiume e i terreni di centinaia di famiglie indigene. Lo stesso petrolio che la popolazione delle città usa per le sue automobili, che l’industria petrolchimica usa per fabbricare i milioni di oggetti che compriamo nei centri commerciali o nei supermercati. Questo fatto, naturalmente, desta sorpresa e indignazione, perché vediamo come oltre alla mancanza di medicine e di assistenza medica, quelle nazioni indigene siano alla mercé di qualsiasi malattia. Ricordo che per scrivere l’articolo ho intervistato un leader kichwa che sorveglia il suo territorio per monitorare nuovi sversamenti. Gli ho chiesto se pensava che questa situazione sarebbe cambiata, un giorno, per lui e per il suo popolo. La sua risposta, in qualche modo, può anche valere da riposta alla domanda che mi fa. Il leader indigeno mi ha risposto: questa situazione cambierà quando la vita di un indigeno e la vita di un occidentale avranno lo stesso valore.
Sempre nell’epilogo spiega come questo testo rappresenti anche un recupero di una parte della sua identità, quella indigena, incarnata da sua nonna Mamita Lilí che riaccompagna nell’unico viaggio di ritorno dalla città in cui viveva a Pucallpa, la foresta della sua infanzia. Nella prima cronaca del testo sottolinea invece come Edwin Chota non fosse originariamente un indigeno, ma avesse scelto di diventarlo nel momento in cui abbracciò lo stile di vita degli indigeni e la loro lotta contro la deforestazione. Cosa sono per lei allora le radici? Come possono diventare un elemento arricchente dell’identità personale e non una rivendicazione sterile, all’insegna dei tanti populismi sulla scena mondiale?
Nel mio caso personale, ritengo che pensare e indagare sulle proprie radici sia importante perché fa parte del processo di autocoscienza che deve attraversare ogni essere umano. Capire e conoscere il luogo da cui proveniamo è di importanza vitale, perché all’origine, al cuore di tutto, c’è il nostro vincolo più puro con la natura, con l’ambiente in cui viviamo. Penso che indagando su quell’origine comprendiamo, in definitiva, che l’essere umano non è un’individualità, ma che invece fa parte di una rete, nella quale le decisioni che prendiamo hanno un impatto su altre vite. Vite come quelle dei popoli indigeni, che abitano le montagne e le foreste da cui si estraggono le risorse che sono alla base della nostra vita moderna e comoda nelle città.
Infine, noi lettori occidentali, nella fattispecie italiani, attraverso la lettura del suo libro apprendiamo tantissime cose nuove sul Perù e sulla sua storia, sulla forza e sulla dignità morale delle comunità indigene, sul coraggio delle lotte ambientaliste lì praticate: come possiamo da qui aiutarle e contribuire al loro successo?
Sì, i lettori europei possono aiutare, certo. Penso che la prima cosa sia mettere in discussione il concetto occidentale di progresso. La seconda è agire, ma non soltanto nel senso di riciclare o piantare alberi. Mi riferisco, più che altro, a un’azione di vigilanza politica. È importante rimanere vigili sulle decisioni dei nostri governi, sulle loro politiche, e protestare e reclamare se quelle politiche attentano alle comunità delle popolazioni più vulnerabili e, più in generale, al nostro habitat naturale.



