“Scrivere in sè non ha niente di bello, al contrario è una faccenda imbarazzante e dolorosa, vuol dire costringersi a dire cose che altri hanno già detto molto meglio.” L’analisi da epigono dell’albanese Arsim, protagonista del romanzo insieme al suo amante serbo Miloš, è uno dei momenti nei quali il trentunenne Pajtim Statovci ci rivela molto presto quale sia il grembo narrativo più fecondo per i figli della diaspora e del conflitto degli anni ’90 in Kosovo: quello del “genere”.
Ritrovatosi profugo in Finlandia con la sua famiglia alla tenera età di due anni, Statovci è cresciuto all’interno di quell’universo d’accoglienza che da noi mediterranei è grossolanamente definito come “il modello scandinavo”. Un mondo che nel romanzo viene omaggiato sottovoce in una delle pagine finali, quando l’ultimo padrone di casa di Arsim afferma con orgoglio di vivere “in un grande appartamento pagato dallo Stato molto vicino al centro di Stoccolma, dove i bambini frequentano buone scuole, studiano inglese, francese, tedesco, a loro scelta”. Statovci avrebbe quindi potuto emergere come giovane talento nel panorama europeo incardinando la sua scrittura nel solco delle contraddizioni infinite che separano le pianure dei merli dagli spazi architettonici di Alvar Aalto. Avrebbe potuto facilmente drammatizzare l’eterno filone comico legato al più dozzinale melting pot: quello che prevede lo scontro artificiale tra miseri stereotipi culturali – i nativi da una parte, i musulmani dall’altra – ciascuno con la propria gobba folkloristica da portare sulla schiena. Rifiutando queste comode caricature, Statovci sceglie di “costringersi” a flirtare con ciò che “è già stato detto molto meglio”: ovvero i generi letterari già consolidati nella storia. Sceglie di testarli, di esasperarli, di esaurirli stilisticamente per misurare l’odissea di due ragazzi universitari, amanti e divisi nel tempo delle feroci guerre nazionaliste che ebbero come epicentro i Balcani.
La città di Pristina, che fa da scenografia muta alle memorie epistolari di Miloš e al racconto in prima persona di Arsim, viene quindi abilmente trasfigurata in tutta la parte iniziale del romanzo: essa ci appare come una Vienna o una Londra caratteristica della letteratura omosessuale. Statovci guarda ai maestri apollinei (Wilde, Mann, Musil) e ne coglie le suggestioni, ma li ripulisce immediatamente da ogni classicismo o lirismo ridondante: li fonde, anzi li affonda, nella narrativa gay americana, quella fortemente dionisiaca che aveva sfidato il moralismo ipocrita del secondo dopoguerra – su tutti Truman Capote e Gore Vidal.
Proprio perchè in Kosovo quel “dopo” è ancora tremendamente legato alla “guerra” ed alla sua matrice etnocentrica – come dimostrano ampiamente le tensioni dei giorni nostri – la tematica omosessuale diventa quindi per Statovci un versatile strumento di denuncia, un bisturi affilato per incidere il corpo marcio del militarismo e del patriarcato. Equamente divisi tra i due protagonisti, questi cancri sociali si sviluppano in modo patologico lungo tutto l’intreccio.
Arsim l’albanese, costretto ad essere marito in una famiglia nucleare e poi anche emigrante prima del conflitto del 1998/’99, accompagna le proprie esperienze pasoliniane all’estero con un progressivo incremento del proprio maschilismo e della violenza sulla moglie. Arrestato per pedofilia, ritroverà il Kosovo nella forma di un rimpatrio forzato, successivo all’espulsione dalla Germania: e il Kosovo ritroverà lui nella forma delle macerie e dello sbandamento, delle speculazioni e dell’emarginazione. Miloš il serbo, invece, tenterà di essere coerente con il proprio percorso di studi, diventando medico militare durante le operazioni “antiterrorismo” dell’esercito serbo e soprattutto durante i successivi bombardamenti americani. A differenza di Arsim, Miloš conserverà nelle sue testimonianze la dimensione romantico-sentimentale (e il forte patetismo) degli approcci, attribuendosi l’aura di una nobiltà d’animo in apparenza non compromessa dalla divisa indossata.
Sarà purtroppo la realtà di Kosovska Mitrovica, la nefasta Berlino dei Balcani odierni, rigidamente suddivisa tra la parte settentrionale serba e quella meridionale albanese, a distruggere quel misto di candore e passione: il decadimento del serbo Miloš allo status di minoranza interna, dopo un decennio di autentica apartheid degli albanesi, segnerà la sua emarginazione e il suo progressivo internamento – proprio nei mesi del rientro in patria di Arsim, che cinicamente riuscirà a superare il vittimismo della sua disperazione dopo aver abbandonato a se stesso l’ex amante, ormai ridotto a un ectoplasma.
 Forse è proprio in quest’ultima parte che Statovci cade nella trappola che aveva tentato di tendere al lettore. Padroneggiando lo stile romanzesco delle corrispondenze omosessuali e costruendo un efficace meccanismo che alterna le versioni dei protagonisti con i loro carsici riferimenti letterari, l’autore ci fa credere fino alle ultime pagine di poter condurre a termine il lavoro in modo sadico, quanto realistico, privandoci di un happy end cinematografico. Invece alla fine cede.
Forse è proprio in quest’ultima parte che Statovci cade nella trappola che aveva tentato di tendere al lettore. Padroneggiando lo stile romanzesco delle corrispondenze omosessuali e costruendo un efficace meccanismo che alterna le versioni dei protagonisti con i loro carsici riferimenti letterari, l’autore ci fa credere fino alle ultime pagine di poter condurre a termine il lavoro in modo sadico, quanto realistico, privandoci di un happy end cinematografico. Invece alla fine cede.
Il riscatto conclusivo di Arsim, così rapido nella sua ascesa trionfale, quanto artificioso e frettoloso nella stesura, è certamente il dazio ingenuo che un autore eclettico come Statovci deve pagare alla legge morale e all’idea di letteratura come catarsi.
“Se gli faccio capire che leggo solo libri che hanno cambiato il mondo, libri che leggendoli possono educarti e farti apprendere qualcosa di importante, magari si mostrerà più comprensivo con me, vedrà in me qualcosa di più che un delinquente”, pensa il detenuto Arsim, mentre nella prigione tedesca tenta di accattivarsi le simpatie intellettuali di un secondino. Ed è questa, probabilmente, la riflessione nascosta che lo scrittore consegna al suo lettore, rimandando per un istante il cambiamento del mondo per concentrarsi sull’aspetto educativo delle dinamiche affettive solitamente discriminate e represse. Quelle verso le quali le tragedie storiche non possono fare da semplice sfondo per troppo tempo.
Pajtim Statovci / L’amore ai tempi del Kosovo
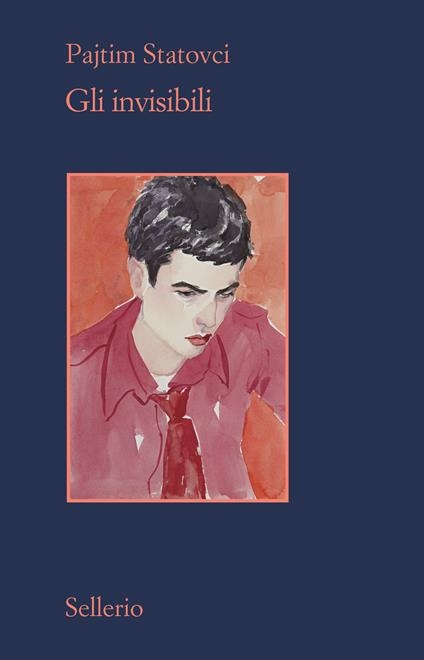
Pajtim Statovci, Gli invisibili, tr. Nicola Rainò, Sellerio, pp. 223, euro 16,00 stampa, euro 9,99 epub



