Covid-19 suonava nei primi giorni come uno dei tanti virus contenuti nei film di fantascienza, come era stato in The Andromeda Strain, la pellicola di Robert Wise del 1971, che adattava l’omonimo romanzo di Michael Crichton pubblicato due anni prima. E ancora, immagini di telegiornali cinesi e lombardi evocavano la serie TV inglese I sopravvissuti (tre stagioni dal 1975 al 1977) che immaginava un mondo futuro in cui un virus altamente letale aveva compiuto il giro del pianeta riducendo la popolazione umana a meno dell’uno per mille. Ma forse quello che risuona in una parte più nascosta del nostro cervello, quella che si attivava nei personaggi dei primi romanzi di James G. Ballard, sono state le sequenze del film La città verrà distrutta all’alba, del 1973, e intitolato The Crazies. Da subito è scontro irragionevole con il potere, lotta per la sopravvivenza, indecisione tra seguire le regole o trasgredirle, assottigliare a un gruppo umano sempre più piccolo il legame di solidarietà e protezione reciproca. E dietro a una biologia impazzita, i dubbi sulla verità, i piani del potere, l’idea di una disciplina destinata a perdurare oltre i limiti dell’epidemia. La lezione di Michel Foucault sulla meravigliosa opportunità che le pestilenze avevano offerto alle municipalità francesi, per meglio organizzare e controllare le società (istituendo orari, confini, controlli), non è complottismo ma marxiana verità. Questa verità applicata ancora oggi, e che Foucault declinava per la sua e per le epoche successive, ci fa fantascientificamente intuire che, passata l’emergenza biologica, una nuova guerra economica cercherà nuove forme di profitto e sfruttamento, trovandole come assolutamente peculiari di un post-epidemia.
La fantascienza sociale, creatura insofferente della Guerra fredda, ha messo in primo piano, più che prevederne il futuro, la fragilità del mondo civilizzato e della sua insolente razza umana, la precarietà del progresso, il riconsolidarsi aggressivo dell’ingiustizia sociale e delle superstizioni. Se miliardi di persone vedono riconfigurarsi la propria libertà e la collocazione sociale, devono fronteggiare la precarietà e il trasfigurarsi delle aspettative, da un giorno all’altro e senza esperienza. Di fronte a un’emergenza globale che si affianca alle molte altre in atto, che sembra sfidare con più violenza la tanto decantata capacità di controllo occidentale, per una volta ci chiediamo cosa è successo in ognuno di noi durante questi giorni. È stato possibile vivere chiusi in casa come se niente stesse accadendo altrove? E noi, i lettori per eccellenza, per caso abbiamo anche solo sognato di vivere una situazione come quella descritta dal telefilm Tempo di leggere, o meglio Time enough at Last, l’episodio della prima stagione della serie TV Ai confini della realtà, in cui il protagonista appassionato lettore si ritrova unico sopravvissuto, ma con la consolazione della biblioteca pubblica finalmente a sua totale disposizione? Sì, il finale è beffardo, ma quanti, ridotta la vita sociale dall’epidemia, si sono avvicinati alla lettura, quanti se ne sono allontanati?
In realtà alcuni segnali indicano addirittura una minore pratica della lettura per i lettori più sistematici e un piccolo ritorno per quelli occasionali. Per i primi la riorganizzazione della vita professionale, come le lezioni on line degli insegnanti, hanno imposto un maggiore impegno nel lavoro e la necessità di affrontare nuove e diverse stanchezze; per gli altri è forse stata una reazione a una nuova e inquietante solitudine.
L’idea maliziosa è che il tempo del Covid-19 sia stato più adatto alla forma del racconto, quasi che la sua brevità meglio si adattasse alla nuova forma della vita che ha drasticamente diviso in due le città, tra chiusi in casa in un rilancio della “convivenza familiare” e lavoratori essenziali, più esposti alle epidemie, precettati ad attraversare i nuovi vuoti urbani. Quasi che si stesse cercando inconsapevolmente una rapida conclusione, senza rimandare a un futuro molto prossimo (soltanto pochi giorni dopo) l’epilogo della lettura. Molti editori e autori hanno regalato racconti da scaricare, affiancandosi a nuove collane commerciali destinate alla narrativa breve da leggersi su pc ed e-reader, offrendo percorsi nuovi tra autori diversi.
Domenico Gallo

Frederick Treves, L’uomo elefante, tr. Matteo Codignola, Adelphi, Microgrammi 10, pp. 32, euro 1,99 epub
In tempi di quarantena anche Adelphi vara un’agile collana in ebook, scaricabile a prezzo modico e leggibile in poche ore: Microgrammi. Il catalogo, già ricco di una quindicina di brevi testi inediti che spaziano da Shirley Jackson a Ennio Flaiano, da Robert L. Stevenson a Georges Simenon, è appetitoso e multiforme. Scelgo, come prima esplorazione, non un classico della letteratura ma una curiosità resa famosa dal cinema. Si tratta del memoriale che il dottor Frederick Treves pubblicò nel 1923, molti decenni dopo i fatti narrati risalenti al 1884, su uno dei casi clinici e umani più singolari e commoventi da lui affrontati, quello di Joseph Carey Merrick, meglio noto come l’Uomo elefante.
La memoria corre subito al secondo film, nel 1980, di un ancor giovane David Lynch, ai sussurri e ai gesti indimenticabili dell’attore John Hurt sotto la maschera terribile e straordinaria, al saggio Freaks (1978; Il Saggiatore, 2009) di Leslie Fiedler e alle fotografie perturbanti in esso contenute, a David Bowie che – al naturale, senza alcun trucco e contando solo sulla voce e la mimica – portò Merrick sui palcoscenici di Broadway, a tutto l’immaginario potente generato dal personaggio, eponimo – a fianco di Jack The Ripper, Sherlock Holmes, Dracula, il Dottor Jekyll, nella League of Extraordinary Gentlemen – della Londra vittoriana. Tutto nasce da questo esile libretto, scritto in modo banalmente cronachistico e del tutto privo di artifici letterari.
Non s’immagini una relazione scientifica o un trattato di terapia clinica come i testi di Jean Itard su Victor dell’Aveyron – altro paziente estremo iconizzato in un grande film, Il ragazzo selvaggio (1970) di François Truffaut – quanto uno scarno soggetto/trattamento da cui gli sceneggiatori di Lynch non avessero che da drammatizzare i personaggi, ricomporre la disposizio delle sequenze narrative e metaforizzare poeticamente le situazioni descritte, per ritrovarsi già pronto un fenomenale blockbuster. E così faranno infatti.
Il film prodotto da Mel Brooks e da lui consegnato alla deriva visionaria di Lynch – di cui aveva apprezzato il film d’esordio, l’abbagliante Eraserhead (1977) – è assolutamente fedele al testo di Treves, fin nei minimi dettagli. L’ordine degli episodi, evocati quasi a casaccio dal buon medico, solo seguendo il filo dei suoi ricordi, viene ovviamente sconvolto e riorganizzato secondo una progressione drammatica, una tensione scenica, uno scioglimento catartico, ma situazioni e personaggi sono già lì, pronti ad essere presi e resi immortali. Il racconto cinematografico aggrega e accresce conflitti solo accennati nel testo originale, inserendo sottotrame, esplicitando figure e figuri sottintesi: l’odioso sfruttatore del freakshow – in Treves solo un fantasma senza volto; la caposala burbera ma dal cuore d’oro; l’infermierina prima terrorizzata poi solidale; la bella attrice che rivelerà “Romeo” nel “mostro”; la moglie del dottore divisa fra commozione e turbamento di fronte all’insolito ospite.
Qualcosa che non c’era viene aggiunto, come il portantino che sfrutta la situazione nell’ospedale; poi il rapimento e la fuga di Merrick e i dubbi morali di Treves. E qualcosa che c’era viene tolto, come la breve ma complicata vacanza residenziale dell’Uomo elefante in un cottage di campagna. Ma tutti i fatti essenziali e tutta la sostanza psicologica del personaggio restano inalterati passando da un linguaggio all’altro: lo shock visivo devastante; la comprensione e la solidarietà che svelano una creatura gentile, intelligente, ingenua, mai corrotta dalle miserie vissute; i sogni, le fantasie, i vaghi ricordi di una madre bellissima e l’impossibilità di dormire “come gli altri” che lo porterà alla morte. Le metafore sono tutte già presenti in potenza nelle scarne pagine di Treves, le sontuose immagini di Lynch non hanno che da rivelarle e amplificarle aggiungendo poesia, commozione, orrore.
Anche il nome del protagonista resta esattamente lo stesso: Merrick, che in realtà si chiamava Joseph, nel film viene chiamato John, ma non c’è stato alcun inspiegabile cambiamento. Anche il dottor Treves nel suo testo chiama sempre John l’Uomo elefante, forse per errore, forse perché quel nome veniva usato dagli amici, questo possiamo solo ipotizzarlo, ma non è stato certo un arbitrio degli sceneggiatori.
In conclusione anche la sobria relazione del dottor Frederick Treves merita un posto d’onore fra i testi che così tanto e così profondamente hanno contribuito a nutrire il nostro immaginario: a suo modo un classico, dunque.
 Ennio Flaiano, Aethiopia. Appunti per una canzonetta, Adelphi, Microgrammi 14, pp.38, euro 1,99 epub
Ennio Flaiano, Aethiopia. Appunti per una canzonetta, Adelphi, Microgrammi 14, pp.38, euro 1,99 epub
Il venticinquenne Ennio Flaiano partecipa nell’ottobre del 1935, come sottotenente del genio, alla campagna d’Etiopia. Fino al maggio del 1936 commenterà l’avventura, con annotazioni neppure troppo frequenti e regolari, molte senza data, nel diario – pubblicato per la prima volta sul periodico Mondo subito dopo la morte dello scrittore.
Poche pagine ma già forti di quello stile aforistico dal sarcasmo fulminante, essenziale, lapidario che renderà celebre il futuro scrittore e sceneggiatore cinematografico. Tutt’altro che un testo immaturo o d’occasione, questi Appunti per una canzonetta – il sottotitolo è già un’esplicita presa di posizione riguardo all’Impresa e all’Impero – costituiscono ben più che un prezioso avantesto sulla base del quale Flaiano potrà costruire, circa dieci anni dopo, il suo esordio letterario, l’unico romanzo della sua carriera di autore: Tempo di uccidere – che Adelphi si appresta a ristampare – Premio Strega nel 1947, e unica opera del nostro Dopoguerra che abbia avuto il coraggio di evocare senza reticenze un capitolo sempre rimosso nel catalogo di memorie degli “italiani brava gente”: il colonialismo e il suo episodio più tardivo e più vergognoso.
Non un documento bellico né un preteso tranche de vie, piuttosto una metafora, Tempo di uccidere attingerà profondamente alle osservazioni tragiche e insieme ridicole consegnate a questo diario giovanile, fin dall’enunciato della sua prima pagina: “Alla base di ogni espansione, il desiderio sessuale”. Qui le descrizioni ironiche di ufficiali, ascari e soldati “che protestano cantando o peggio tacendo”, si fanno affettuose e piene di pietas per gli abissini, accostati per grazia a certe figure di Giotto, soprattutto i bambini indigeni, privi di tutto tranne che di altruismo e gentilezza, ma si alternano a immagini raggelanti come l’asciutto resoconto della rappresaglia per il massacro del Cantiere Gondrand di Mai Lalha (in cui un ingegnere italiano e sua moglie vennero torturati e uccisi): “Le donne e gli uomini asserragliati nella chiesa sono trucidati. Una donna, la più avvenente, viene posseduta in circolo e poi nel suo sesso è introdotto un tizzone: un tizzone che era servito per bruciare il cachì copto. Poi la chiesa viene sgombrata dai cadaveri. Si decide di bruciarli”.
Analogo registro, in perenne equilibrio fra il lieve, il disincantato e l’atroce, intonerà le pagine di Tempo di uccidere. Nelle vicende paradossali di un insipido ufficiale che violenta e uccide una giovane e bella indigena occultandone il cadavere e cancellando in sé ogni rimorso dietro assurde giustificazioni (la ragazza era consenziente, il colpo è partito per errore), Flaiano rappresenta l’Africa stuprata e svenduta e la cattiva coscienza della più inadeguata e arlecchinesca delle potenze coloniali: l’Italietta di Francesco Crispi e Giovanni Giolitti prima, di Benito Mussolini poi. L’ufficiale, come la sua patria, è un inetto: uccide per paura; per paura si abbandona all’ossessione di aver contratto la lebbra dalla sua vittima. Così la paura di dover scontare le conseguenze delle azioni compiute innesca una catena di tentati omicidi, mai portati a termine per semplice maldestrezza; e solo per paura il colpevole si costituirà alla fine, scoprendo che nessuno si era mai accorto di nulla e che pertanto lui è innocente (non perché sia davvero innocente, ma perché nessuno si è accorto di nulla): “Il prossimo è troppo occupato coi propri delitti per accorgersi dei nostri”. Potrà così tornare indisturbato in patria, dalla moglie che lo aspetta fedele e ignara e autoassolversi dimenticando ogni fallo. Mondato dall’immaginaria lebbra, nello splendido finale, non resta su di lui che un vago odore: “un fiato velenoso. Affrettai il passo, ma la scia di quel fetore mi precedeva”.
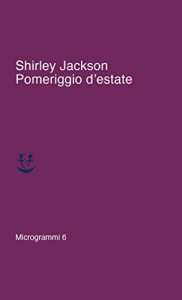 Shirley Jackson, Pomeriggio d’estate, tr. Simona Vinci, Adelphi, Microgrammi 6, pp. 28, euro 1,99 epub
Shirley Jackson, Pomeriggio d’estate, tr. Simona Vinci, Adelphi, Microgrammi 6, pp. 28, euro 1,99 epub
Adelphi ha per il momento centellinato assai parcamente la narrativa breve di Shirley Jackson (sulla scrittrice non ci dilunghiamo qui ma rimandiamo al nostro Primo piano su di lei). L’editore milanese ha già pubblicato – se si escludono i romanzi (finora tre fra i principali: Lizzie; L’incubo di Hill House e Abbiamo sempre vissuto nel castello) – solo un’edizione “mordi e fuggi” di La lotteria, ridotta a 4 racconti dei 25 presenti nell’originale; il volumetto La ragazza scomparsa, tre racconti in tutto; e il volume miscellaneo di narrativa e saggistica Paranoia, con solo 4 racconti dei 30 presenti in Let Me Tell You, raccolta postuma da cui prende origine. Ora consegna alla minicollana solo digitale Microgrammi, altri due racconti inediti anticipando che sono l’avanguardia di un prossimo volume in uscita entro la fine dell’anno, che si intitolerà La luna di miele della signora Smith e che ci auguriamo renda onore alla scrittrice statunitense con un numero finalmente congruo delle sue magistrali short-stories.
Analogamente un po’ dispiace e un po’ ci irrita lo “strillo” redazionale che presenta i testi come “Due racconti fin qui inediti di una maestra del terrore”. Ridurre Shirley Jackson a “una maestra del terrore” appare, per chiunque abbia letto un suo testo qualsiasi, decisamente semplicistico e fuorviante. Non che ci sia niente di intrinsecamente squalificante nella nobile tradizione letteraria del gothic, del weird and eerie, della ghost-story, del dark-fantasy o che dir si voglia, tutt’altro; né che sia del tutto sbagliato collocare Jackson in prossimità di questi territori narrativi, almeno considerando le influenze dirette su certi suoi conclamati discepoli pulp – ma, ricordiamolo, pulp Shirley non lo fu mai, associata piuttosto alla stampa patinata del New Yorker e simili: una coscienza di classe che vale in entrambe le direzioni – come i quasi coetanei Ray Bradbury e Richard Matheson, fino alla generazione successiva di Stephen King. Molto semplicemente il registro narrativo di Jackson, e lo dimostrano in pieno i due racconti di questa micro-raccolta stessa, pur ricorrendo al perturbante, al fantastico, al bizzarro, all’angoscioso, all’ambiguo, al grottesco, esula completamente dal terrore. È invece l’ironia il tratto caratteristico della scrittrice, ironia spesso amara, in qualche caso cupa. Il maestro di tutti, Edgar Allan Poe, resta uno scrittore del terrore anche nei suoi racconti pretesi comici o satirici; Shirley Jackson al contrario resta umoristica, ironica, talvolta sarcastica, anche quando si avvicina al terrore (senza mai eccedere il frisson d’inquietudine).
In più, e cosa molto più importante, Shirley Jackson è una scrittrice, una donna: forse la donna-scrittrice per antonomasia. Mai il disagio della condizione femminile è deflagrato in modo così potente, commovente e devastante, come nella sua intera opera di “maestra del terrore”: una denuncia sommessa, misurata, ellittica e per questo ancora più implacabile; non gravata dai didascalismi della retorica femminista, dalle volgarità pansessualiste, o dalle velleità militanti di tante presunte suffragette letterarie successive. Forse più che “maestra del terrore”, Shirley avrebbe meritato l’appellativo di “maestra della letteratura al femminile”.
Anche i due racconti di cui si compone il breve ebook sono la riprova di quanto appena detto. Il primo, “Invito a cena”, in originale “Dinner for a Gentleman”, perde in traduzione, omettendo il gentleman, una sfumatura significativa. Si tratta infatti di una sorta di fiaba epigrammatica nel registro leggero e comico-sarcastico di Shirley, una variante sul tema di Cenerentola: una ragazza non esattamente esperta di cucina invita a cena per sfida il saccente e arrogante collega “bellissimo, in quel modo virile che funziona perfettamente nei film, ma diventa atroce se uno come lui lo incontri tutti i giorni in ufficio. Fa sembrare tutti gli altri uomini pallidi e trasandati. Ha una bella abbronzatura artificiale, gioca a golf, mangia con appetito e, soprattutto, adora indossare un ridicolo grembiule e mettersi ai fornelli per dimostrare alle donne com’è che si cucina”. Del tutto incapace di realizzare i suoi propositi e già rassegnata all’inevitabile sconfitta sarà salvata in extremis dall’intervento quasi fantomatico di una misteriosa vecchietta – la fata non dichiarata ma ugualmente taumaturgica – che risolverà la situazione e doterà di un libro di cucina piuttosto particolare l’ormai avveduta fanciulla: l’uso finale non esattamente canonico di un’impeccabile torta al limone, così faticosamente conquistata, segna la vittoria dei poteri femminili, naturali e preternaturali, contro la spocchiosa insipienza del falso gentleman.
Il secondo racconto, “Pomeriggio d’estate”, rientra invece nel canone non certo del terrore ma dell’inquietante. Partecipiamo ai giochi di due bambine in età prescolare che, esaurito il repertorio degli abituali passatempi in giardino, si avventurano intorno all’isolato – attente a non attraversare mai la strada – per invitare Tippie, la piccola coetanea che fa sempre loro ciao alla finestra di una casa del vicinato e che non scende mai giù (la chiamano Tippie proprio da tip, punta, perché si mostra sempre solo a mezzo busto, dietro il vetro della finestra della sua camera). Per i bambini così piccoli non c’è un confine netto tra realtà e fantasia, tra amico immaginario e fantasma, ciò che dice la mamma ignora l’evidenza. Un semplice capolavoro d’atmosfera costruito sugli accenni e sulle sfumature.
Due racconti sono solo un assaggio. Restiamo in attesa di piatti più sostanziosi nell’immediato futuro.
Walter Catalano



