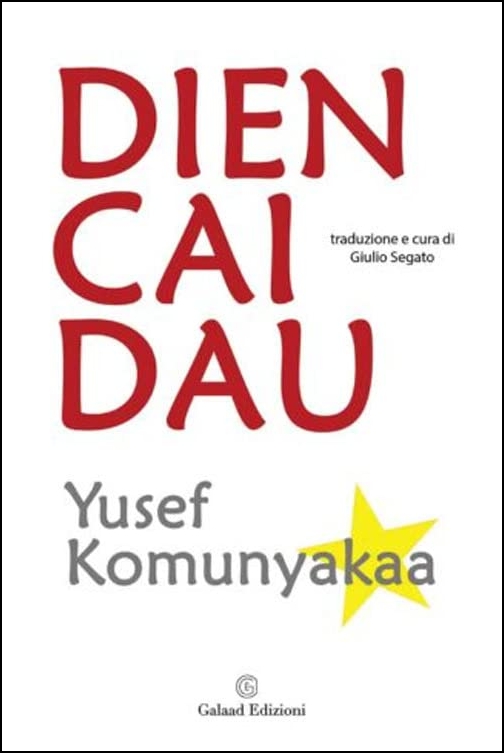Chiunque abbia dimestichezza con la storia e la cultura degli Stati Uniti può inquadrare con una certa facilità le vicende della comunità afroamericana nei vari conflitti che hanno visto coinvolto il Paese nel corso del ventesimo secolo. Come ha dichiarato, fra i tanti, Spike Lee all’indomani dell’uscita del suo film Da 5 Bloods – Come fratelli (2020), che ruota attorno alle storie di quattro veterani afroamericani della guerra in Vietnam, “i soldati neri hanno combattuto per il Paese sin dal primo giorno”. Eppure, tale presenza costante non è stata mai riconosciuta, venendo silenziata e oppressa non solo dal razzismo strutturale che ancora marca pesantemente la storia e la società degli USA, ma anche da altri fenomeni di reducismo, all’interno di una continua guerra tra poveri, o impoveriti. Basti, appunto, ricordare Travis Bickle in Taxi Driver di Scorsese per farsi un’idea, seppur embrionale.
È in questo contesto, delineato con estrema semplificazione, che si inserisce Dien Cai Dau del poeta afroamericano Yusef Komunyakaa, premio Pulitzer per la poesia nel 1994 e finora poco tradotto in italiano, se non per la meritevole opera di Antonella Francini (in varie sedi e poi nel volume Totem, tradotto per Le Lettere nel 2006). Tuttavia, come ricorda nella postfazione del presente volume Giulio Segato, autore di un’agile e intelligente curatela e traduzione, “mentre molti scrittori afroamericani come Amiri Baraka – che peraltro non è mai stato in Vietnam durante il conflitto – affrontano il coinvolgimento degli afroamericani in Indocina con toni militanti e spesso giustificano la violenza come mezzo per porre fine all’oppressione, la poesia di Komunyakaa resiste a questo paradigma e alla necessità che le parole agiscano come fists and daggers (pugni e pugnali). È vero che le poesie belliche di Komunyakaa assumono spesso il punto di vista di un soldato afroamericano (in qualche caso anche vietnamita), ma la visione non è mai ideologica né prettamente politica. Quello che cerca di fare il poeta è giustapporre immagini e suoni che, con la loro forza evocativa, offrano al lettore un nuovo spazio di riflessione anche sulle questioni razziali”.
 Non è una ritirata, ma una professione di coerenza per un autore che, ad esempio, si è sempre interessato alle commistioni della scrittura poetica con la musica jazz. È una mossa che apre anche uno spazio congeniale all’instaurazione di un’autentica dialettica, nella quale può emergere un senso tragico di empatia che non sminuisce, anzi rafforza la connessione tra le diverse oppressioni (afroamericana e vietnamita, in primo luogo). In tale dialettica, si riscontra poi quella possibilità di un percorso di autocoscienza che, da un lato, ripropone in molte poesie il punto di vista di un soldato dell’esercito americano – facendone apprezzare la peculiarità dello sguardo, nel bene e nel male –, e dall’altro fa emergere lo sguardo vietnamita sul Paese invasore: Dien Cai Dau, come recita il titolo, riprende, in fondo, l’appellativo – traducibile con “pazzo, fuori di testa” – dato dai vietnamiti agli americani.
Non è una ritirata, ma una professione di coerenza per un autore che, ad esempio, si è sempre interessato alle commistioni della scrittura poetica con la musica jazz. È una mossa che apre anche uno spazio congeniale all’instaurazione di un’autentica dialettica, nella quale può emergere un senso tragico di empatia che non sminuisce, anzi rafforza la connessione tra le diverse oppressioni (afroamericana e vietnamita, in primo luogo). In tale dialettica, si riscontra poi quella possibilità di un percorso di autocoscienza che, da un lato, ripropone in molte poesie il punto di vista di un soldato dell’esercito americano – facendone apprezzare la peculiarità dello sguardo, nel bene e nel male –, e dall’altro fa emergere lo sguardo vietnamita sul Paese invasore: Dien Cai Dau, come recita il titolo, riprende, in fondo, l’appellativo – traducibile con “pazzo, fuori di testa” – dato dai vietnamiti agli americani.
Un testo che può essere preso a paradigma di questa breve analisi, che peraltro non pretende di essere esaustiva, è Vedere al buio: le immagini con le quali si apre (“Il suono stridulo di film / porno scava sempre più a fondo, / come il fuoco di un mortaio tinge la notte / del colore della carne.”) trovano un capovolgimento tragico – con un coinvolgimento in prima persona che getta le basi per l’autocoscienza, senza imporla in modo ideologico – in chiusura (“L’immagine trema; il proiettore / si spegne, e malediciamo il buio / e il respiro pesante delle cicale”). Anche per questo testo, in fondo, vale quello che Segato annota per la poesia immediatamente successiva, e cioè “il cortocircuito innescato tra guerra e spettacolo, nonché il modo in cui il consumo sessuale vi si interseca in una sorta di parossismo simbolico”.
D’altra parte, “siamo uomini pronti a fonderci / con immagini fantasma” si legge a metà del testo, nel momento del negativo (oppure “abbiamo tutti i nostri fantasmi”, come recita un verso di Un altro morto da contare), e ciò riguarda anche la storia afroamericana dopo le atrocità, inflitte e subite, della guerra in Vietnam. È questo proposito, ribadendo l’esistenza di un immaginario al tempo stesso condiviso e conflittuale, che Segato può concludere: “è così che matura la consapevolezza del fatto che ‘we’re all somehow connected’, anche se proprio presso questo approdo spunta nuovamente la sensazione che le parole siano destinate a vacillare: ‘What would I have said?’. L’interrogatorio più pressante […] non è tanto quello dei vietcong o di un pubblico generale, bensì quello interiore, a voice within”.
La voce dentro, o meglio ancora le voci dentro: non è un caso che i vietnamiti parlassero di “pazzi” e di “fuori di testa”, e non solo per stigmatizzare il nemico, ma prevedendo, forse, le ferite che il nemico, e le sue varie identità, si sarebbero portati dentro ancora per molto tempo.